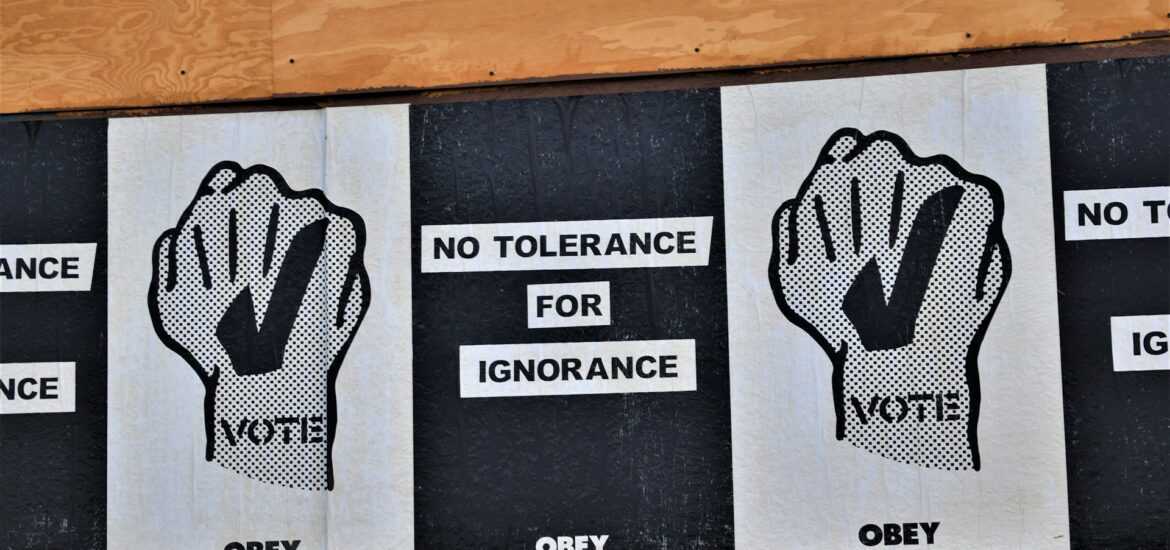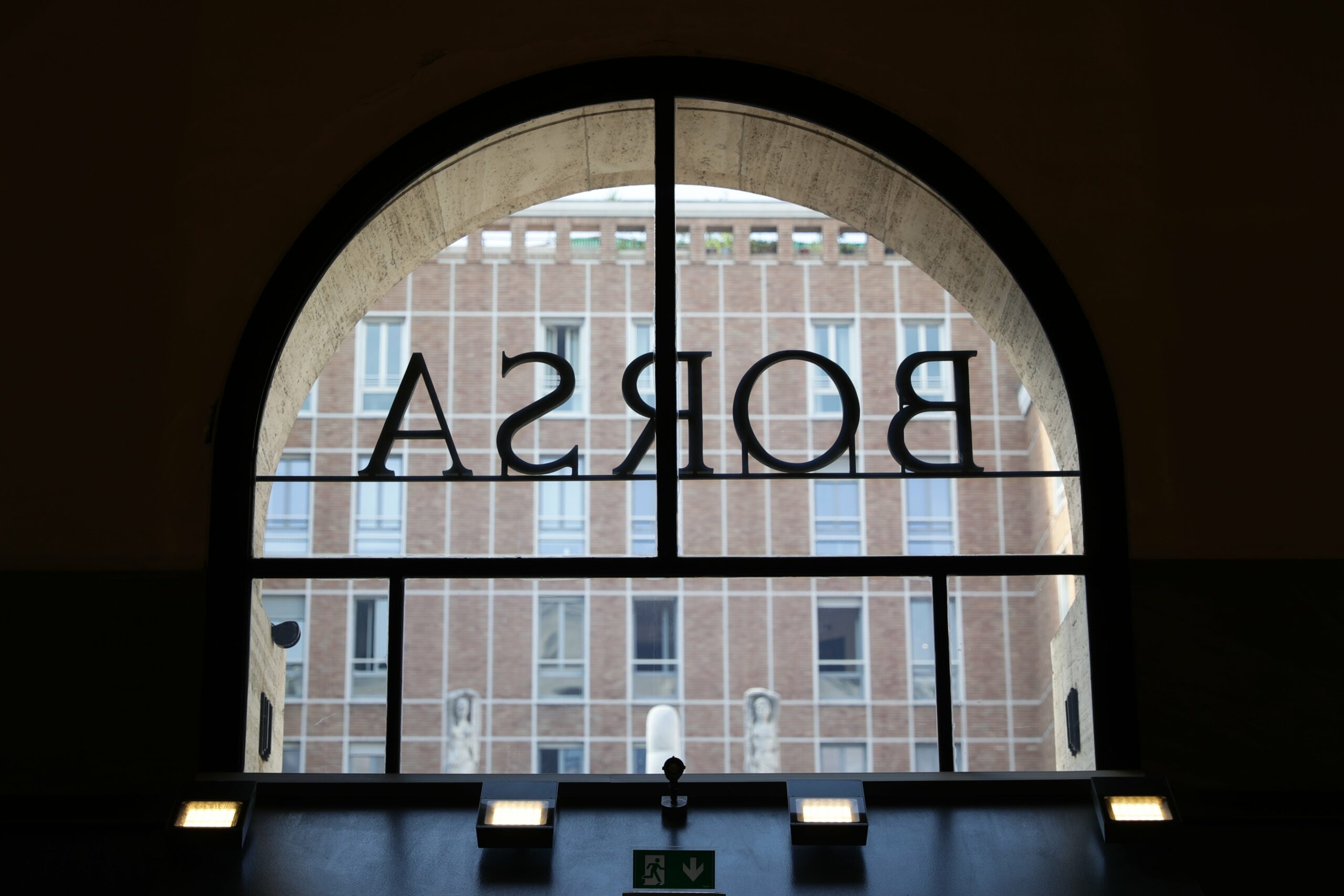Giorgia Meloni ha pronunciato di recente alcune affermazioni che rafforzano la sua posizione antintellettualistica, diciamo così, in particolare relativamente al rispetto dovuto alle persone che non hanno potuto studiare e che non devono essere per questo considerate socialmente inferiori. Si tratta di una conferma dell’immagine che il presidente del Consiglio vuole dare di sé come underdog, borgatara e pesciarola, espressioni che le vengono attribuite e che lei rivendica con orgoglio.
Qualcuno vede però nella rivendicazione anche tracce della convinzione ideologica della destra che si riassume in genere nella famigerata battuta “appena sento la parola intellettuali metto mano alla fondina”: cioè l’ostilità tra conservatori e reazionari da un lato e intellettuali engagé, organici, maitre-à-penser dall’altro, una diatriba fondata su elementi reali e uno degli elementi per cui le sinistre non riescono ad avere più appeal popolare. I progressisti si sono serviti troppo a lungo della categoria colta come avanguardia e adesso che questa è entrata in crisi ne pagano lo scotto.
Nell’ultimo caso, però, Meloni ha parlato di un aspetto specifico, quello dello studio, che dovrebbe essere sempre esaltato come molla di crescita personale e come ascensore sociale, senza distinzioni ideologiche o politiche. Ma qui sta l’altro aspetto critico: l’istruzione – inclusa quella universitaria che, come sappiamo, in Italia raggiunge percentuali di popolazione scarse – non svolge più questa funzione di ascensore, ormai sono altre le strade attraverso le quali si può assurgere alle vette dei redditi e della posizione pubblica. Chi insegna sa bene che la qualità formativa è proporzionata soprattutto a ciò che le famiglie riescono a fornire indipendentemente dai percorsi di studio regolari e l’università risente sia di questa crisi sia della difficoltà cui fa riferimento Meloni, di far accedere in modo equo ai livelli avanzati anche persone che non possono permettersi di pagare le migliaia di euro che 20 anni di studio comportano, direttamente e indirettamente.
Merita sempre di ricordare che una persona di sinistra ma indipendente come Fausto Bertinotti ebbe il coraggio di affermare che la soluzione migliore a questo problema sarebbe avere rette alte e sconti per i meritevoli bisognosi, non un’università tendenzialmente di basso costo che però scarica gli oneri sulla parte meno abbiente in modo indifferenziato, per permettere di fatto soltanto a coloro che arrivano da classi più elevate di proseguire. Nell’attuale sistema è un po’ come se i poveri pagassero gli studi dei ricchi, i quali poi, di fronte al calo inevitabile della qualità dell’offerta, scelgono strade privatistiche, onerose ma più efficaci almeno come job placement.
Si tratta comunque di discussioni un po’ superate, appunto perché la formazione scolastica e universitaria svolge poco e male il suo ruolo di allenamento del giovane all’agone sociale, culturale, professionale. Una scena di vita vissuta da una discussione di tesi di qualche giorno fa può essere da questo punto di vista illuminante. Gli studenti si avvicendavano in modo routinario davanti alla commissione con i loro elaborati, dove si notavano persino refusi, e col loro parlare stentato o a pappagallo, confermando la scarsa cura prestata dai relatori. Colpiva anche però come i medesimi professori si fossero peritati di assegnare tesi con citazioni di Marx, oggetti di studio come la propaganda comunista oppure di moda come l’inclusione e la diversità.
Inevitabile quindi la litania oratoria (viviamo in una società di comunicazione, ma spesso per questi ragazzi la discussione di tesi è il primo vero discorso pubblico) infarcita di slogan, parole passe-partout, luoghi comuni, banalità. Insomma, una sagra del conformismo, come se l’università non facesse da propulsore di un cambiamento, di un miglioramento della società e della cultura, ma si adattasse in modo conformistico all’esistente. Il che è poi la verità: sappiamo benissimo che il limite dei percorsi formativi è l’adesione al pensiero convergente, cosa che in una società in veloce modificazione come la nostra crea una spaccatura sempre più grave.
Ah, queste sono considerazione che facevano già i classici più di 2000 anni fa…