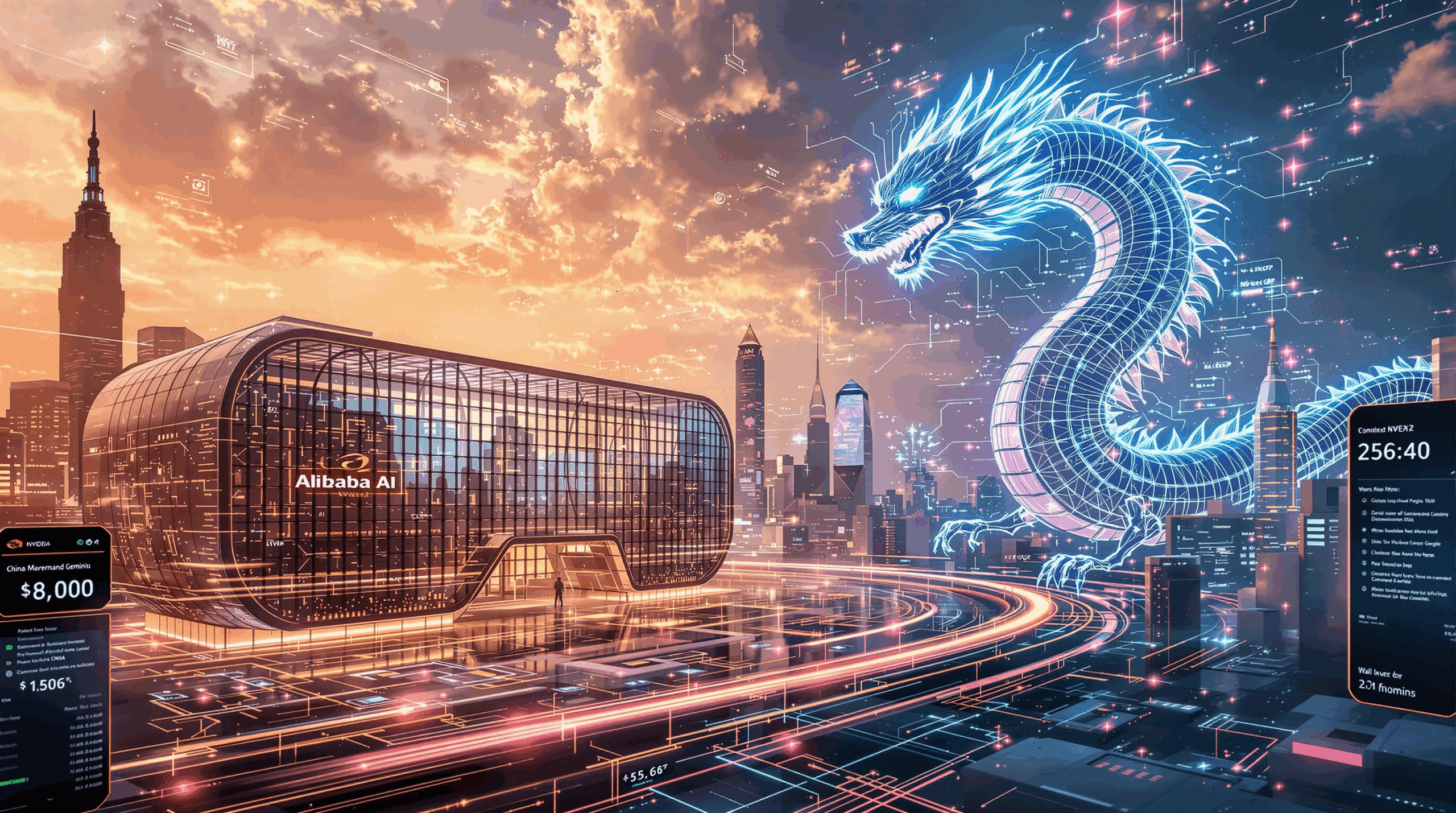Vista dall’Italia, la vicenda di un ex presidente della Repubblica francese come Nicolas Sarkozy che entra in carcere solleva alcune domande: è il sintomo della crisi terminale di un sistema politico? O è la dimostrazione che, nonostante i profondi problemi politici e finanziari che la tormentano, la Repubblica francese è ancora abbastanza solida e forte da dimostrare che la legge è uguale per tutti, anche per gli ex capi di Stato?
Si leggono e si sentono molti commenti superficiali, che liquidano la questione come se fosse un tic francese quello di abbattere i propri sovrani. A Luigi XVI è andata peggio, con la ghigliottina nel 1793. Ma anche il capo del governo collaborazionista con gli occupanti tedeschi durante la seconda guerra mondiale, cioè Philippe Pétain, ha finito i suoi giorni in carcere.
Dunque non è la prima volta che un capo di Stato si trova dietro le sbarre. Ma è la prima volta per un presidente della Repubblica.
La Francia si trova così nella situazione di avere un ex presidente, Sarkozy, che è in carcere e un futuro presidente, Marine Le Pen, già condannata per abuso di rimborsi pubblici per gli assistenti al Parlamento europeo, che potrebbe finirci. Mentre all’Eliseo rimane, immobile ma sempre più fragile, Emmanuel Macron, presidente con meno scandali – almeno non per corruzione – ma che è diventato l’immagine della paralisi e della perdita di consenso delle istituzioni francesi.
Dunque la vicenda Sarkozy è soltanto una nota di colore nella storia complessiva del collasso di un sistema politico, oppure è la dimostrazione di una sorprendente vitalità della democrazia francese, che riesce ancora ad affermare il suo valore fondante dell’uguaglianza, almeno davanti alla legge?
La fedina penale
Molti dei commenti, almeno qui in Italia, prescindono dai fatti. Prima di parlare del processo che ha portato Sarkozy in carcere, a La Santé, bisogna ricordare la sua sterminata fedina penale.
L’ex presidente è stato condannato in via definitiva per corruzione e traffico di influenze per aver cercato di ottenere informazioni riservate da un alto magistrato promettendogli un incarico. Le prove sono nelle intercettazioni telefoniche del 2014 sulla linea segreta, intestata al fittizio Paul Bismuth, che Sarkozy aveva con il suo avvocato.
Sarkozy se l’è cavata con arresti domiciliari e braccialetto elettronico, ma era già un condannato in via definitiva prima della sentenza del 25 settembre che ora lo ha portato in carcere.
Poi pende la sentenza della Cassazione su un altro caso di finanziamento illegale per la campagna elettorale, per aver sforato il tetto di spesa nel 2012 con un sistema di fatture fittizie. Nei primi due gradi Sarkozy è stato condannato.
C’è l’indagine sul possibile ruolo di Sarkozy come mediatore di uno schema corruttivo nel 2010 per assegnare al Qatar i mondiali che si sono giocati nel 2022.
E molto altro ancora, incluse le irregolarità sull’assegnazione senza gara dei sondaggi quando Sarkozy era all’Eliseo. Irregolarità accertate, ma Sarkozy non era perseguibile penalmente perché agiva nelle sue funzioni di presidente.
Insomma, quando Sarkozy è uscito dal tribunale che lo ha condannato a settembre e ha detto “sono innocente” non aveva molti elementi per sostenere una affermazione così generica e contraddetta da un po’ troppi elementi.
E veniamo così al processo che lo ha portato in carcere, dove deve scontare una condanna per cinque anni anche se inizierà presto ad avere permessi e sconti di pena perché ha superato i 70 anni.
La vicenda è molto complicata, ma si può riassumere così. Tra 2005 e 2006 Nicolas Sarkozy è ministro dell’Interno, all’Eliseo c’è Jacques Chirac, un altro che finirà la sua carriera in tribunale ma con accuse minori, soltanto, diciamo così, di appropriazione indebita.
Sarkozy inizia a preparare la sua campagna per diventare il candidato del partito conservatore, che allora si chiamava UMP, e poi puntare all’Eliseo alle elezioni del 2007. Non è sicuro di farcela perché il suo rivale è l’autorevole ministro degli Esteri Dominique De Villepin.
Secondo quanto ricostruito dall’accusa prima e dal processo poi, Sarkozy evita di agire in prima persona, ma lascia che alcuni suoi stretti collaboratori stringano contatti con il regime di Muammar Gheddafi in Libia.
Sarkozy si occupa degli affari di maggiore portata, intese sul nucleare, vendite di caccia Rafale francesi, gestione di delicate questioni diplomatiche come delle infermiere da estradare in Bulgaria.
Intanto gli uomini di Sarkozy trattano con quelli di Gheddafi finanziamenti milionari e illegali per favorire l’ascesa di Sarkozy all’Eliseo. C’è uno strano mediatore franco-libanese, Ziad Takieddine, che è sempre presente agli incontri di Sarkozy in Libia, ma soltanto a quelli, mai alle visite degli altri ministri francesi.
Sarkozy e i suoi collaboratori iniziano a occuparsi del caso del terrorista Abdallah Senoussi, capo dei servizi segreti, considerato responsabile della fase degli attentati libici sui voli civili, come quello sul volo UTA 772 nel 1986, 170 morti. Senoussi in Francia era stato condannato all’ergastolo, ma Gheddafi sperava che ci fosse una revisione della pena.
Mentre Sarkozy e i suoi si muovono in questa zona grigia tra affari e favori con un regime considerato già allora poco raccomandabile, il mediatore Ziad Takieddine inizia a ricevere soldi dallo Stato libico sui conti di una sua oscura società creata alle Isole vergini, un paradiso fiscale, e con una intricata rete di conti correnti tra Libano e Liechtenstein.
Arrivano 3 milioni. Forse la prima tranche di un flusso molto più ingente, una scommessa su quell’ambizioso ministro dell’Interno francese che al momento dei primi movimenti di denaro non era neppure sicuro di essere il candidato del suo partito per la presidenza.
Ziad Takieddine, nel processo, prima parlerà di decine di milioni di euro mandati da Gheddafi a Sarkozy, poi ritratterà tutto, e c’è un altro filone di indagine che riguarda anche la moglie di Sarkozy, Carla Bruni, un cellulare riservato a trattative con una mediatrice, forse proprio per far ritrattare Takieddine.
Con un singolare tempismo, comunque, Takieddine muore il 23 settembre 2025, due giorni prima della condanna in primo grado di Sarkozy per i rapporti con i libici.
Comunque, per quanti sforzi abbiano fatto i magistrati, alla fine ci sono soltanto 35.000 euro in contanti pagati dalla campagna elettorale del 2007 di Sarkozy al suo staff.
Dove sono i soldi
La gigantesca corruzione libica non c’è mai stata? A parte quei primi milioni, i libici non hanno mai pagato altro? Oppure quei soldi sono andati ad arricchire Sarkozy e i suoi, invece che a finanziare la scalata all’Eliseo? Quella rete di mediatori e faccendieri è riuscita a mascherare così bene le mazzette da renderle non riconoscibili?
Il processo non è arrivato a una risposta, molte delle accuse più gravi verso Sarkozy sono cadute.
È rimasta però quella di un reato equivalente alla nostra associazione per delinquere: come in Italia, si può essere condannati per corruzione anche senza traccia della mazzetta che, per definizione, è concepita per non lasciarsi alle spalle ricevute o fatture.
In Italia la corruzione prevede che il corruttore dia o prometta denaro o altra utilità. Quindi non è necessario trovare i soldi per stabilire che lo schema corruttivo c’era.
E così hanno sancito i giudici francesi. Visto che comunque si tratta di un reato grave, Sarkozy finisce in carcere senza la sospensione della pena in attesa della sentenza definitiva. E’ un approccio drastico, ma non è un caso unico il suo. E, come si vede, ha dato anche ampia dimostrazione che se lasciato a piede libero può continuare a trafficare per cercare di condizionare l’esito dei processi a suo beneficio.
Qualcuno, anche in Italia, in questi casi dice che i giudici non dovrebbero processare la politica. Che spetta al massimo agli elettori, o ad altri politici, giudicare quello che gli eletti fanno mentre sono in carica.
È più complicato di così, però. Anche in Francia c’è l’equivalente del nostro tribunale dei ministri, cioè un tribunale dedicato a valutare i possibili reati che i politici compiono nell’esercizio delle loro funzioni.
Ma i giudici del caso Sarkozy hanno stabilito, con argomenti difficili da confutare, che quando Sarkozy trafficava in Libia, prometteva centrali nucleari e mandava i suoi uomini a discutere finanziamenti, non agiva da ministro dell’Interno. Bensì da candidato, e i candidati sono cittadini comuni processabili in tribunali comuni, anche se provvisoriamente ricoprono un incarico pubblico.
Peraltro, nella sentenza i giudici osservano che questi rapporti corruttivi non sembrano aver inciso sulla politica francese verso la Libia dopo l’elezione di Sarkozy all’Eliseo. Anzi, nel 2011 è Sarkozy a cercare il sostegno di Stati Uniti e Gran Bretagna per bombardare la Libia e uccidere Gheddafi impegnato nella repressione violenta delle proteste in patria.
I giudici non entrano nelle valutazioni politiche, se non per escludere che ci sia una qualche contropartita politica conclamata dei possibili finanziamenti libici.
Chi vuole trovare punti deboli in un processo per corruzione nel quale mancano le mazzette e, in fondo, il movente del corruttore.
Ma, come ha scritto il giurista Thibault Carrère sul sito Verfassungsblog, questo caso “esemplifica la filosofia repubblica” che è l’essenza della democrazia francese:
Al suo centro vi è la virtù civica: la capacità di distinguere il bene pubblico dagli interessi privati.
Quando i leader li confondono, il sistema politico stesso si corrompe. Il tratto distintivo della filosofia repubblicana, soprattutto nella sua forma moderna, è l’affermazione secondo cui la virtù deve essere istituzionalizzata. Il repubblicanesimo moderno sottolinea che la virtù non dovrebbe dipendere soltanto dalla coscienza individuale, ma deve essere rafforzata dalle istituzioni.
(Estratto da Appunti di Stefano Feltri)