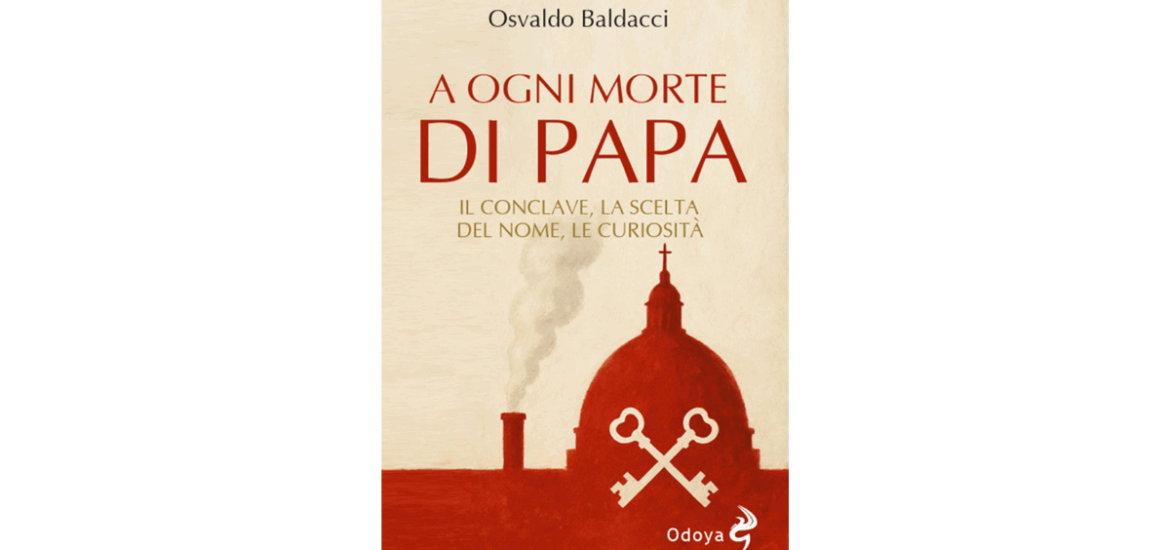Un momento determinante nella nomina di un nuovo Pontefice è la scelta del proprio nome. Tanto che questo elemento è presente nella notissima formula del primo annuncio pubblico dell’avvenuta elezione. La scelta del nome è un elemento importante, anche perché già riassume in sé gli aspetti programmatici che ha in mente il futuro Papa.
Basti pensare alla scelta del nome (fino ad allora inedito) di Francesco da parte di Jorge Mario Bergoglio, con tutto quello che ha implicato nel corso del suo pontificato in termini di scelte prioritarie in favore dei poveri e dell’ambiente.
Nella quasi totalità dei casi poi il nome scelto ha costituito l’omaggio a un predecessore, per indicare ammirazione e gratitudine, ma anche – tornando alle linee di indirizzo – volendo indicare l’intenzione di seguire la strada tracciata dall’omonimo predecessore.
L’assunzione di un nome nuovo poi porta con sé una forte simbologia (in parallelo con quanto da molto più tempo fanno nella Chiesa monaci e suore, e che inoltre si ritrova già persino in personaggi chiave nell’Antico Testamento): il taglio netto con il passato, la nascita di una persona del tutto nuova che da quel momento in poi sarà dedicata solamente a quell’ufficio, in una totale identificazione, anche lasciandosi alle spalle le contaminazioni del proprio vissuto per guardare tutto con occhi rinnovati dalla consacrazione al nuovo e definitivo ruolo. Una creazione di una nuova persona così come con l’imposizione del nome al momento del battesimo si definisce l’identità del nuovo cristiano.
Oggi nella procedura della nomina del nuovo Papa è previsto che dopo il raggiungimento dell’elezione e dopo l’accettazione del candidato, il cardinale decano del Collegio Cardinalizio chieda all’eletto «Quo nomine vis vocari?» («Con quale nome vuoi essere chiamato?»). Ma l’assunzione di un nome nuovo e diverso dal proprio non è un obbligo per il Papa, non è previsto da alcuna regola, e – come per molte di queste procedure – non è stato sempre così. Certo, il primo a cambiare nome è stato proprio il primo Papa e a cambiarglielo secondo il Vangelo è stato Gesù in persona: “Simone, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” (Vangelo secondo Matteo, 16,18).
Però la stessa prassi non è stata seguita dai suoi successori, che per quanto ne sappiamo hanno mantenuto il proprio nome. In realtà per essere precisi per i Pontefici più antichi non abbiamo notizie esatte: non sappiamo cioè se ad esempio abbiano cambiato il loro nome originario già al momento del battesimo, oppure se per quelli di loro che provenivano dalle diverse province romane (dal Medio Oriente al Nord Africa) l’assunzione di un nome latino o greco (tutti i nomi dei Papi più antichi sono in queste due lingue) si sia giustapposta o sovrapposta alla presenza di un altro nome nella lingua originale (come nel caso di Saul divenuto Paolo, per capirci). Per assoluta onestà bisognerebbe anche puntualizzare che non abbiamo la totale certezza che nessuno di loro abbia mai assunto un nome diverso al momento di diventare vescovo di Roma (magari in omaggio a Simon Pietro).
Possiamo però dire che i nomi “da Papa” con cui li conosciamo sono anche gli unici nomi con cui ci sono noti, e per quanto è possibile ricostruire dove le fonti sono meno scarse sembra che la prassi fosse quella di essere chiamati con il proprio nome precedente all’elezione. La prima assunzione certa di un nome diverso risale al 31 dicembre 532. Fino a quel momento i vescovi di Roma avevano mantenuto il proprio nome aggiungendo semmai l’indicazione della loro provenienza (ma non ancora il numerale). Alla morte di Bonifacio II venne eletto il romano Mercurio (o Mercuriale), presbitero della chiesa di San Clemente, intronizzato il 2 gennaio 533. Lui o altri intorno a lui (una tradizione parla della madre) ritennero incompatibile per il capo della Chiesa cristiana portare il nome di un dio pagano, peraltro patrono dei ladri e dei truffatori, oltre che dei commercianti. Mercurio allora scelse il nome molto evangelico di un recente predecessore, Giovanni, morto martire imprigionato dal re Teodorico a Ravenna: si chiamò dunque anche lui Giovanni (il secondo, avviando così una lunga scia di omonimi, la più folta nella storia della Chiesa). Questa scelta però non è bastata per fare scuola. Evidentemente la spiegazione che si fosse trattato di una scelta di devozione a causa dell’assonanza con il dio pagano veniva ritenuta sufficiente a far considerare il cambio nome un’eccezione. Per trovare un nuovo gesto simile bisogna quindi attendere alcuni secoli: nel 955 Ottaviano dei Conti di Tuscolo decise di farsi chiamare Giovanni XII.
(…)
A ripetere questo gesto fu invece nel 983 Giovanni XIV: il suo nome originale era Pietro Campanora, e come spiegazione per la scelta sembra sufficiente il fatto che in segno di rispetto e umiltà non volesse che fosse ripreso il nome dell’apostolo e primo Papa. Il suo successore però già si chiamava Giovanni di nome battesimale e lo mantenne come Papa Giovanni XV. Nel 996 venne però eletto un Papa di origine germanica, Bruno di Carinzia, il cui nome non apparteneva alla tradizione latina cristiana. Egli dunque optò per assumere un nome pontificale più tradizionale, quello di Gregorio V. A lui nel 999 succedette un altro Papa “straniero”, il primo francese, Gerberto di Aurillac, per cui valeva la stessa considerazione: egli optò per il nome Silvestro II.
Così la tradizione di cambiare nome si andava consolidando, anche perché i nomi germanici ed estranei alla tradizione divenivano sempre più diffusi in tutta Europa, Italia compresa, e quindi divenne prassi comune assumere un nuovo nome una volta eletti al Soglio di Pietro. Solo un paio di anti-papi in quel periodo mantennero i loro nomi germanici di nascita. Ma intanto nel 1003 e nel 1004 venero eletti di nuovo due Papi romani e di nome Giovanni, che decisero di mantenere. Nel 1009 però al soglio di Pietro venne eletto ancora una volta un uomo di nome Pietro, e ancora una volta costui decise di non assumere come secondo il nome del primo apostolo, e preferì chiamarsi Papa Sergio IV.
Così possiamo dire che è da questo periodo che è diventata se non norma almeno consuetudine per il Pontefice assumere un nuovo nome all’intronizzazione. Di solito scelgono il nome di un predecessore, spesso quello di chi li aveva ordinati cardinali. Martino V e Clemente XI hanno invece scelto il nome in onore al santo del giorno dell’elezione o della consacrazione.
A questa regola non scritta ci sono state da allora solo due eccezioni, entrambe nel XVI secolo. Il tedesco-olandese Adrian Florensz Dedal nel 1522 divenne Papa assumendo il nome di Adriano VI. Nel 1555 fu il turno di Marcello Cervini che si fece chiamare Marcello II. Prima di loro nel 1503 Giuliano della Rovere ricorse forse a una piccola astuzia: scelse di diventare papa Giulio II. Marcello II fu l’ultimo pontefice a mantenere il nome di battesimo fino ad oggi: ne è nata anche una piccola storiella, secondo la quale essendo lui morto dopo soli una ventina di giorni dall’intronizzazione, qualcuno suggerì che non cambiare nome portava sfortuna, e così tutti i successori si sarebbero poi attenuti alla consuetudine. Diciamo che la spiegazione spirituale in questo contesto è più attendibile.