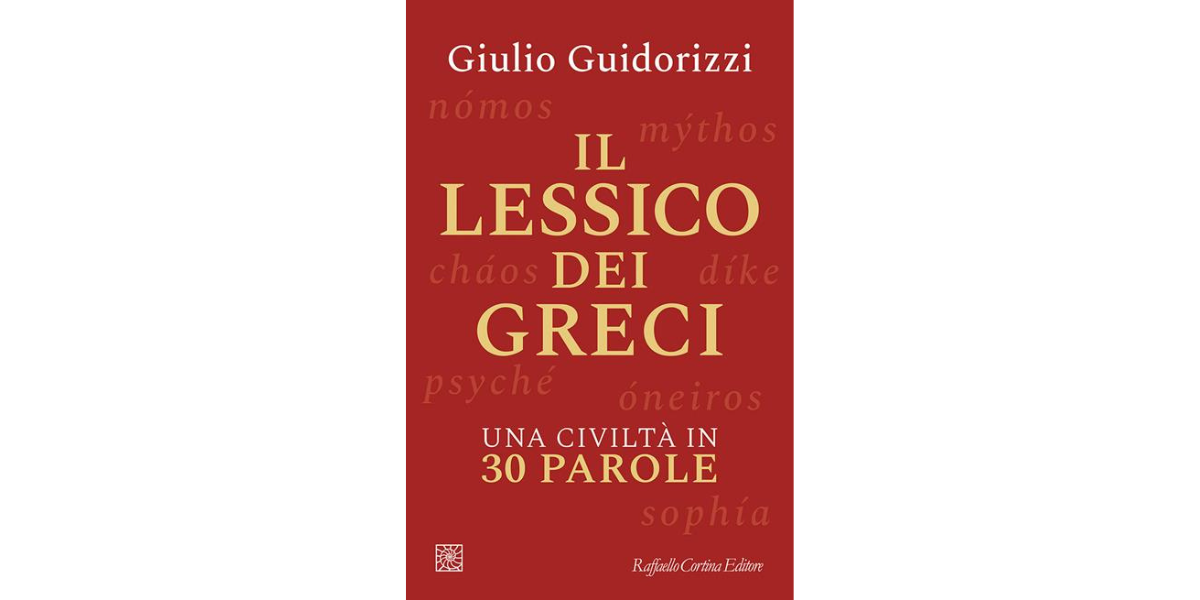La norma dell’ultimo Dpcm non è un modello di chiarezza, ma da lunedì prossimo ci autorizza (forse) a correre e camminare anche lontano da casa. Vedremo presto, comunque, se si tratta di una vera novità. In tal caso, gli sportivi potranno allenarsi e i comuni mortali prendere una boccata d’aria per qualche ora o anche più (magari grazie a ordinanze regionali più benevole).
Beninteso, maratoneti o podisti dilettanti che siano, gli italiani dovranno attraversare per lo più da soli i parchi delle città, i sentieri di montagna, i viottoli campestri. A molti potrà non piacere, eppure la passeggiata solitaria è stata celebrata da numerosi letterati e pensatori come una condizione ideale per riconquistare quella libertà interiore perennemente insidiata dagli obblighi e dalle consuetudini sociali. Ne cito solo alcuni.
Nei suoi Detti memorabili, Senofonte (430-355 a.C circa) racconta che Socrate passeggiava senza sosta sull’agorà soprattutto nei giorni di mercato, quando era pieno di gente. Un brano delle “Vite dei filosofi” di Diogene Laerzio (180-240 d.C), indica che Platone insegnava camminando. Aristotele deve proprio a questa abitudine il suo soprannome di “passeggiatore” (“peripatêtikos”). Nella scuola stoica di Epitteto (50-130 d.C circa), invece, il maestro si rivolgeva a un pubblico che bisogna immaginare immobile, e che lui interpellava. Così Epicuro (341-270 a.C) ai discepoli nel suo famoso “giardino” di Atene. Gli unici sapienti greci davvero camminatori, dunque, furono i cinici.
Vagabondi di professione come i cani randagi (cinico viene dal greco “kúon”, cane), erano accusati dai loro avversari di nutrirsi di carne cruda. I seguaci di Antistenee di Diogene di Sinope, vissuti tra il quinto e il quarto secolo a.C., camminavano a pieni nudi, con un bastone in mano e con il corpo coperto da un mantello di stoffa che serviva anche da giaciglio. È a loro che somiglieranno il pellegrino medievale e il predicatore degli ordini mendicanti. I cinici, però, non camminavano per evangelizzare, bensì per fustigare le false credenze e i futili costumi degli ateniesi. Senza affetti familiari, senza patria e senza possedimenti, consideravano il nomadismo come un’espressione della sovranità assoluta di cui gode chi si sente cittadino del mondo.
Kant, all’opposto, non ha mai varcato le mura di Königsberg (l’attuale Kaliningrad), la sua città natale. Come per Nietzsche, nella gerarchia delle sue occupazioni quotidiane l’imperativo della passeggiata e l’attenzione al cibo venivano subito dopo la lettura e la scrittura. Ma gli stili di vita dei due grandi filosofi erano assai diversi. Nietzsche era uno scalatore infaticabile: conosceva come le sue tasche le montagne dell’Engadina come le alture della costiera ligure e amalfitana; e la sua dieta era da eremita. Kant, al contrario, era di buon appetito e, terminata la sua passeggiata di un’ora esatta (ai suoi amici era severamente proibito di accompagnarlo), rientrava a casa.
Qualunque fosse il tempo, però, la faceva. Durante l’intera durata del tragitto, respirava col naso tenendo la bocca chiusa: uno stratagemma a cui ricorreva per tutelare la sua salute. Ciò che impressiona in Kant, tuttavia, è la costanza di una simile disciplina. Si narra che l’abbia infranta solamente in due circostanze: per procurarsi una copia dell’Emilio di Rousseau e per informarsi sugli sviluppi della rivoluzione francese. Uniche eccezioni a una regola ferrea che fungeva da coronamento e, insieme, da preludio a una pagina da scrivere, a un’idea da approfondire, a una dimostrazione da perfezionare. E, alla fine, un’opera gigantesca.
Nelle Confessioni (pubblicate postume tra il 1782 e il 1789), Rousseau afferma che la vista di una scrivania e di una sedia lo nauseava. Solo le interminabili camminate eccitavano i suoi sensi e il suo fervore creativo. Dopo i lunghi viaggi della giovinezza in Francia e in Italia, per un ventennio vestirà i panni del “signore” — come si definisce — che si sposta soltanto in carrozza, alla ricerca febbrile di una gloria non effimera tra i suoi contemporanei. Più tardi, diventa un proscritto: condannato a Parigi e Ginevra, è minacciato di arresto. Si bruciano i suoi libri sulla pubblica piazza. E, quando le passioni più violente si placano, torna a vagare tra i boschi di Saint-Germain e di Boulogne. E lì scopre il profilo fragile dell’uomo civilizzato, la cui innocenza primitiva è stata corrotta dalle ipocrisie e dalle ingiustizie sociali. Tra il 1776 e il 1778, alla vigilia della sua morte, scrive così Les Rêveries du promeneur solitaire. Fantasticherie crepuscolari di un camminatore solitario, nate nel corso di quelle passeggiate che lenivano le amarezze della vecchiaia.
Nel 1854, quando fu data alle stampe per la prima volta Walden, Henry David Thoreau aveva da poco compiuto trentasette anni. Era infatti nato il 12 luglio 1817 a Concord, nel Massachusetts. La cittadina, che allora contava duemila anime, era circondata da monti, fiumi, laghi, campi coltivati da contadini laboriosi. In questo “paesaggio favoloso dei suoi sogni infantili”, il filosofo americano elabora — sulla scia di Rousseau — una originale concezione della natura come fonte di purezza e di verità interiore, sacrificate sull’altare del culto del denaro e del consumo. Il “figlio dell’acqua”, che avrà un lettore attento in Marcel Proust, nei suoi scritti inneggia alla libertà dell’individuo immerso nella solitudine della foresta e proteso alla ricerca del tempo perduto. Immenso escursionista (da tre a cinque ore al giorno, tutti i giorni, nella foresta che dà il titolo alla sua opera eponima), Thoreau insiste su un punto: camminando, l’uomo non si sente nella natura, ma diventa “naturale”. E, camminando, avverte una specie di viscerale partecipazione alla sua realtà.
Diversamente da Rousseau, Nietzsche e Thoreau, Gustave Flaubert era convinto che solo stando seduti si poteva pensare e scrivere. Al padre di Emma Bovary questa idea costerà la dura replica di Nietzsche nel Crepuscolo degli idoli (1889): “Restare seduti è esattamente il peccato contro lo spirito santo. Solo i pensieri nati camminando hanno valore”. Prima di loro, tuttavia, Honoré de Balzac si era interrogato sul significato mai sondato fino in fondo, a suo avviso, del camminare. La sua Théorie de la démarche (Teoria del camminare, Elliot, 2014) comparve per la prima volta — in cinque puntate — sulla rivista “L’Europe Littéraire” nel 1833. Partendo dall’assioma per cui “la camminata è la fisionomia del corpo”, Balzac indaga tra i pensieri più segreti, le emozioni più nascoste, che si rivelano all’occhio esperto di chi sa osservare l’andatura del “marcheur”. Preso dall’esaltazione che deriva da ogni grande scoperta, tra l’ironico e l’epico dichiara che “l’arte di alzare e abbassare il piede”, per essere compresa, richiede una scienza capace di differenziare il movimento dei “tipi umani” sulla base dei mestieri, delle classi e delle convenzioni sociali.
È stato soprattutto Walter Benjamin che ha reso celebre, con i suoi studi, il personaggio del “flâneur”, ben diverso dal passeggiatore fin qui tratteggiato. Nei Passages di Parigi (Einaudi, 2010), a cui aveva lavorato — braccato dai nazisti — fino al suo suicidio (1940), ne analizza la fenomenologia rileggendo le pagine di Charles Baudelaire, il poeta che più lo aveva impersonificato. Emblema del perfetto perdigiorno, nella tradizione letteraria dell’Ottocento il “flâneur” rappresenta l’intellettuale che passa il suo tempo vagando senza meta, contemplando con disincanto le masse che si muovono nello spazio urbano. È insomma un aristocratico dello spirito, un borghese esentato dalla lotta per la sopravvivenza, un prodotto della rivoluzione industriale, come aveva acutamente intuito Benjamin.
Anche il “flâneur” è un accanito camminatore, come il protagonista di uno straordinario racconto dello scrittore svizzero Robert Walser, La passeggiata (1919). Mentre il drammaturgo austriaco di origine boema Rainer Maria Rilke lo aveva ritratto, nei “Quaderni di Malte Laurids Brigge” (1910), come un errabondo inquieto e tormentato, che si aggira nei labirinti di una Parigi infernale e sotterranea in preda a un delirio allucinatorio. Una delle ultime opere degne di menzione della letteratura novecentesca della “flânerie” è probabilmente la Trilogia di New York di Paul Auster (1985-1987), in cui il protagonista, anch’egli un passeggiatore solitario, si trasforma in un detective alla ricerca del senso della vita in una metropoli surreale e alienante.
Ma esiste ancora, oggi, la figura del “flâneur”? Può darsi, ma non ne sono sicuro. Da qualche tempo il suo erede è stato individuato nel “cyberflâneur”, il solitario navigatore della Rete che guarda con distacco il multiforme spettacolo della realtà virtuale, mosso da quel voyeurismo che costituisce la cifra del mito del “botanico da marciapiede” (copyright di Baudelaire). Ebbene, è probabile che Internet ci abbia reso un po’ vagabondi, esploratori di territori non battuti. Riflettiamo però su una questione. Mentre agli albori della cultura digitale si credeva che una maggiore trasparenza e più ampie chance di partecipazione al gioco democratico avrebbero dato un colpo decisivo alle concentrazioni di potere e ai vertici di gestione delle conoscenze, adesso sappiamo che il flusso delle informazioni è governato da pochi gruppi dominanti. Un oligopolio che può decidere la sistematica violazione della verità fattuale, rendendo difficile lo smascheramento del falso. In questo senso, non c’è da stupirsi se il “chiunque” trionfatore del Web spesso è un professionista della menzogna. Attacchi personali, volgarità gratuite, sindrome del complottismo, fake news al riparo dell’anonimato: non sono forse i grandi attori del teatro populista?
Buona passeggiata a tutti.