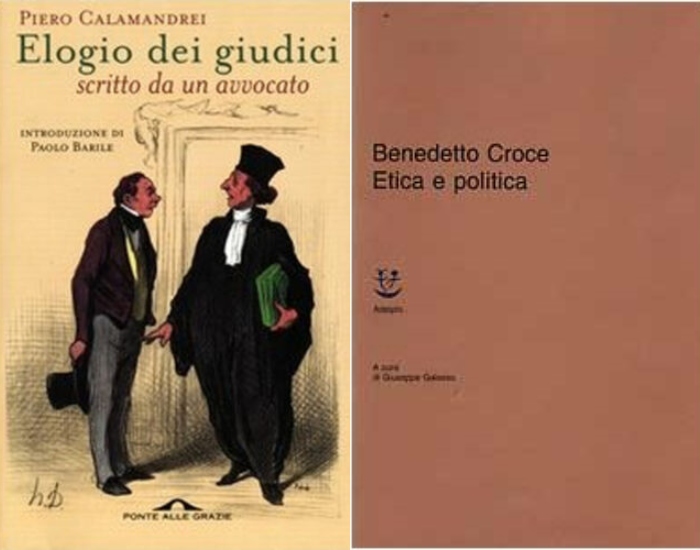“L’errore giudiziario qualche volta è l’effetto inconsapevole di un peccato d’orgoglio: il magistrato che ha infilato una strada, si rifiuta di ascoltare le ragioni di chi vuol dimostrargli che è sbagliata, perché è convinto che, se l’abbandonasse dopo averla presa, ne soffrirebbe la dignità della giustizia. Egli crede che sia in giuoco la giustizia, mentre è in giuoco soltanto il suo amor proprio: senza accorgersene, coll’ostinarsi nella sua tesi, da giudice si è trasformato in parte” (Piero Calamandrei, “Elogio dei giudici scritto da un avvocato”, 1935)
****
“Timidamente, dunque, e tra molte esitazioni e preoccupazioni, comincia a farsi strada faticosamente la consapevolezza che la regolamentazione delle funzioni e della stessa carriera dei magistrati del pubblico ministero non può più essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni e, quindi, le attitudini, l’habitus mentale, le capacità professionali richieste per l’espletamento di compiti così diversi: investigatore a tutti gli effetti il pubblico ministero, arbitro della controversia il giudice. Su questa direttrice bisogna muoversi, accantonando lo spauracchio della dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo e della discrezionalità dell’azione penale, che viene puntualmente sbandierato tutte le volte in cui si parla di differenziazione delle carriere.
Disconoscere la specificità delle funzioni requirenti rispetto a quelle giudicanti, nell’antistorico tentativo di continuare a considerare la magistratura unitariamente, equivale paradossalmente a garantire meno la stessa indipendenza e autonomia della magistratura, costituzionalmente garantita sia per gli organi requirenti che per gli organi giudicanti” (Giovanni Falcone, “La posta in gioco. Interventi e proposte per la lotta alla mafia”, Rizzoli, 2010).
****
“In Italia riformare la giustizia è difficile perché non c’è più la separazione dei poteri. Il governo è diventato legislatore. Il Parlamento è diventato amministratore. I giudici esercitano funzioni amministrative, occupando gli uffici serventi del Csm e del ministero della Giustizia, e la funzione legislativa con la loro presenza nei gabinetti ministeriali”. La riforma Nordio è “un buon inizio, purché si continui. I milioni di cause pendenti mostrano che c’è una domanda di giustizia che non viene soddisfatta. Questo si riflette nella rapidamente decrescente fiducia, misurata dai sondaggi, della popolazione nella magistratura. Se l’ordine giudiziario non riesce rapidamente a eliminare l’arretrato, rispondendo con sollecitudine alla domanda di coloro che si sono rivolti ai giudici, l’intero corpo della magistratura finirà per perdere completamente la fiducia che la collettività deve avere nella giustizia. Una giustizia che arriva in ritardo non è giustizia. E rischia di non esserlo una giustizia che perde la fiducia dei cittadini” (Sabino Cassese, intervista a Quotidiano Nazionale, 17 giugno).
****
In una celebre nota sull’onestà politica pubblicata nel 1931, Benedetto Croce narra le peripezie di Charles James Fox. È il grande statista inglese, vissuto nella seconda metà del diciottesimo secolo, a cui si deve il trattato che nel1783 riconobbe l’indipendenza delle colonie americane. Dedito alla crapula e a dissolutezze di ogni tipo, una volta giunto al potere cerca di diventare uomo probo e di costumi morigerati. Sennonché, quando sente infiacchirsi la sua vena oratoria e la sua energia lottatrice, per ritrovare quelle forze torna rapidamente alle vecchie abitudini.
Si può deplorare, commenta Croce, una così infelice costituzione fisiologica e psicologica, che per agire aveva bisogno di discutibili eccitanti. Tuttavia Fox, aggiunge, giovò certamente al sua paese, sebbene “i padri di famiglia con pari prudenza gli avrebbero dovuto negare le loro figliuole in ispose”. Ma, conclude, è pur vero che “questa disarmonia tra vita propriamene politica e la restante vita pratica non può spingersi tropp’oltre, perché, se non altro, la cattiva reputazione prodotta dalla seconda, rioperando sulla prima, le frappone ostacoli […] o l’ipocrisia morale degli avversari può avvalersene da arma avvelenata. Ma questo è un altro discorso” (“Etica e politica”, Adelphi, 1994).