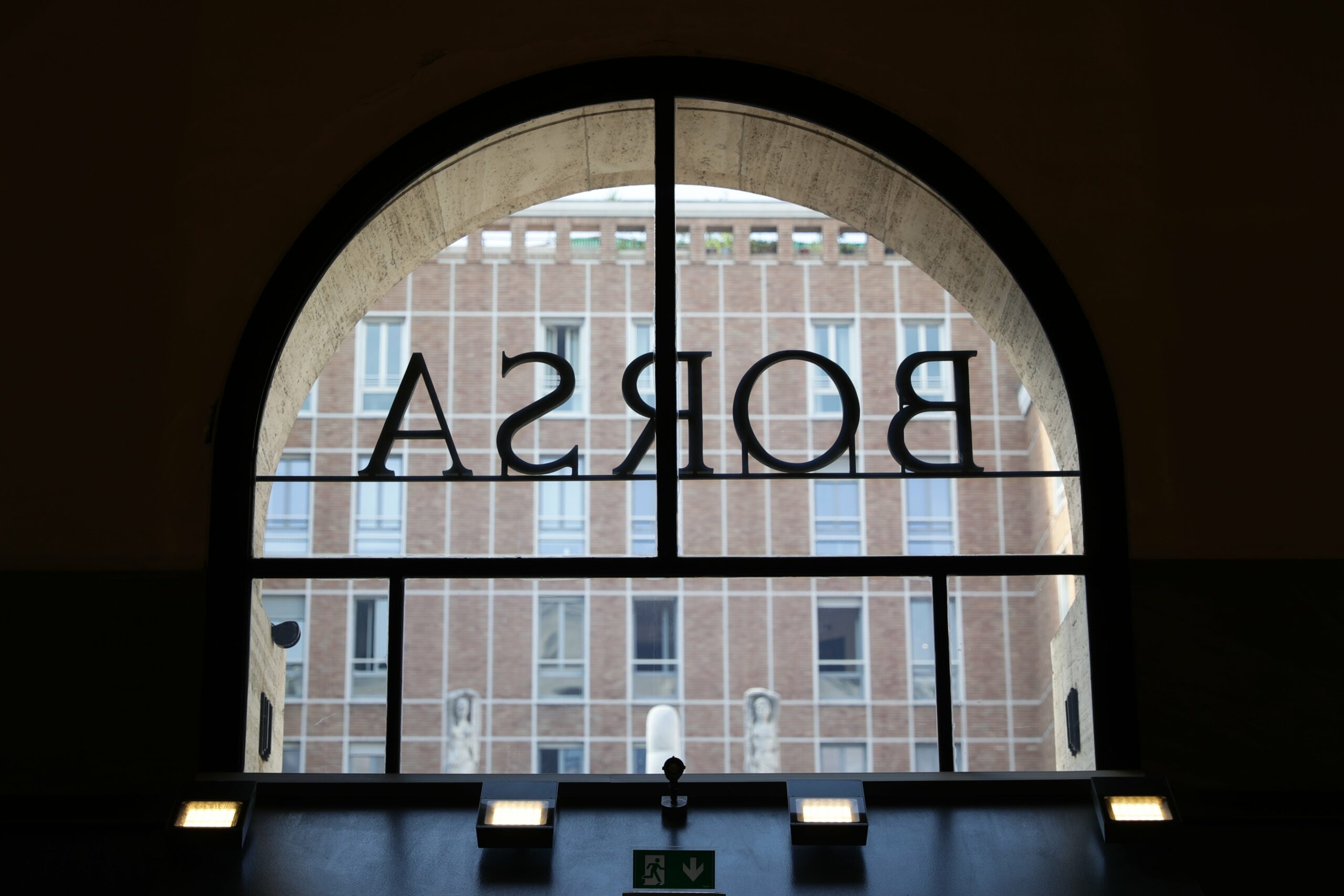Occasionalmente, sporadicamente, i temi della bioetica si affacciano alla ribalta della cronaca politica quotidiana. Potremmo anche parlare di “biopolitica”: entrambi i termini rendono chiaro il significato e la pregnanza di questi argomenti, come l’aborto e l’eutanasia, per la vita delle persone. Quasi tutti ci troviamo ad affrontare scelte delicate da questo punto di vista e siamo sempre di più, dato l’invecchiamento della popolazione, l’allungamento dell’età media e la tendenza alla diminuzione della natalità.
Già i due termini che abbiamo utilizzato in luogo delle perifrasi di “interruzione di gravidanza” e “morte assistita”, nel primo caso con evidente intento eufemistico, rendono però palese come queste questioni portino dietro anche delle modalità di comunicazione e rappresentazione interessanti dal punto di vista sociale, poiché applicate agli ambiti più vari.
In generale si sostiene che sulla bioetica si tendono a polarizzare le opinioni perché si accendono sentimenti istintivi e personali molto vivi e in qualche misura indipendenti dalle nostre convinzioni ideologiche più generali dato che nelle valutazioni entrano elementi biografici. È in genere un’esperienza di dolore personale o del nucleo famigliare a indirizzarci verso una scelta e dunque una posizione.
La considerazione è senz’altro vera. È però altrettanto ragionevole che su certi temi pressoché nessuno sostenga una posizione di estremismo assoluto: ben poche persone ritengono sia auspicabile utilizzare l’aborto come normale sistema di interruzione di gravidanza, quasi nessuno pensa lo si debba impedire a qualunque costo, anche nei casi più particolari come quello di stupro; parimenti, sono davvero risicate minoranze ad appoggiare il diritto a esercitare il cosiddetto suicidio assistito su chiunque e in qualunque caso, oppure che si debba negarlo a un malato che soffre in modo indicibile per una malattia sicuramente incurabile.
La trasversalità politica e ideologica dovrebbe consentire di trovare accordi verso una moderazione comune, cioè un’articolazione delle norme rispetto alle molte sfumature che queste situazioni possono presentare. Questo si dovrebbe teoricamente tradurre anche in una maggiore facilità di trovare accordi legislativi. Come stiamo vedendo in questi giorni, però, accade il contrario. Da un lato, sull’aborto, si spacca la stessa maggioranza, con la defezione della Lega; dall’altro nel PD la componente cattolica si dissocia spesso da quella più progressista. Anche sul fine vita abbiamo assistito a uno scontro istituzionale con la regione Emilia-Romagna che ha subdolamente cercato di applicare una norma più lassista, contro le indicazioni del Comitato Nazionale di Bioetica che anche, a maggioranza non all’unanimità, aveva invece stabilito criteri più rigorosi.
Queste spaccature all’interno dei partiti e delle alleanze, anziché favorire accordi di moderazione tendenti “al centro”, per così dire, complicano le scelte, che vengono dilazionate, lasciando spazio a decisioni autonome, quindi sentenze della magistratura, e iniziative soggettive come quelle di Marco Cappato.
Le cose in questi ambiti sono molto complicate. Ciascuno di noi dovrebbe fare una riflessione sincera e onesta. Come bisogna comportarsi, per esempio, nel caso di una persona molto anziana e stanca di vivere, allettata, immobilizzata in una stanza nella quale deve essere accudita anche per le minime esigenze, che esprime il desiderio di andarsene rifiutando cibo e acqua? Fino a che punto anche una semplice infusione di soluzione fisiologica o glucosata può diventare “accanimento terapeutico”? È legittimo assecondarla, se questo per chi la assiste significa farla “morire di fame e sete”? Sono grovigli morali ed esistenziali molto complicati, nei quali l’atteggiamento dei partiti suona quasi sempre con me un fastidioso tentativo propagandistico.