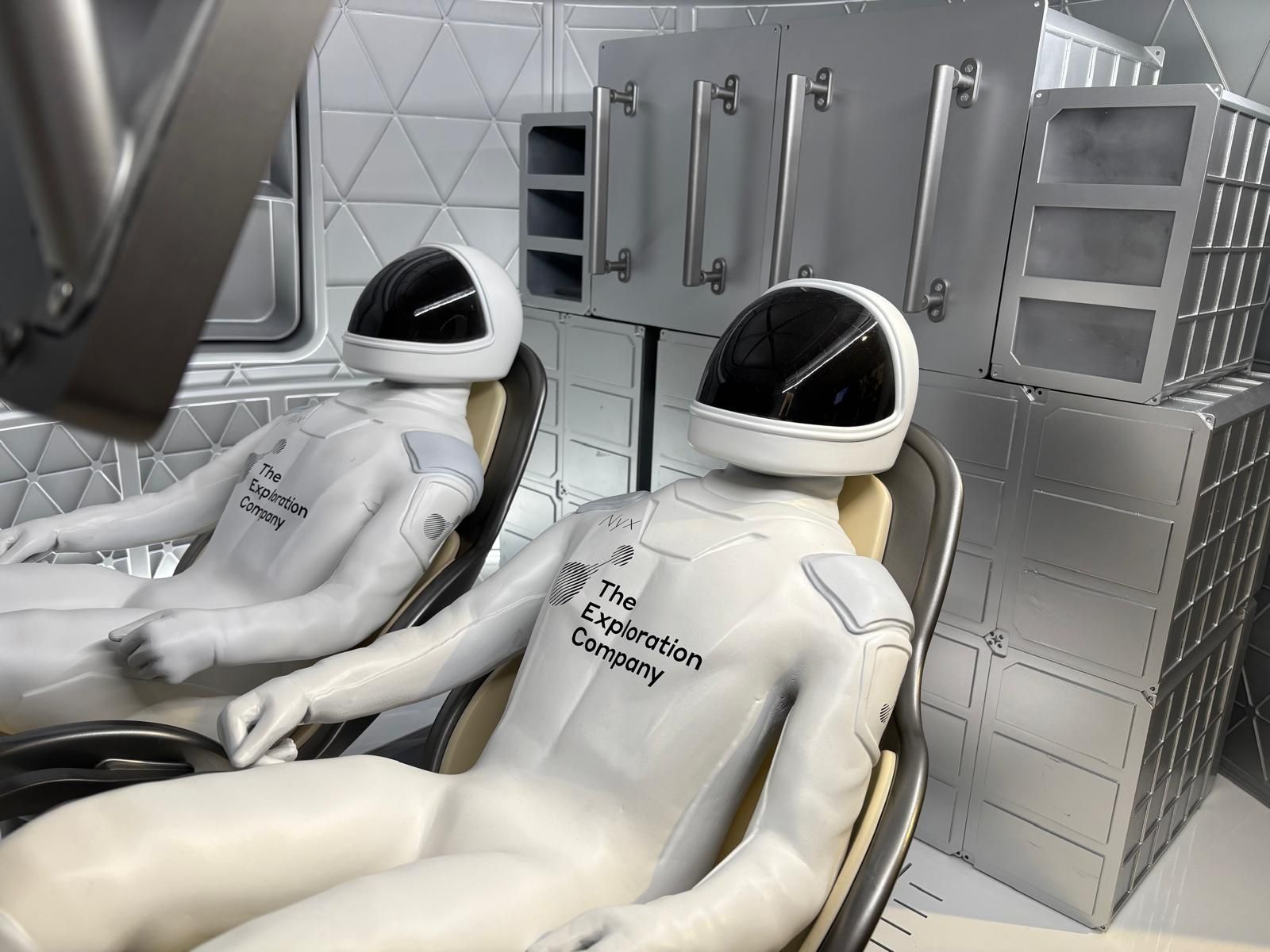L’ennesima uscita di un’impresa estera, con la rinuncia di Shell a dar seguito ai permessi di ricerca di gas e petrolio in Piemonte, è stata salutata con entusiasmo dal M5S come un ulteriore passo “verso un’Italia Oil Free”.
A parte il fatto che ancor oggi il petrolio costituisce col 34% la prima fonte dei nostri consumi di energia e che non estrarlo all’interno non equivale affatto a non consumarlo (bensì ad importarlo), può apparire fuori del coro parlare di petrolio e metano anche solo indirettamente riconducibili al nostro Paese. Parlare di Eni, ad esempio, e delle sue ottime performance.
Non farlo sarebbe però segno di quell’ipocrisia che attraversa l’imperante retorica ambientale su quel che sarà – grazie all’auspicato ma difficilissimo da conseguire Piano Energia-Clima – evitando di parlare di quel che è. E negli idrocarburi è soprattutto Eni: società quotata, (ancora) controllata dallo Stato, patrimonio quindi dell’intera collettività che ha ampiamente beneficiato della sua azione sin dalla sua fondazione nel 1953.
Qualcosa quindi di cui non bisognerebbe imbarazzarsi e tacerne, come nella più parte dei media. Né, a ben vedere, lo fa lo stesso Cane a Sei Zampe, sempre più proteso a pubblicizzare quel che fa nelle marginali rinnovabili (da ultimo sul moto ondoso o gli olii esausti) più che nel suo core business: petrolio e metano.
Per saperne di più è utile allora scorrere la stampa internazionale, specie quella specializzata, a iniziare dal più accreditato magazine del mondo degli idrocarburi: Oil&Gas Journal, fondato nel 1902, che in un recente numero riporta le classifiche delle Top 50 oil&gas americane e le Top 100 nelle altre regioni sui loro risultati nello scorso biennio.
Eni vi compare nella classifica europea come 4° gruppo dietro, nell’ordine, all’anglo-olandese Royal Dutch Shell (RDS), alla britannica BP, alla francese Total e davanti alla norvegese Equinor (nuovo nome di Statoil dopo un’abile operazione di green-washing) e alla spagnola Repsol.
Al di là della notevole differenza dimensionale negli indicatori monetari (ricavi e utili) in un rapporto sino a 1 a 4 rispetto alla prima classificata RDS, Eni evidenzia due aspetti del tutto peculiari rispetto ai suoi competitor: 1) una più elevata propensione ad investire e 2) una relativamente più ampia base mineraria.
Il volume di investimenti di Eni nel 2018 è stato di circa 11 miliardi di dollari rappresentando circa il 12 per cento dei suoi ricavi totali, contro percentuali dei competitor nettamente inferiori sino alla metà. Segno che il gruppo crede nel domani del suo core business, al di là delle nefaste profezie sull’imminente fine di petrolio e metano, ed al suo convinto impegno a ridurre l’“impronta carbonica” (carbon footprint) delle sue attività, ad iniziare da quelle upstream.
In sintesi: Eni è in grado di più che rimpiazzare la sua produzione corrente, individuando (con largo anticipo) nuove aree che presentino un minor time-to-market delle risorse rinvenute, rischi non elevati, costi contenuti, buoni margini.
La sua eccellenza nella fase esplorativa – universalmente apprezzata da competitor e paesi produttori – ha consentito al Gruppo nel recente passato di finanziare la più costosa fase di sviluppo cedendo quote minoritarie dei giacimenti scoperti. Quel che le ha permesso di prolungare i flussi di produzione, che nel 2018 hanno toccato un nuovo record di 1,85 milioni barili al giorno di petrolio equivalente, conseguendo una buona redditività, con un profitto per barile di 9,3 dollari (con prezzi oggi intorno ai 60 dollari).
L’insieme di questi dati porta a un’amara conclusione: che l’Italia, la sua politica, chi gestisce il controllo azionario del gruppo, dovrebbero essere ben orgogliosi di poter far conto su un’azienda come Eni. Evitando, magari, in modo ipocrita, di compiacersi di quel che fa all’estero ma impedendole di fare altrettanto in Italia. Quasi che i rischi ambientali sulle trivellazioni che si paventano (erroneamente) in Italia nulla contassero negli altri paesi da cui importiamo.
(estratto di un articolo pubblicato su Energia; qui la versione integrale)