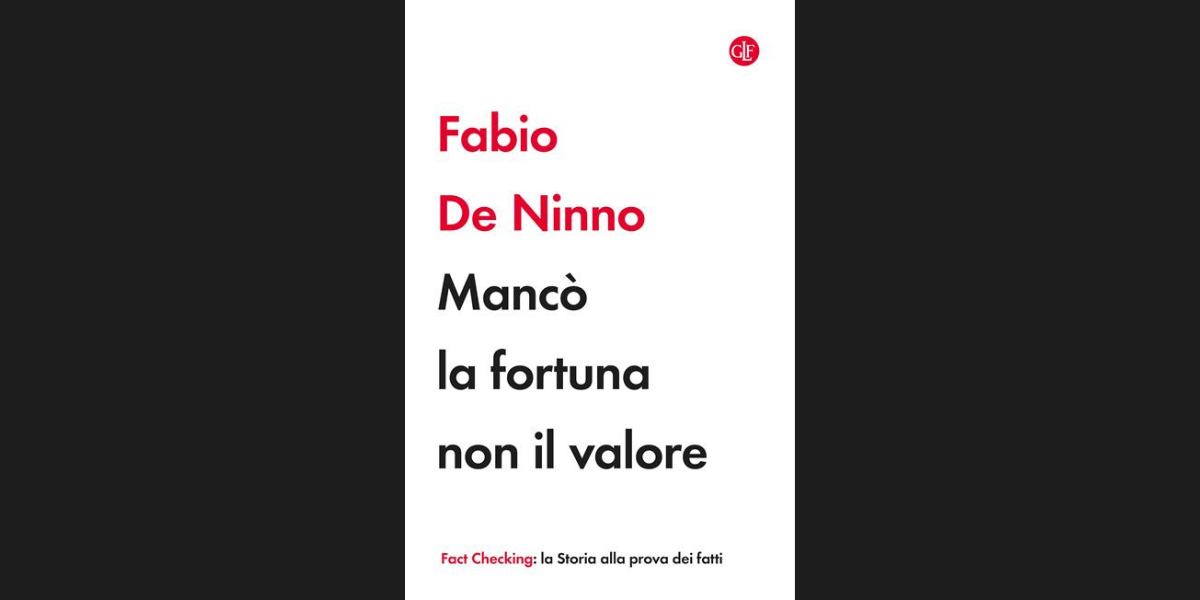Cosa sta accadendo sul Superbonus? Poco più di nulla. L’aspetto più rilevante, e meno edificante per il governo, è che sia costretto a tornare per l’ennesima volta sul tema con modifiche che tutto sommato potrebbero anche rivelarsi convenienti per il contribuente.
Il teatrino mediatico di questi giorni, con il ministro Giancarlo Giorgetti impegnato in singolar tenzone con l’altro ministro Antonio Tajani, lo lasciamo alle minime di cronaca. Qui non osserviamo il dito, ma la luna, che è la sostanza di quest’ultimo intervento, per il quale si è gridato “al lupo, al lupo” e poi si è scoperto che il lupo non è arrivato. Per avere un esempio, è sufficiente confrontare il Sole 24 Ore di ieri con quello di oggi.
Ci sono due modi per utilizzare il beneficio dei bonus edilizi: detraendoli anno dopo anno in dichiarazione o cedendo il credito con la stessa cadenza temporale. Il governo è intervenuto solo sugli anni in cui si detrae l’agevolazione, che passano da 4 a 10. Nulla accade ai crediti di imposta che sono quelli rivenienti da cessioni o sconto in fattura e che continuano ad essere recuperabili in 4 o 5 anni (barriere architettoniche).
E questo, come ha correttamente fatto rilevare oggi sul Sole Federica Brancaccio, presidente dell’Ance, potrebbe essere un vantaggio per il contribuente con minore capienza fiscale che avrebbe più possibilità di compensazione.
Invece il governo – dopo l’insuccesso della imposta degli extraprofitti – ci riprova con le banche che detengono decine di miliardi di crediti acquistati. Dal 2025 non saranno opponibili in compensazione i debiti per contributi previdenziali. Considerati gli ingenti utili di bilancio delle banche, questo difficilmente determinerà problemi di incapienza, ma oggettivamente disincentiverà le banche dall’acquisto di ulteriori crediti. Che è proprio l’obiettivo sempre dichiarato da Giorgetti: consentire il prevalente utilizzo dei bonus edilizi come detrazione in dichiarazione, e non cedendoli.
Il fatto che ciò avvenga in sede di conversione di un decreto legge che, appena 40 giorni fa, aveva introdotto ulteriori restrizioni per le cessioni e le compensazioni dei crediti, non è un segnale di grande lucidità e fermezza da parte del governo.
Una misura come il Superbonus aveva un senso nella fase post lockdown e per un periodo di vigenza limitato, per l’elevato effetto moltiplicativo sul Pil che quella spesa generalmente determina. Ma progettarlo senza un limite di risorse a disposizione e senza adeguati controlli e autorizzazioni ex-ante, è stato un grave errore.
La cui principale conseguenza è stata una sostanziale ipoteca sugli scenari di finanza pubblica per i prossimi anni. Nessun governo può accettare che un’unica leva di politica di bilancio assorba una quota così elevata di risorse, impedendo o almeno depotenziando altre forme di intervento. Figurarsi se poi questa misura viene ereditata dal governo Conte 2, oggi all’opposizione.
Le cose nate storte non si raddrizzano quasi mai. Si tagliano alla radice. E questo è l’unico errore imputabile al governo Meloni in materia. Ha cercato modifiche marginali che hanno avuto un modesto impatto su un treno lanciato in corsa ad alta velocità ed ogni volta cerca di aumentare la forza della frenata, sperando di riuscirci.
Ma quanto accaduto nel corso del 2023 – con previsioni di spesa sforate di oltre 50 miliardi – ci dà la dimensione della difficile controllabilità del fenomeno.
Intendiamoci, qui non si sostiene il vecchio mantra dell’austerità e dei “conti in ordine”. Al contrario, crediamo che la politica di bilancio debba essere strutturalmente espansiva, fino a quando non incontra limiti e colli di bottiglia nell’economia reale.
Tuttavia c’è modo e modo. E il Superbonus, anche con gli innegabili effetti propulsivi sul PIL, non può permettersi di dominare il ventaglio delle scelte a disposizione e non essere controllabile nei suoi effetti. Così si gestisce una salumeria – ci scusino i salumieri – non le finanze pubbliche di uno Stato che ha circa 2.000 miliardi di PIL annuo ed un rapporto debito/PIL del 137%.