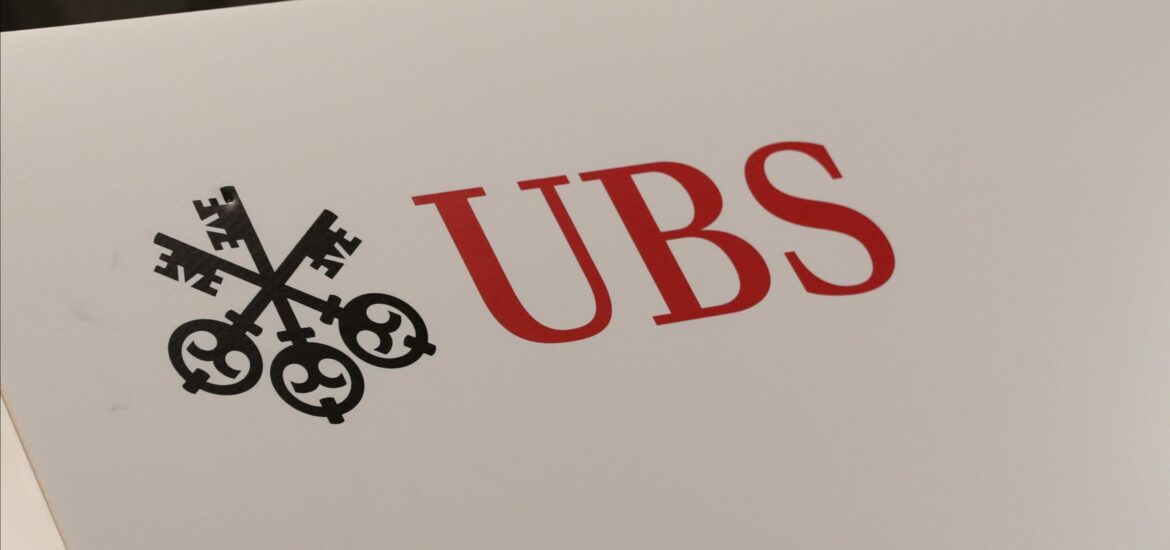La buona notizia è che, almeno in Svizzera, ci sono ancora dei giornali.
Nella conferenza stampa iniziata alle 19 e 30 di domenica 19 marzo, Festa del Papà, nel palazzo del governo federale a Berna si è celebrato il funerale della più antica e – se si può dire – antonomastica grande banca elvetica, non a caso denominata Credit Suisse, in sigla CS (Credito Svizzero in italiano e Schweizerische Kreditanstalt in tedesco, ma la versione francese è quella in uso; anzi era, visto che stiamo parlando di una defunta).
Officianti, il presidente di turno del Consiglio federale Alain Berset, la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter, il presidente della Banca nazionale svizzera Thomas Jordan, la presidente della Finma (l’autorità di vigilanza del mercato finanziario, una sorta di Consob elvetica) Marlene Amstad, il presidente del Credit Suisse Axel Lehmann e infine il presidente di Ubs Colm Kelleher.
Brevi interventi e alla fine qualche risposta alle domande dei non numerosissimi giornalisti invitati: una cerimonia composta, come si addice a un Paese che non ama l’enfasi e le tinte forti, quanto meno nella vita pubblica. Il messaggio non era altro che la sobria esposizione dei termini della soluzione finale individuata per una crisi di fiducia non più governabile, l’acquisto dell’intero capitale del CS, seconda banca svizzera da parte della prima, la Ubs. Per l’esecuzione immediata della compravendita il governo federale apprestava un quadro normativo di emergenza che attribuiva ai rispettivi consigli d’amministrazione il potere di deliberare, senza necessità di alcuna decisione delle assemblee dei soci, l’operazione. Operazione che – sottolineava il presidente Berset – sia il governo, sia l’istituto di emissione sia l’autorità di vigilanza avevano approvato con grande convinzione (lasciando così intendere di averla sostanzialmente imposta), all’evidente anche se non dichiarato scopo di assicurare la più ampia copertura politico-istituzionale agli organi amministrativi delle due banche interessate. Veniva ribadito che l’operazione era dovuta all’esigenza di prevenire il rischio di destabilizzazione non solo del mercato finanziario elvetico ma anche e soprattutto di quello internazionale, che la soluzione individuata era stata condivisa con le autorità monetarie degli Stati Uniti e del Regno Unito e che non c’era altro modo di fronteggiare la crisi nei ristrettissimi tempi concessi. Infine, con eroico sprezzo del ridicolo veniva detto e ripetuto che l’operazione era una transazione tra due soggetti privati.
Si diceva della stampa svizzera. Pur senza i caratteri cubitali che solitamente in quella nostrana suppliscono all’esiguità dei contenuti, la Neue Zürcher Zeitung di lunedì titolava in apertura “La Confederazione e la Banca nazionale salvano il Credit Suisse”. Di fianco il commento: “Uno zombi sparisce ma nasce un mostro”, dove si segnala il rischio che Ubs stia per diventare quasi un organo esecutivo dello Stato.
Il Corriere del Ticino sceglie un titolo d’apertura più evocativo (“C’era una volta il Credit Suisse”) ampiamente giustificato dal ruolo della banca nel processo di industrializzazione della Svizzera a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, e affida a un colloquio con Carlo Lombardini l’analisi critica dell’operazione di assorbimento del CS da parte di Ubs. Lombardini, avvocato di primo piano del foro di Ginevra e docente alla facoltà di diritto e scienze criminali dell’università di Losanna, specializzato in diritto bancario, non le manda a dire. “La cosa preoccupante”, spiega, “è che nessuno sa bene cosa ci sia nei libri contabili del Credit Suisse”, e proprio questa “cosa preoccupante” spiega l’iniziale reticenza di Ubs a impegnarsi nell’operazione, reticenza superata anche con lo stanziamento di 9 miliardi di denaro pubblico a copertura delle eventuali sopravvenienze passive che dovessero emergere (“rischi economici e giuridici che derivano da una diversa cultura d’impresa (…) che spinge l’appetito al rischio un po’ più oltre quello del settore” li chiama Lombardini).
Fin qui siamo nell’ambito del tecnico, ma la critica dello studioso ginevrino va oltre. Anzitutto segnala che oltre alla fuga dei depositanti c’era una realtà diversa: “Le altre banche internazionali non le davano più fiducia (al CS, ndr) e la evitavano come controparte”. In una situazione così compromessa – sembra di capire – il management dei CS avrebbe dovuto, quando quattro mesi fa annunciò un piano di risanamento, agire con più decisione: “In fondo è la mancanza di decisioni più severe ad aver portato il Credit Suisse a quello che è oggi. È tristissimo perché questo si tradurrà in tagli occupazionali ancora più gravi. Un vero e proprio bagno di sangue”.
Ci vorrà tempo per elaborare questo lutto, ammesso che ci si riesca. Già si sente parlare di regolamentazioni più stringenti ma a monte potrebbe esserci un problema di qualità del lavoro degli enti regolatori e della vigilanza. “Moltiplicare le regole”, obietta Lombardini, “non ci mette al riparo dall’incompetenza. Regole, inoltre, che rischiano di trasformare la vigilanza finanziaria in mero controllo giuridico e burocratico”.
Questa forse è la questione cruciale, che va oltre l’episodio, gravissimo ma pur sempre circoscritto, del Credit Suisse. Per quasi sessant’anni, dagli anni Trenta agli anni Novanta del secolo scorso, l’attività bancaria in gran parte del mondo capitalistico è stata regolata dal principio obiettivamente semplice, codificato nel Glass Steagall Act, della separazione della banca di credito ordinario dalla banca di investimento. Poi con la liberalizzazione, si è arrivati alla crisi finanziaria del 2008 e alle otto mila pagine del Dodd Frank Act dell’amministrazione Obama. Quel che è successo dopo è difficile da decifrare perché gli operatori del mercato si sono trovati ad agire in un contesto di domanda ininterrotta e crescente di strumenti finanziari e di denaro a costo zero. Ora il ritorno degli interessi passivi presenta il conto agli operatori con un eccessivo “appetito per il rischio” e lascia intravedere una scarsa efficacia dell’attività di vigilanza bancaria. Pensare subito a nuove regole può essere fuorviante e perciò pericoloso, perché già quelle esistenti non pare abbiano funzionato. La crisi del Credit Suisse si trascina da anni ma né l’autorità di vigilanza né la banca centrale sono riusciti neppure a controllarla, non si dice a prevenirla: se ancora oggi “nessuno sa bene cosa ci sia nei libri contabili del Credit Suisse”, vuol dire che negli ultimi due anni – da quando la crisi, rivelatasi terminale, del CS era conclamata – ha voluto o potuto guardare dentro a questi libri contabili, e la cosa si può spiegare solo in due modi: o la normativa rende di fatto impossibili questi controlli, oppure il personale dell’autorità di vigilanza è al livello del capostazione di Larissa.
La domanda è molto semplice: il ceto governante dei Paesi occidentali è in grado di formulare regole che funzionino o sa solo produrre testi nominalmente normativi, che hanno la prevalente funzione di intrattenere le opinioni pubbliche e non irritare gli interessi costituiti, creando un sovrappiù di oneri e intralci formali per l’unico ceto che non è in grado di far sentire la propria voce, quello dei cittadini?
Detto in altri termini, i governi contemporanei sono in grado di produrre normative efficaci come ai suoi tempi è stato efficace il Glass Steagall Act? Sono incompetenti o sono troppo deboli per imporre normative efficaci? Le autorità di vigilanza hanno il personale della qualità richiesta dai loro compiti?
Di sicuro, non è trattando qualsiasi privato cittadino che si avventuri ad aprire un conto in una banca come un potenziale padrino della mafia che si evitano i crack bancari.