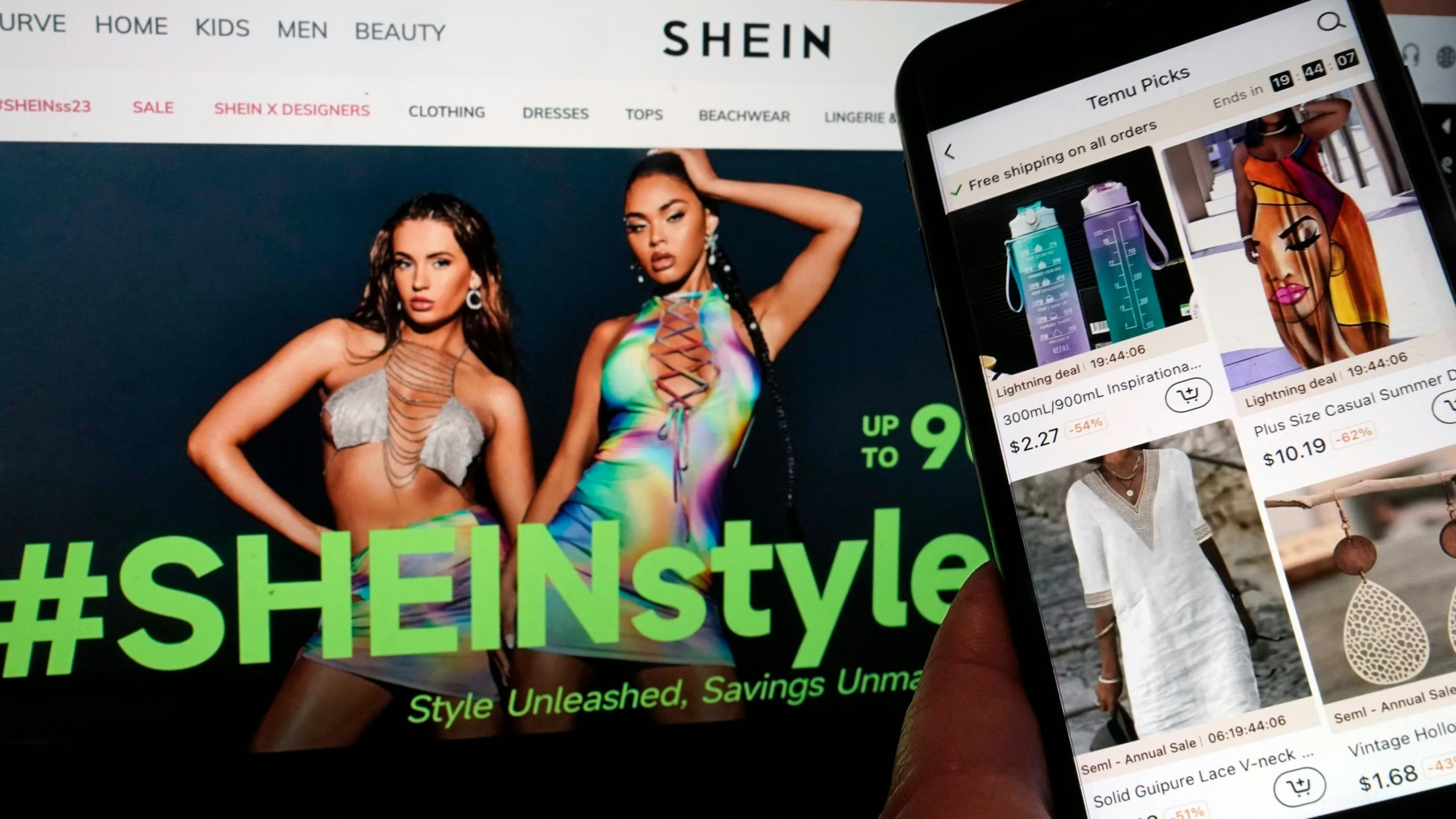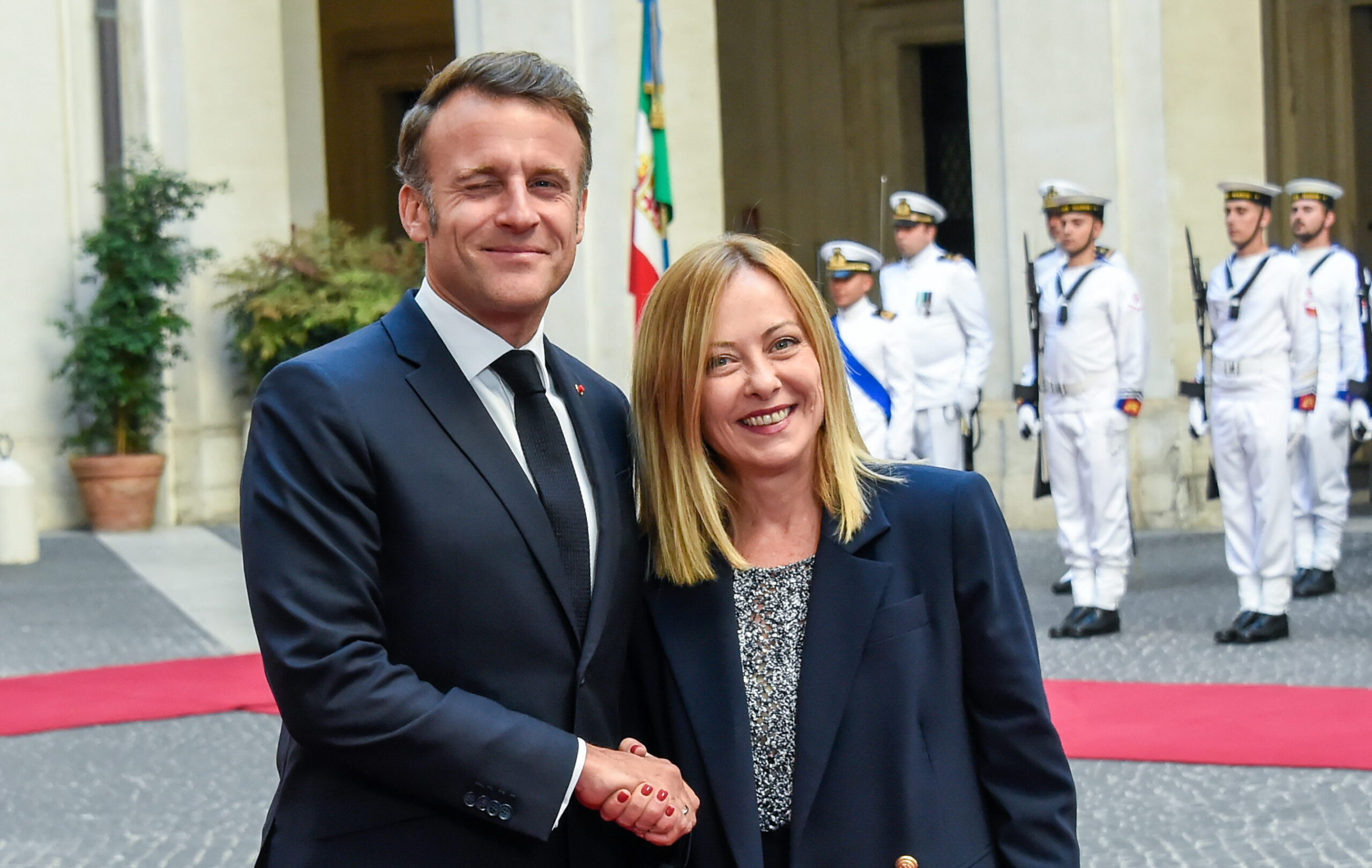Probabilmente quello che stiamo vivendo non passerà alla storia come il “secolo americano”. E non solo perché Donald Trump sta facendo di tutto per costruire un’immagine diversa da quella che si è affermata negli ultimi cento anni di storia. Ma per una ragione per così dire fisiologica. Gli Stati, al pari degli individui, nascono, crescono e poi deperiscono. Per cedere ad altri la leadership. Alla luce di questa legge generale è tuttavia vitale che questo stesso periodo non si trasformi nel secolo cinese o, ancora peggio, in quello russo. Per evitare che questo accada, l’intero Occidente deve scendere in campo e misurarsi con le proprie interne contraddizioni.
Il vecchio sogno americano, all’indomani della Global Financial Crisis, ha perso molte delle sue piume originali. L’economia è cresciuta ad un ritmo superiore rispetto agli anni precedenti, distaccando la stessa Unione Europea. Ma solo grazie ad una linea di politica economica e finanziaria che non trovava riscontro nelle esperienze passate. Quando alla forza intrinseca delle sue aziende si accompagnava una grande prudenza fiscale.
Dalla serie storica dei dati di bilancio, pubblicati dal CBO (Congressional Budget Office), l’organismo indipendente che sovrintende alle analisi di finanza pubblica, è facile vedere come quel percorso virtuoso in termini di deficit e di debito pubblico si sia interrotto proprio a partire dal posticipo della crisi. In precedenza, invece, gli Stati Uniti avrebbero potuto chiedere l’iscrizione onoraria alle regole del Patto di stabilità e crescita europea. Il deficit di bilancio, infatti, era risultato essere sistematicamente inferiore al 3%, con una media del 2,1% dal 1962. A sua volta il rapporto debito/Pil aveva avuto caratteristiche tedesche. Leggermente superiore al 60%, solo a metà degli anni ‘90. In precedenza (dal 1962) valori di gran lunga inferiori.
Al fallimento della Lehman Brothers, che fu il punto culminante della crisi, seguirono due anni di recessione. In cui si cercò soprattutto di ristabilire quel clima di fiducia che l’”euforia irrazionale” di quegli anni (copyright di Alan Greenspan, Governatore della FED) aveva devastato. Due furono i principali strumenti: una politica monetaria più che accomodante, con un “federal funds rate” che rimase imbullonato per ben 7 anni su un valore pari allo 0,25%; una politica di bilancio più che espansiva, al fine di evitare il diffondersi della crisi. Dal 2009 al 2013 il deficit di bilancio sarà pari in media al 7,5%, con punte del 9,8%, nel 2009.
Inevitabile il riflesso sull’andamento del rapporto debito pubblico/Pil. Nel 2008 quel rapporto era tutt’altro che preoccupante, fermo com’era a poco più del 60% del Pil. Ma già alla fine di quei due anni di crisi, in cui gli Stati Uniti avevano conosciuto gli effetti di una “crescita zero” (-2,6 nel 2009 e +2,7 l’anno successivo), il debito pubblico aveva compiuto un balzo di 20 punti, iniziando una rincorsa che non si sarebbe più fermata, fino a raggiungere, in pieno Covid, il 126%. Non più la frugalità tedesca, ma la preoccupante situazione italiana. Che potrebbe arrivare, secondo le previsioni del CBO, al 156,3%, nel 2055. Una sindrome giapponese, senza le caratteristiche del Giappone.
Dove la differenza? Soprattutto nel fatto che sebbene il debito pubblico giapponese abbia ormai raggiunto una dimensione stratosferica (237% nel 2024), i relativi titoli sono quasi esclusivamente nelle mani dei giapponesi. Da questi conservati e tesaurizzati, come se si trattasse, della bandiera nazionale. Gli Italiani sono stati un po’ da meno, considerato che una quota oscillante tra il 25 e il 35 per cento, nel periodo 2008/2024, è stato in mano ai non residenti. Nel caso degli Stati Uniti, invece, queste percentuali sono progressivamente salite, raggiungendo, il 30 giugno del 2024, secondo la tradizionale indagine campionaria, il 51,8 per cento del totale dei titoli emessi: 14,3 trilioni di dollari su un totale di 27,6. Un dato che bene illustra la fragilità finanziaria dell’intero sistema.
Lo scorso anno il debito complessivo – il federal debt – era all’incirca pari al 120% del Pil. Se le profezie, tragiche per la verità, del CBO dovessero manifestarsi, nei prossimi anni si assisterà a massicce emissioni di titoli da parte del Tesoro: in parte per compensare quelli in scadenza, in parte per far fronte alle nuove emissioni, dovuti alle maggiore esigenze finanziarie. Sarebbe comunque un problema relativo se il tasso risparmio, negli USA, fosse simile a quello europeo. Ma recenti ricerche della Commissione europea (European Economic Forecast – Autumn 2024, pag.29) dimostrano il contrario. Nel corso dell’ultimo decennio il tasso di risparmio europeo è stato pari in media al 12% del reddito disponibile, negli USA, è stato meno della metà.
Ed ecco allora una doppia fragilità. Un mercato dei titoli che cresce a macchia d’olio, una sempre maggiore incidenza di risparmiatori esteri, che non hanno alcun sentimento di identità con il Paese emittente. Pronti a disfarsi di quanto accumulato al variare della congiuntura economica o di quella politica. Come si è già verificato nelle settimane passate a seguito delle contraddittorie dichiarazioni dell’inquilino della Casa Bianca. Alle prese con una situazione più che disastrata.
Sempre a giudicare dalle proiezioni del CBO, il deficit di bilancio nei prossimi anni sarà difficilmente gestibile, per la sua intrinseca rigidità. Nel prossimo decennio, la previsione indica un deficit medio annuo di bilancio del 5,8% del Pil, le cui componenti principali saranno le spese per la difesa (in media il 2,7% annuo) e gli interessi sul debito, per il 3,6. La semplice somma di questi due diversi addendi porta ad un totale del 6,3%, che supera di 0,5 punti l’anno la prima preoccupante previsione. Soldi che al momento non si vedono all’orizzonte.
Dire che questa sorta di Caporetto finanziaria sia colpa di Donald Trump sarebbe del tutto ingeneroso. I mali della società americana sono più antichi e le relative difficoltà diffuse tra tutto l’establishment. Il che spiega, al di là dei mille svarioni tattici compiuti dai democratici, la facile vittoria elettorale del neo Presidente. Il quale avverte su di sé l’urgenza del fare, anche se poi non è altrettanto lucido nel vedere le possibili soluzioni. Anzi c’è il rischio concreto, come si è visto durante il periodo della sua “luna di miele”, che la sua politica possa far peggiorare la situazione non solo degli Stati Uniti, ma di tutto l’Occidente.
Trump ha bisogno di avere a disposizione maggiori risorse economiche: non solo per competere con il Resto del mondo. Ma per arrestare una deriva finanziaria, altrimenti destinata a trascinarlo chissà dove. La politica dei dazi, secondo questa impostazione, avrebbe dovuto essere la sua arma segreta. Ben vista dal suo elettorato, scottato dalla globalizzazione, l’idea principale non era tanto di natura commerciale, ma fiscale. Far pagare ad altri, con un balzello sulle importazioni, il costo del necessario risanamento finanziario. Risultato che sarebbe stato possibile se gli altri avessero semplicemente accettato di buon grado, senza reagire.
Ma così, com’era del resto prevedibile, non è stato. Anzi le modalità stesse che hanno accompagnato i primi passi di quell’azione, hanno mostrato un’arroganza, destinata inevitabilmente a generare azioni di rigetto. Che, alla fine, hanno anche oscurato le ragioni di una richiesta più che ragionevole. Quell’esigenza di un riequilibrio nei costi di una comune difesa, finora posta a carico di un solo Paese. Che da solo ha garantito quell’ombrello che, seppur giocato sul filo dell’equilibrio del terrore, ha garantito, per oltre 80 anni, una pace relativa. Oggi minacciata da logiche revansciste che rischiano di rimettere indietro l’orologio della storia.