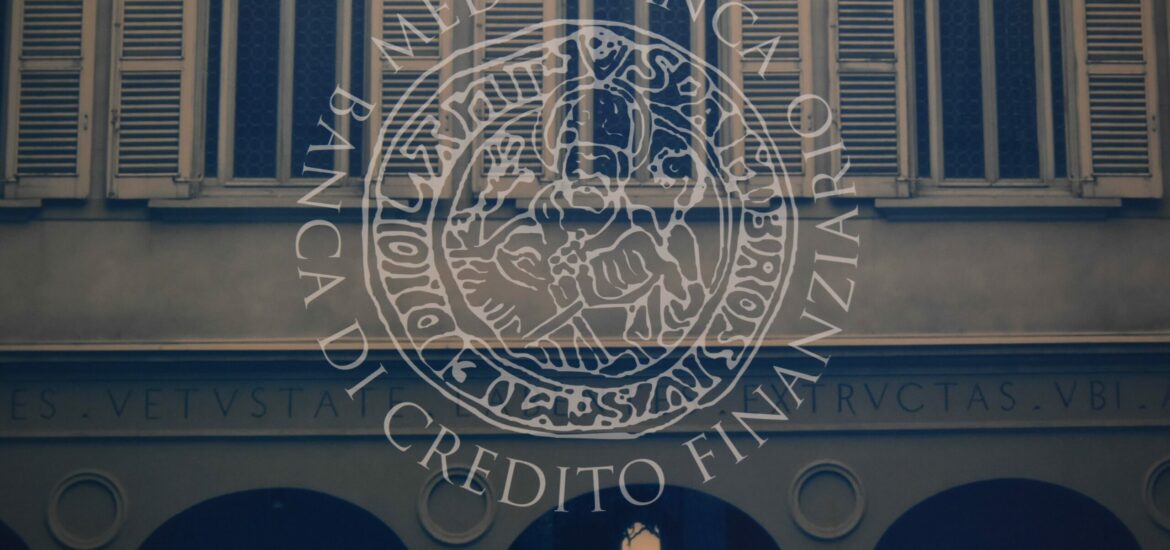Per chi non riesce ad orientarsi nel diluvio di commenti – spesso ispirati da interessi di bottega – sulla vicenda che vede i gruppi Caltagirone e Del Vecchio muovere (via Monte dei Paschi di Siena) alla conquista del controllo di Mediobanca e, probabilmente, anche di Generali, sotto lo sguardo benevolo del Governo, qui si offre una chiave di lettura, ovviamente opinabile, ma che ha solidi addentellati con la realtà.
Il filo rosso da seguire è la difesa del risparmio nazionale. Nel senso di adoperarsi, nei limiti del legittimo e del consentito, affinché l’azionariato di importanti competitor del settore bancario e del risparmio gestito, come MPS, Mediobanca e Generali resti saldamente in mano italiana. Non per banale campanilismo, ma per due essenziali motivi di equilibrio macroeconomico: in primo luogo si tratta di imprese molto profittevoli e il fatto che gli utili siano percepiti da soggetti non residenti, peggiora le partite correnti della bilancia dei pagamenti; in secondo luogo, le scelte di allocazione del risparmio privato, che tali imprese incentivano, possono favorire, ancor più di quanto già accade, strumenti finanziari emessi all’estero e quindi, ancora una volta, aumentare i profitti di soggetti stranieri.
Non è fanta-finanza ma è quanto sta già avvenendo da alcuni mesi e seguire il flusso dei soldi che entrano ed escono dal nostro Paese è uno dei metodi per capire cosa stia realmente accadendo all’economia italiana e perché è nell’interesse nazionale che l’industria del risparmio gestito resti, per quanto possibile, in mano di imprenditori italiani.
Quei flussi di denaro da e verso l’estero raccontano come gli investitori ogni giorno valutano l’Italia e il rapporto pubblicato venerdì 17 da Bankitalia ci rivela novità molto interessanti che si incrociano molto bene con il risiko bancario in corso.
Continuiamo ad essere un Paese esportatore netto di capitali che è l’altra faccia della medaglia di essere un Paese con un importante saldo positivo della bilancia commerciale e delle partite correnti della bilancia dei pagamenti. L’eccedenza di risparmio interno generata dal settore privato (famiglie e imprese) finisce in attività finanziarie sull’estero. Se il deficit pubblico fosse più ampio, grazie per esempio a maggiori investimenti pubblici, quel risparmio finirebbe in titoli pubblici, ma i vincoli della Ue lo impediscono.
Ma questa tendenza negli ultimi due anni ha subito un rallentamento e, al contempo, sono in significativo aumento gli investimenti degli stranieri verso strumenti finanziari italiani, con una sostanziale impennata negli ultimi mesi del 2024, che è il fatto nuovo che emerge dai dati Bankitalia.
L’Italia all’estero è tornata di gran moda. Investono in tutte le direzioni: azioni con finalità di controllo societario (i cosiddetti investimenti diretti), investimenti di portafoglio (investimenti con finalità puramente finanziaria), depositi presso banche residenti (classificati sotto “altri investimenti”) e, soprattutto, titoli del debito pubblico italiano.
Le cifre sono significative. Nei 12 mesi terminati a novembre 2024, tra investimenti diretti e di portafoglio sono entrati in Italia ben 178 miliardi (contro 117 dei 12 mesi precedenti e un deflusso di 45 miliardi nei 36 mesi precedenti). Di questi, 114 miliardi sono il flusso che è andato a favore di titoli pubblici, la cui consistenza in mano straniera era arrivata a 761 miliardi al 31 ottobre. Di rilievo anche gli acquisti di obbligazioni private e bancarie, per circa 41 miliardi.
Quegli acquisti di titoli italiani di sommano a quelli dei 12 mesi precedenti (36 miliardi) e concorrono a chiudere completamente la “fuga” che nel triennio 2020-2022 aveva portato gli stranieri a disinvestire 123 miliardi dai nostri titoli pubblici. In quegli anni la Bce è stato l’unico “sceriffo” sul mercato dei titoli pubblici italiani, ponendosi come compratore netto di gran parte dell’offerta dei nostri titoli.
Da metà 2023, quando la Bce ha cessato gli acquisti netti e i reinvestimenti, erano numerose le Cassandre che si chiedevano timorose cosa sarebbe accaduto alle emissioni del Tesoro. La risposta degli investitori è stata forte e chiara. Con la Bce e le banche in ritirata, ci hanno pensato gli investitori esteri e famiglie e imprese italiane (+44 miliardi nei 12 mesi terminati ad ottobre 2024) a comprare debito pubblico.
Quindi tutto bene? Non esattamente. Infatti, più attività finanziarie italiane in mano straniera significa più flussi in uscita per pagare interessi e dividendi. A questo fine, i tassi offerti sul debito pubblico italiano, da quando è partita a luglio 2022 l’ondata di rialzi, sono stati un decisivo elemento di attrazione, dato il rischio (modesto) percepito dai mercati.
E questo è diventato un elemento di debolezza per il nostro Paese, sotto un duplice aspetto. Da inizio 2023 è diventato negativo (10 miliardi e poi 14 miliardi nel 2024) il flusso annuo netto di pagamento di interessi e dividendi verso l’estero (redditi primari nella bilancia dei pagamenti). Questo ha significa un peggioramento non banale del saldo delle partite correnti che pur beneficiando del rinnovato saldo positivo della bilancia commerciale (+58 miliardi nei 12 mesi fino a novembre 2024, tornata ai livelli pre Covid), è decurtato dal flusso in uscita dei redditi primari.
Tale flusso negativo è ancor più preoccupante perché l’Italia continua ad avere una posizione netta sull’estero positiva per circa 265 miliardi a settembre 2024, cioè le attività finanziarie detenute dagli italiani all’estero sono superiori a quelle detenute dagli stranieri in Italia. Ciò che è cambiato molto è la composizione di queste attività, perché gli investimenti degli stranieri sono concentrati su attività più redditizie, basti solo pensare alle partecipazioni bancarie in Italia di Credit Agricole e Bnp Paribas e che producono dei redditi superiori a quelli delle attività finanziarie detenute all’estero dagli italiani.
Detto del ruolo del debito pubblico, è proprio nel settore bancario che si annida il problema. In questo settore, negli ultimi 12 mesi gli stranieri hanno accresciuto enormemente gli investimenti di portafoglio in partecipazioni azionarie e sono stati acquistati da non residenti circa 40 miliardi di azioni bancarie al cui seguito, ovviamente, fluiscono copiosi i dividendi. Questi flussi hanno peggiorato la posizione netta sull’estero (già negativa) di tale settore.
Movimenti che hanno peggiorato i nostri conti con l’estero e devono evidentemente aver suscitato qualche preoccupazione (non da oggi) dalle parti di Palazzo Chigi.
Nessuno potrà ovviamente confermare che, probabilmente anche per questo motivo, il governo da diversi mesi è attivamente impegnato nel riequilibrare la situazione recitando un ruolo attivo nel processo di concentrazione del settore bancario a favore di soggetti residenti.
Ma non c’è nulla di male, anzi, se il governo perseguisse anche questo fine.
In questo senso, suonano sospette le parole del Presidente Giorgia Meloni (“operazione di mercato”) e di Antonio Tajani, quasi una «excusatio non petita».
No, non è un’operazione di mercato. È ovviamente disciplinata dalle regole del mercato. Ma il governo non deve esitare e nemmeno vergognarsi di esercitare tutto il proprio peso come regolatore e come “Stato” portatore di uno specifico interesse (pubblico), affinché degli imprenditori nazionali mantengano in Italia degli importanti flussi di risparmio nazionale.
È lo stesso motivo per cui la Francia, pur avendo una bilancia commerciale in pesante passivo, riesce a compensarla parzialmente con un rilevante flusso in entrata di interessi e dividendi, possedendo all’estero (anche in Italia) alcune galline dalle uova d’oro. Gli investimenti esteri sono un’arma a doppio taglio, perché vanno remunerati e potrebbero ripartire con la stessa rapidità con cui sono arrivati.
Ecco perché sono importanti i risparmi nazionali. Non è per banale campanilismo ma per l’equilibrio finanziario del Paese.