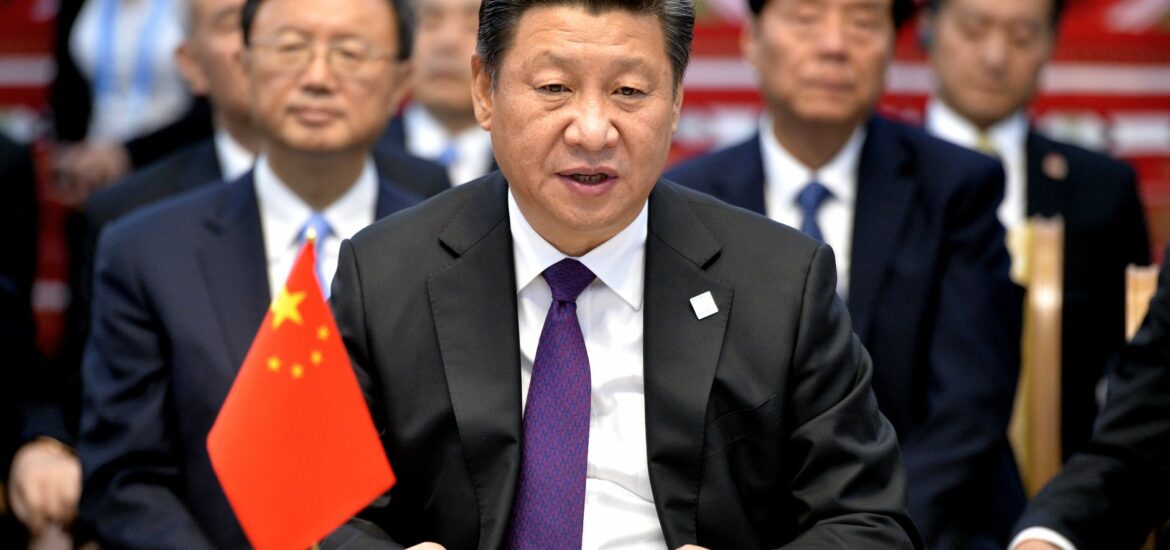Le reciprocal tariffs promulgate da Trump il 2 aprile 2025 costituiscono senza ombra di dubbio un profondo spartiacque nella storia del commercio internazionale, potenzialmente ponendo fine all’ordine fondato sul free trade che, in una forma o nell’altra, ha costituito un paradigma costante dell’economia internazionale dai tempi degli accordi di Bretton Woods, nel 1944.
La Cina è stata tra i principali beneficiari della globalizzazione a trazione statunitense verificatasi a partire dagli anni ’80. L’interconnessione economica con le economie avanzate è stato uno dei principali elementi abilitanti che hanno permesso alla Cina di svilupparsi e di creare un sistema produttivo all’avanguardia, oggi capace di competere con le impese occidentali anche in settori ad alto valore aggiunto tecnologico. La domanda allora è: cosa accadrà alla crescita economica cinese dopo che l’amministrazione Usa ha posto in essere dazi di proporzioni tali da ingenerare un vero e proprio decoupling tra le due economie?
La stessa scelta cinese di rispondere ai dazi statunitensi, ingaggiando una guerra commerciale, sottolinea la fiducia della Cina nella forza della propria economia, ritenuta capace di resistere al nuovo accentuato protezionismo degli Stati Uniti. Diverse contromisure possibili sono già state avanzate sia da membri del governo che da alcuni dei più importanti economisti cinesi . Tra le proposte principali rientrano:
• la diversificazione delle destinazioni dell’export, processo peraltro già da anni (almeno dal 2018) portato avanti dalle imprese cinesi;
• la stabilizzazione del mercato immobiliare, in calo ormai da circa tre anni;
• la creazione di fondi di investimento finalizzati alla tutela della performance dei mercati finanziari del Paese.
La nostra ipotesi è che la principale risposta della Cina ai dazi statunitensi sarà rappresentata dalla transizione verso un’economia incentrata sui consumi interni; questo sembra essere del resto il messaggio principale che è emerso dalle Due Sessioni del 2025 .
Tra le soluzioni proposte, infatti, questa soltanto ha la capacità di portare la Cina su un nuovo robusto percorso di crescita, le altre proposte essendo o più circoscritte nei loro impatti – come nel caso degli interventi sui mercati immobiliare e finanziario nazionali – o semplicemente insufficienti ad affrontare le problematiche macroeconomiche che oggi il Paese si trova di fronte.
Le imprese cinesi hanno infatti già da tempo iniziato a diversificare i mercati di destinazione dei loro prodotti, e risulta difficile immaginare un’espansione al di là di quanto non si sia già fatto. Un’eventuale espansione ulteriore potrebbe inoltre portare a nuovi conflitti commerciali con Paesi che si sentono minacciati dalla concorrenza delle imprese cinesi. Infine, da tempo economisti di vario orientamento sottolineano l’ancora insufficiente sviluppo del mercato interno della Cina, senza il quale la crescita cinese è destinata a rallentare anno dopo anno. Questo in conseguenza di rendimenti via via decrescenti sugli investimenti e delle crescenti difficoltà di accaparrarsi ulteriori quote di mercato una volta stabilita una presenza già molto significativa sui mercati esteri.
È quanto hanno sostenuto economisti quali Michael Pettis, secondo il quale lo scoppio della bolla speculativa nel mercato immobiliare cinese nel 2022 avrebbe segnato in maniera definitiva la bancarotta del modello di crescita export- e investment-led, portato avanti con tanto successo dalla Cina negli anni precedenti . La Cina odierna non ha affatto esaurito il proprio potenziale di espansione economica, ma perché questa possa continuare a ritmi sostenuti è necessario che il driver principale di crescita sia spostato dalla domanda estera alla domanda interna.
Non sarebbe la prima volta nella storia che la dinamica di sviluppo economico della Cina viene trainata dalla domanda interna. È interessante notare come Adam Smith, ne La ricchezza delle nazioni, contrapponga la “via europea” per lo sviluppo economico a quella “cinese”: Europa e Cina, sottolinea il fondatore dell’economia moderna, sono mercati di dimensioni paragonabili, ma che hanno raggiunto questa dimensione in due maniere opposte; da un lato, l’Europa ha seguito la strada più “innaturale e retrograda”, quella che vede nel raggiungimento della maturità economica del mercato interno un prodotto della crescita delle esportazioni; dall’altro, la Cina ha diretto i propri capitali “prima all’agricoltura, poi alle manifatture, e infine al commercio estero”, seguendo in questo modo il “corso naturale delle cose” .
Riformulando questi concetti in termini a noi più vicini, si può dire che esistano due strade di sviluppo economico, una che privilegia innanzitutto la domanda interna e solo in un secondo momento quella estera (la via “cinese” dei tempi di Smith), e una che si concentra prima sulla domanda estera e poi, con la ricchezza così accumulata, sulla domanda interna (la via “europea”).
La presente situazione dell’economia cinese si presta ad essere letta attraverso queste categorie, ma, per così dire, a parti invertite: la Cina, negli ultimi 50 anni, ha seguito la strada “europea” di sviluppo, accrescendo la propria ricchezza attraverso le esportazioni verso i mercati avanzati di Stati Uniti, Europa e Giappone; per continuare a crescere, l’economia cinese deve oggi – per ammissione della stessa dirigenza cinese – concentrare le proprie risorse in direzione dello sviluppo del proprio mercato interno. Il Paese andrebbe così a replicare – per una strana ironia della storia – il modello “europeo” di raggiungimento della maturità economica osservato da Adam Smith.
Tale transizione ad un nuovo modello di crescita costituisce nondimeno un processo complesso e dagli esiti tutt’altro che scontati. Mentre esistono molte ricerche che affrontano il tema del “sottoconsumo cinese”, non sono molte le analisi delle cause complesse che stanno dietro l’ancora insufficiente sviluppo dei consumi in Cina. Non è raro imbattersi in ricerche che sottolineano come nel post-pandemia la Cina abbia continuato a crescere sotto la spinta delle esportazioni, mentre i consumi interni e le importazioni hanno mostrato rilevanti segni di debolezza, ma ben poco viene solitamente detto sulle ragioni del ritardo della Cina nel realizzare l’obiettivo di un’economia maggiormente incentrata sulla domanda interna.
Obiettivo di questo lavoro è appunto quello di fare chiarezza sulle sfide che l’economia cinese dovrà superare per poter sviluppare un fiorente mercato interno, in ultima analisi l’arma principale che la Cina ha a disposizione contro la minaccia rappresentata dal rischio di politiche protezionistiche, da parte degli Stati Uniti in primis ma anche di altri partner commerciali di primo livello come l’Unione Europea.