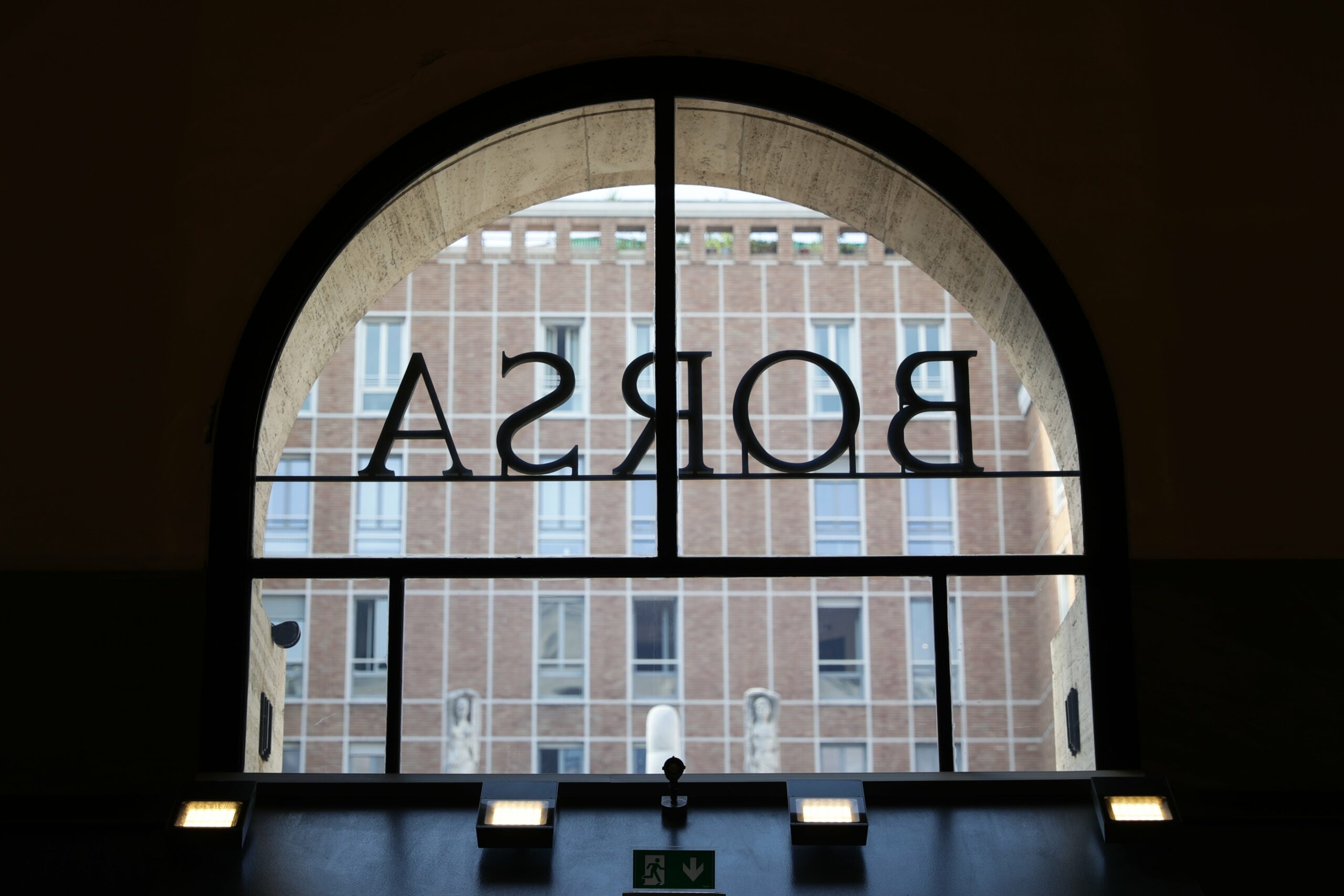È una riflessione che da tempo faccio tra me e me, e che ho faticato a decidere di condividere per timore di essere considerato cinico o peggio. Ma più vado avanti e meno sopporto le cascate di retorica che trasformano le morti sul lavoro in una messa in scena la cui sceneggiatura è sempre uguale e falsa, finalizzata a suscitare commozione, sdegno, rabbia, piuttosto che consapevolezza e responsabilizzazione.
Ho fatto il sindacalista tutta la vita e mi è capitato per due volte che in fabbriche che seguivo vi fossero infortuni mortali. So benissimo cosa provano non solo i familiari della vittima, ma anche i suoi compagni di lavoro, i sindacalisti e, di solito, anche i dirigenti dell’azienda. Nessun cinismo o protagonismo in quello che dirò, quindi.
LA NARRAZIONE EMOZIONALE DELLA “STRAGE”
Dico ciò che osservo: i media, i politici, il sindacato, il Papa si esaltano ad ogni incidente mortale, dove peraltro non è infrequente la morte di piccoli imprenditori , nel dipingere un martirio. In generale si presenta il fatto come “strage”: faccio notare che una strage postula uno stragista, la cui identità naturalmente non è manifesta ma allusa. La strage è ovviamente infinita e crescente: non è vero, ma di questo parleremo dopo. Ma l’emozione cresce: “i lavoratori sono sacri” ammonisce Papa Francesco ( ma i disoccupati o i pensionati non lo sono?). Su questa spinta emozionale nasce l’affermazione “non si può morire al lavoro”. Se accade andandoci al lavoro invece è meno grave? (anche su questo torneremo poi). Andando in vacanza invece è lecito morire? O andando a fare la spesa? O in ogni altra occasione in cui cause esterne dolose o colpose determinano la morte di qualcuno? Perché la vita stroncata da un incidente di chi sta viaggiando in macchina (la maggior parte delle morti per cause esterne verificate ogni anno nel Paese) indigna meno della morte di chi resta schiacciato sotto una macchina in fabbrica? Perché allora la morte del sig. Luigi sul lavoro suscita emozione ed esecrazione mentre se il Luigi viene investito da un tram mentre va al cinema è tutto sommato un fatto archiviabile?
COS’È IL LAVORO NELLA CULTURA ITALIANA
Credo che esista una risposta che si può evincere facendo una sintesi del messaggio emotivo di queste morti: sono morti “lavorando”. LAVORANDO. Questa parola ha il potere di suscitare una tempesta emozionale. Nell’immaginario collettivo italiano il “lavoro” è cosa contesa tra l’obbligo feudale e il riscatto del lavoratore. In tutt’e due i casi confina strettamente con l’assoluto. Il lavoro è percepito (e descritto) come una corveè inevitabile ma crudele. Da qui il rispetto compunto del quale è circondato e che è facilmente riscontrabile in popolari modi di dire: “ha dovuto andare a lavorare”, “lavorava per mantenere la famiglia”, o la diffusa scusa per evitare fastidi “sto’ a lavora’”, che illustra una sacralità del lavoro tale da non poter essere turbata da nessun richiamo terreno. D’altra parte l’aura di sacrificio di cui è circonfuso il lavoro ne propizia una visione trascendentale, per cui il lavoro è “riscatto”; meno retoricamente è l’essenza stessa dell’essere umano. Non a caso, creativamente, la Repubblica è “fondata sul lavoro”. Una sofferenza, un obbligo, che viene elevata a virtù massima. Si potrebbero fare molte discussioni sulla visione del lavoro nella cultura cattolica e in quella protestante, ma ci porterebbe troppo fuori.
Ciò che resta è, che per un verso o per l’altro, il lavoro in Italia non viene vissuto come una condizione normale, ma in qualche modo eccezionale. Il sentimento che trapela nei commenti alle morti sul lavoro lascia intravedere un giudizio sull’evento che si può sintetizzare così: “poveretto, già sopportava coraggiosamente di dover lavorare e poi anche questo…”. Questo fa capire perché se Luigi muore in fabbrica emoziona e chiama a reagire contro quella che viene vissuta come un’ingiustizia, mentre se muore sotto il tram no.
I NUMERI DELLE MORTI SUL LAVORO
Ciò detto per quanto concerne il sentiment che avviluppa le morti bianche, è anche opportuno fare qualche numero per rimettere i piedi nella realtà, premettendo che anche la morte di una sola persona è un evento inaccettabile: nel 1°semestre 2023 i morti per causa di lavoro sono stati 463, 13 in meno del 1° semestre 2022 e 32 meno del 2019 (non si fa il confronto con il 2020 perché ovviamente il Covid ha pesantemente condizionato i dati). Per il 2022 intero i morti sono stati 1090, di cui 300 per incidenti stradali. Sono dati non dissimili da quelli dell’Europa: nel 2021 (ultimo dato disponibile) il tasso di infortuni mortali in Italia è stato di 2,6 ogni 100.000 lavoratori, la media UE di 1,77, la Germania 0,86 ma la Francia 3,32.
Non solo: la mortalità è in costante calo: se ci si prende la briga di andare a consultare le serie storiche dell’Inail si osserva che nel 1951 i casi furono 3.511 (con un numero di lavoratori significativamente inferiore a quello attuale), ha poi toccato il massimo nel 1963 con 4.644 per arrivare a 1.104 nel 2008 e toccare il minimo storico nel 2022 (1.090). Non una strage sempre più grande, ma un male contro il quale si combatte con risultati tangibili. In Italia le normative sulla sicurezza del lavoro sono avanzate, e coinvolgono con responsabilità dirette anche il Sindacato. Se regole e procedure non vengono rispettate c’è soltanto da condannare responsabilità individuali, no da evocare scenari di inesorabile macello o di additare misteriose responsabilità del genocidio. Il punto è che dobbiamo avviare al più presto strategie e comportamenti concreti per ottenere una più netta inversione di tendenza in materia di infortuni sul lavoro.
Le morti sul lavoro devono essere combattute, con tutti i mezzi che la tecnica e la conoscenza mettono a disposizione, non essere evocate a dimostrazione spettacolare delle efferatezze del capitalismo o dell’inefficienza dello Stato.
IL RUOLO DEI SINDACATI
Last but not least: la L.626 e le norme successive istituiscono una precisa responsabilità (diritti + doveri) dei Sindacati nella vigilanza e codeterminazione dell’applicazione delle regole sulla sicurezza nelle aziende: magari meno appelli e slogan e un utilizzo più assiduo, preciso, rigoroso degli strumenti che ci dà la Legge?
Al proposito mi pare retorica, superficiale ed emotiva la proposta di istituire il reato di “omicidio sul lavoro” che ricorre nei discorsi del sindacato. Trascurando come essa riprenda in sindacalese un vezzo della cultura nazionale, per la quale è importante avere una legge ad hoc per ogni specifico crimine molto più che far funzionare quelle che già esistono, come se la catalogazione del reato fosse requisito indispensabile per reprimerlo, è opportuno notare che quando una Procura, a fronte di una morta bianca, aprisse un’indagine per omicidio cambierebbero natura anche le trascuratezze di chi avrebbe dovuto vigilare sull’applicazione rigorosa delle norme di sicurezza: non solo dirigenti dell’azienda e capi reparto, ma anche RLS e Organismi Sindacali che dovrebbero orientare e controllare l’attività. La tecnologia consente l’utilizzo di strumenti sempre più efficaci ma anche le cose più semplici potrebbero divenire di grande utilità se cogestite a livello aziendale. Per esempio l’uso delle telecamere, se riservata esclusivamente a fini di formazione, potrebbe aiutare a correggere comportamenti che mettono a rischio la sicurezza dei dipendenti.
Ancor più necessario sarebbe raccogliere e promuovere proposte come quella di introdurre nella scuola la cultura della sicurezza, anche per evitare che il lavoratore consideri la misure di sicurezza come una cosa che riguarda l’azienda o addirittura come una noiosa perdita di tempo.