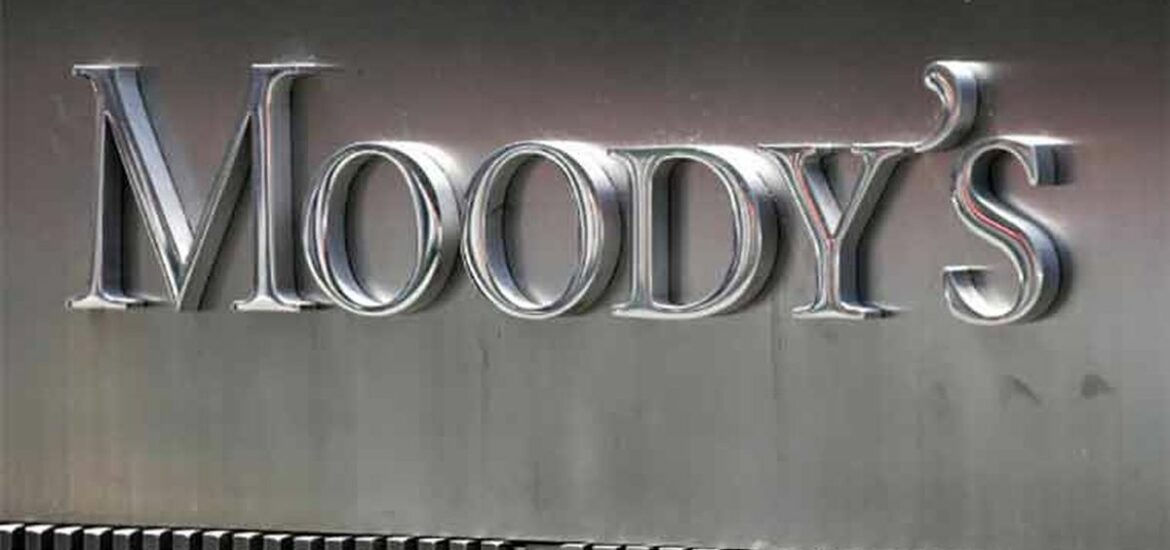Speriamo che l’ultimo verdetto di Moody’s sull’economia americana illumini gli scettici. Coloro cioè che considerano l’avventura di Donald Trump un semplice incidente della storia. E non il riflesso di qualcosa di più profondo che valga la pena di analizzare senza cedere al risentimento. I fatti sono, o almeno dovrebbero essere, noti. L’Agenzia ha declassato il rating della principale economia del Pianeta, portandolo da Aaa a Aa1, outlook stabile. Non doveva essere una sorpresa, considerato che lo scorso anno il giudizio era stato ugualmente severo. Il rating restava pari a Aaa, ma con outlook non più stabile, bensì negativo. In definitiva una mezza bocciatura. Rinviata quindi a maggio, l’Amministrazione non ha superato la prova di esami, ed il giudizio negativo non solo è stato confermato, ma peggiorato. Con grave scorno sui mercato: se si considera che quella tripla A risaliva al 1919.
A preoccupare ulteriormente è la sequenza dei giudizi negativi. Il downgrade di Moody’s segue quello dell’agenzia Fitch nell’agosto 2023, anch’esso di un gradino. S&P aveva già tolto il rating massimo agli Usa dopo la crisi del tetto al debito del 2011. Difficile pertanto poter imputare a Mark Zandi, economista di Moody’s Analytics, come ha fatto Steven Cheung, che è il Capo della comunicazione della Casa Bianca, un atteggiamento pregiudizialmente ostile. Il quale, in un post pubblicato su X, subito dopo l’emissione del verdetto, aveva chiosato: “Mark Zandi, l’economista di Moody’s, è un consigliere di Obama e un supporter dei Clinton. È stato sempre un sostenitore del ‘Mai Trump’ dal 2016. Nessuno prende sul serio le sue ‘analisi’. Essendosi sbagliato più e più volte”.
Il linguaggio, come si può osservare, è quello tipico della nuova Amministrazione. Con alcune ulteriori aggravanti. Mark Zandi lavora per Moody’s Analytics e non per Moody’s Ratings, cui spetta il compito esclusivo della valutazione inerente al rating. Quindi bersaglio sbagliato. Ma se pure fosse vero il pregiudizio, come rispondere non solo a Moody’s, ma sia a Fitch che a Standard & Poor’s, che in precedenza si erano espressi sulla stessa lunghezza d’onda. E se poi si volesse evocare una sorta di complotto di tutte le agenzie di rating, come era avvenuto in Italia per i fatti del 1911, che dire, allora, delle valutazioni del CBO (Congressional Budget Office) organo di garanzia massima, negli USA, per quanto riguarda gli andamenti di finanza pubblica?
La critica di Moody’s, riguardava essenzialmente la dinamica del debito. Secondo le sue previsioni il debito/Pil salirà al 134% entro il 2035, rispetto al 98% del 2024. Secondo il CBO il suo sviluppo tendenziale porterà, per quell’anno, il valore del debito pubblico trattenuto dai privati al 118,5 % del Pil; mentre il debito federale sarà pari al 135,5%. Perfetta coincidenza. Del resto le previsioni non sono poi così difficili. Il declino dei parametri finanziari degli Stati Uniti è sotto gli occhi di tutti. In quel lungo periodo che va dal 1962 al 2008 (45 anni) il deficit del bilancio pubblico americano era stato pari, in media, al 2,1 per cento l’anno. A partire dalla Global Financial Crises del 2007/2008 e fino al 2024 quello stesso deficit era cresciuto al 6,4 per cento, in media l’anno. Dando la stura ad una corrispondente crescita del debito sul Pil. Nel 2008 il debito posseduto dai privati era pari al 39,2% del Pil. Nel 2024 aveva raggiunto il 97,8. Quasi tre volte tanto.
Donald Trump, nella sua corsa trionfale verso la Casa Bianca, non si era mai soffermato sulle conseguenze della crisi, che aveva portato al fallimento della Lehman Brothers, e che dal continente americano si era riversata sull’intero Pianeta. Per la verità, ancora oggi, se si escludono alcune pioneristiche iniziative, come la colossale opera di Adam Tooze (Crashed – How Decade of Financial Crises Changed the World), su quel groviglio di problemi si è poco riflettuto ed ancor meno investigato. Una grave omissione. Le conseguenze di quella crisi, originata dalla cupidigia di Washington (mai dimenticarlo!) fecero, infatti, da sponda e si sommarono con una serie di avvenimenti politici destinati a cambiare il volto della geopolitica mondiale.
L’aumento del rischio sistemico, legato all’investimento estero, comportò un forte rientro dei capitali investiti in precedenza. La Russia di Putin ne fu una delle vittime principali. Generando nella testa del nuovo Zar l’idea che il capitalismo non era quell’Eden descritto nei libri d’economia. Meglio allora tuffarsi nel passato per riscoprire le virtù di Santa Madre Russia e le sue vocazioni imperiali. L’invasione della Georgia, proprio nel 2008, ne fu la prima conseguenza. Successivamente, in un Medio Oriente sconvolto dall’inflazione soprattutto relativa ai generi alimentari (il pane), alimentata da quella stessa crisi, i Fratelli mussulmani ottenevano la loro rivincita contro le varie oligarchie locali. Dando luogo a quel movimento revanscista destinato, sempre più, ad avere le caratteristiche della jihad islamica. Di fronte ad un Occidente distratto ed impaurito da avvenimenti che non riusciva a comprendere, nel 2014, Putin ritenne, pertanto, fosse giunto il momento per rivendicare il possesso della Crimea, sottraendola al legittimo titolare. Vale a dire l’Ucraina . Otto anni dopo, all’indomani della dura prova contro il Covid – il morbo destinato a colpire soprattutto le aree più globalizzate – ed il bruciante ritiro dall’Afganistan, prese corpo l’invasione della stessa Ucraina, con l’evidente obiettivo di ritornare ai vecchi splendori della Russia zarista prima e di quella sovietica poi.
Se si analizza la sequenza di quegli avvenimenti è facile vedere in controluce la debolezza dell’Occidente. Profondamente diviso, attestato su linee di politica economica divergenti, non poteva non prestare il fianco ai nuovi e ai vecchi nemici. La cui potenza economica, finanziaria, tecnologica e militare era nel frattempo cresciuta grazie soprattutto ad una governance libera dai condizionamenti della democrazia. Capace di imporre scelte di potenza ai danni di un popolo da sempre sottomesso. Nella logica di produrre cannoni al posto del burro. Di fronte a queste sfide l’Occidente è stato incerto. Ci sarebbe voluto una grande pazienza ed una più forte determinazione per riannodare fili spezzati, contrastare vocazioni mercantilistiche, contribuire ad imporre, specie nei Paesi leader della UE, quei cambiamenti di politica economica che solo oggi, grazie a Friedrich Merz, si intravedono all’orizzonte. Ma allora il timone era ancora in mano ad Olaf Scholz: una delle più scialbe figure della SPD tedesca.
Donald Trump ha invece scelto un’altra strada. Quella della forza, del diktat che le complesse vicende internazionali hanno sempre trasformato in una sorta di penultimatum. Altro che grande negoziatore! Ad ogni sua mossa il mercato ha risposto in modo opposto e contrario. Dal crollo in borsa dei titoli azionari, alla caduta del dollaro sui mercati internazionali, alla crescita dei tassi di interesse sull’enorme debito pubblico accumulato. Fino all’ultimo episodio costituito dal verdetto di Moody’s. Che, come ricordato in precedenza, ha una valenza storica incontestabile. Gli Stati Uniti, checché ne pensi Trump, sono un’economia aperta che non può essere isolata alzando ponti levatoi. Rispetto all’UE, come ha ricordato Mario Draghi, il peso del commercio estero sul Pil è di gran lunga inferiore. Circostanza che ha generato l’illusione di una possibile sorta di autosufficienza in grado di consentirle di poter sostenere qualsiasi guerra commerciale. Ma questo è solo un aspetto del problema.
Il lato oscuro di quella forza è dato dagli assetti finanziari complessivi. La sua crescita economica e tecnologica è stata resa possibile da un continuo trasferimento di capitali. Da un drenaggio di risorse che ha riguardato il mondo intero. Flussi che possono trasformarsi rapidamente in hot money e riprendere la strada da cui erano venuti. L’aspetto più delicato della questione riguarda proprio il debito pubblico. I cui titoli, secondo le stime più recenti, sono posseduti per il 52% da risparmiatori residenti all’estero. I quali, se troppo intimoriti da politiche non convenzionali, reagiscono come sempre hanno fatto gli investitori di tutto il mondo. Vendono i loro assets per rifugiarsi in porti più sicuri. Dopo il verdetto di Moody’s, il barometro sembra destinato a segnare tempesta. Con quali conseguenze sugli assetti complessivi di finanza pubblica non è difficile immaginare.