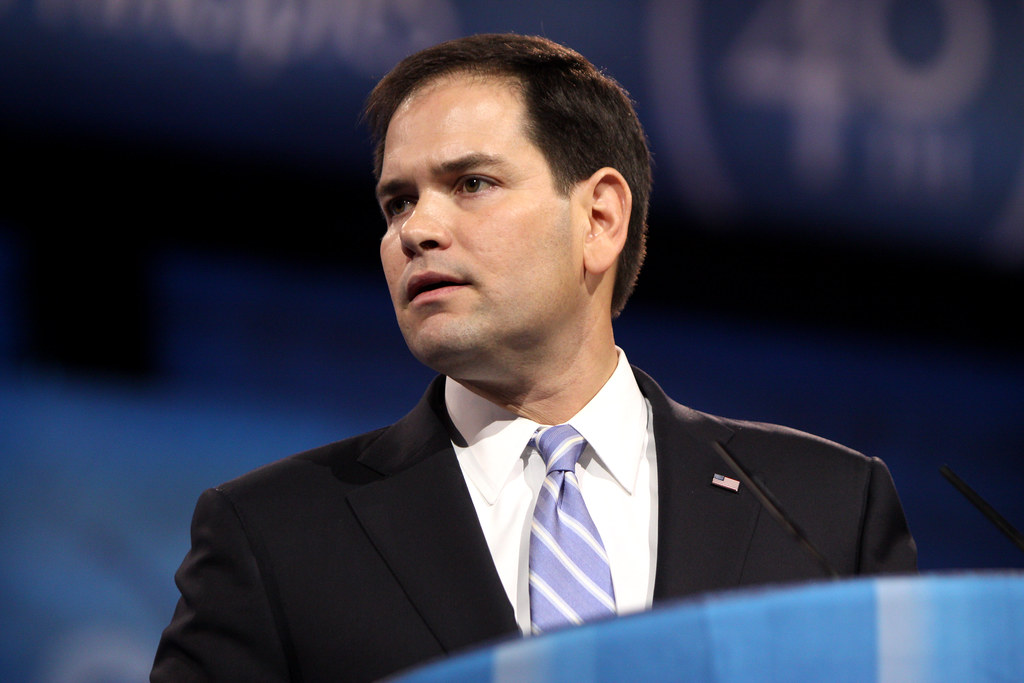È passata in prima lettura in Senato la riforma dell’autonomia differenziata, il ddl Calderoli, che, nelle intenzioni dei legislatori, vuole ampliare il bacino di materie che possono essere decentralizzate in favore delle Regioni. La riforma Calderoli è passata con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 30 astenuti e ora passa al vaglio della Camera. La maggioranza vorrebbe arrivare a un’approvazione entro il prossimo giugno, quando si terranno le elezioni europee.
IL SENATO HA APPROVATO LA RIFORMA CALDEROLI SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Il Governo ha presentato la riforma dell’autonomia differenziata come un secondo tempo della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 che, modificando l’articolo 116, stabilì che le Regioni ordinarie potessero richiedere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. La riforma Calderoli prevede che le Regioni possano chiedere fino l’autonomia legislativa fino a un massimo di 23 materie, dalla tutela della Salute all’Istruzione, Sport, Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero, mentre non c’è un numero minimo.
I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E SOLIDARIETÀ
Il disegno di legge 615 presentato dalla maggioranza recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” vuole “dare seguito al processo virtuoso di autonomia differenziata già avviato da diverse Regioni italiane secondo il dettato costituzionale e in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà, in un quadro di coesione nazionale”, come spiegato dalla Premier Meloni. A partire da queste considerazioni l’esecutivo ha impostato il suo lavoro su due direttrici:
- la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
- la presentazione alle Camere di un disegno di legge per l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
COSA SONO I LEP E PERCHÈ SONO CENTRALI NELLA RIFORMA DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA
I Livelli Essenziali delle Prestazioni sono gli standard minimi di servizio indispensabili per dare attuazione ai “diritti sociali e civili” tutelati dalla Costituzione. I Lep servono, dunque, a garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale. La legge quadro prevede la preventiva individuazione dei Lep per istruzione, ambiente, sicurezza sul lavoro, ricerca scientifica e tecnologica, salute, alimentazione, ordinamento sportivo, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e navigazione, comunicazione, energia, e beni culturali. Sono ancora molti i settori in cui i Lep non sono stati definiti, dai servizi sociali al trasporto locale, ma questo prescinde dall’introduzione della riforma dell’autonomia differenziata.
“Livelli essenziali delle prestazioni avrebbero dovuto essere garantiti a prescindere dall’autonomia differenziata, questo è il dato che bisogna avere presente – ha detto il giurista e costituzionalista Giovanni Guzzetta -. Il problema dei Lep è un problema che si pone indipendentemente dall’autonomia differenziata e che si pone da 22 anni. La Corte costituzionale in un numero oramai considerevole di sentenze ha sottolineato, più volte, che lo Stato ha l’onere di definire i Lep, cosa che, a parte per alcuni settori, non è mai stata fatto. A parte il settore sanità, dei servizi sociali, quello, embrionale, degli asili nido e qualche altro settore, i livelli essenziali non sono mai stati definiti”.
COS’È IL CLEP E CHI NE FA PARTE
La Legge di Bilancio 2023 ha affiato il compito di definire i Lep a una cabina di regia presieduta dalla premier Meloni, con delega al ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. La cabina di regia lavora sulla base dell’istruttoria svolta dal Comitato guidato dal giurista Sabino Cassese. Lo scorso marzo, infatti, il Governo ha istituito il CLEP, il Comitato incaricato di “stabilire nel concreto i costi e i fabbisogni di ciascuno dei servizi pubblici, in supporto alla Cabina di Regia governativa per le Autonomie regionali differenziate”. Il CLEP era formato da 61 “saggi”, personalità di spicco dell’accademia italiana, e presieduto dal giurista Sabino Cassese.
Tra i membri del CLEP ci sono: Ignazio Visco, governatore Banca d’Italia, Paola Severino, presidente Scuola nazionale dell’amministrazione, Guido Trombetti, ex professore di analisi matematica, Giovanni Guzzetta, ordinario di diritto pubblico, Pier Luigi Portaluri, ordinario diritto amministrativo, Lorenza Violini, ordinario diritto costituzionale e Valerio Di Porto, consigliere per l’autonomia differenziata e il Pnrr del ministro per gli affari regionali. Del CLEP facevano parte anche gli ex presidenti della Corte Costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, l’ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e l’ex ministro della Funzione Franco Bassanini, ma lo scorso luglio si sono dimessi.
LA ROAD MAP DELLA CABINA DI REGIA PER LA DETERMINAZIONE DEI LEP
La Cabina di regia provvederà a una ricognizione del quadro normativo, nazionale e regionale, e all’individuazione delle materie o degli ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni che hanno a che fare con i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. A seguire saranno determinati i livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nelle materie previste dal terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione (quello che la riforma dell’autonomia differenziata va a modificare). Al termine di questo iter, entro un anno, la Cabina di regia predisporrà uno o più dpcm attraverso i quali determinare i Lep.
Infine, entro aprile 2026 il Governo dovrà aver definito il quadro normativo di riferimento per procedere all’individuazione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. La Cabina di regia avrebbe dovuto terminare i propri lavori a fine 2023, ma il Milleproroghe le ha dato un altro anno di tempo. Il Ddl Calderoli prevede una delega al Governo per definire i Lep con decreti legislativi entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge.
LEP: I RISCHI DI MAGGIORI COSTI
La definizione dei Lep potrebbe portare ad aggravi economici per i conti dello Stato. Del resto, le attuali differenze territoriali nell’erogazione dei servizi lasciano immaginare che la ricerca di uniformità sia accompagnata all’aggravio dei costi. “Non si può pensare che da un giorno all’altro i Lep vengano assicurati – ha osservato il giurista e presidente del CLEP Sabino Cassese – perché per assicurarli occorre che siano accompagnati da cifre. Occorre prevedere un quadro pluriennale così che quelle risorse vadano a colmare le lacune riscontrate”. Come scrive “La Voce”, sul punto la riforma non è molto chiara. “L’articolo 4 del disegno di legge stabilisce “che qualora dalla determinazione dei Lep (…) derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento”. Al contrario, l’articolo 8 al primo comma dice che dall’applicazione della legge e delle conseguenti intese “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e infine, al terzo comma, che è garantita “l’invarianza finanziaria (…) per le singole regioni che non siano parte dell’intesa”.