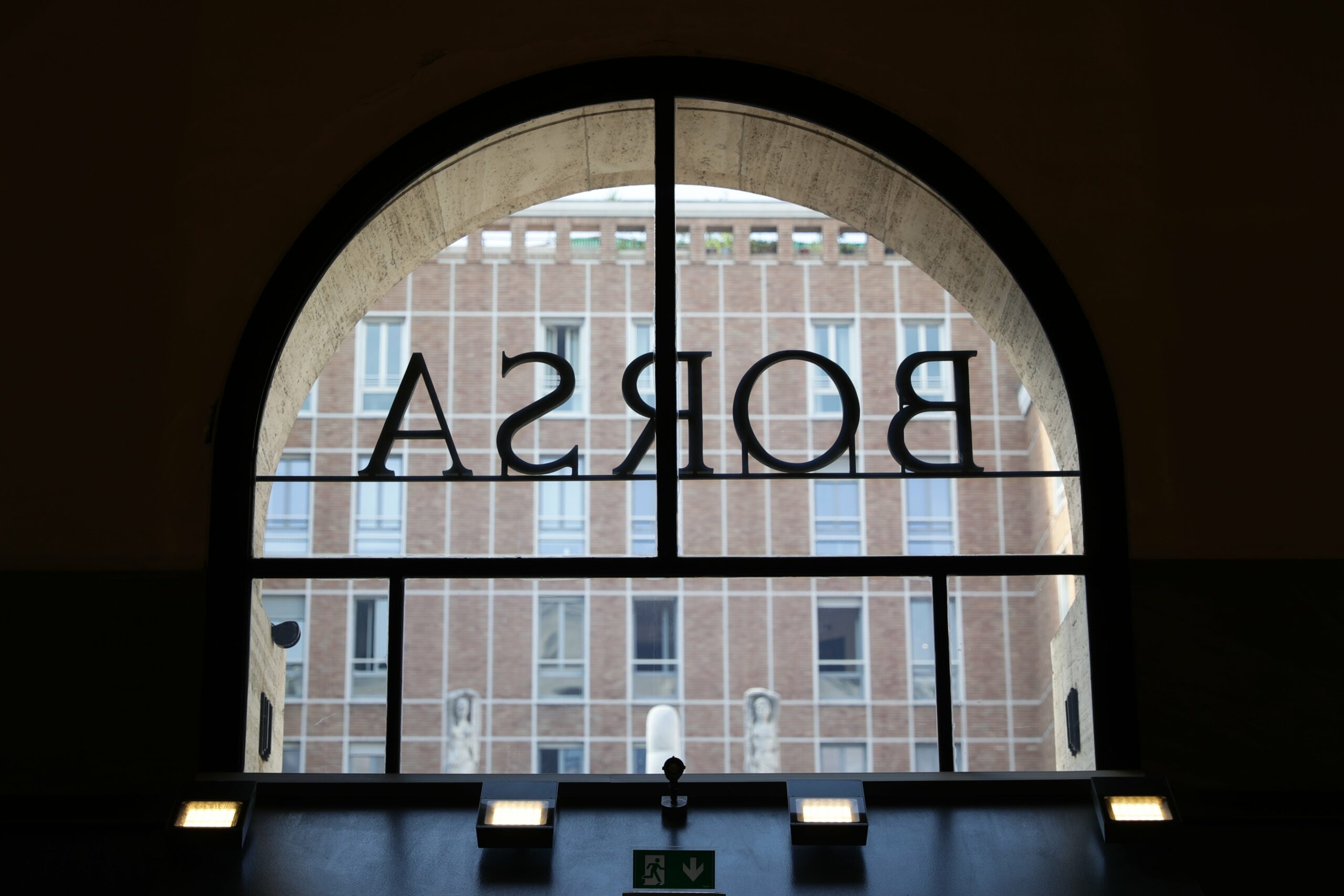Santorini è soltanto l’ultima meta turistica ad aver deciso di proteggersi e tenere lontana la massa dei visitatori, segue una lunga lista di località – le Cinque Terre, Venezia, l’Everest… – che hanno adottato misure simili di fronte all’insostenibilità, stavolta il termine è pienamente rispondente, di eccessive quantità di persone che si concentrano in uno stesso spazio e nello stesso tempo. Il fatto è semplice e oggettivo: se il numero di automobili che si infilano nelle ristrettissime e tortuose stradine della costiera amalfitana oppure di persone che pretendono di percorrere la Via dell’Amore o fare ingresso agli Uffizi è eccessiva si crea un imbuto, un tappo, una fila con rallentamenti esasperanti.
È l’esito di un processo che rimonta a parecchi decenni fa, il turismo di massa che ha come concause sul piano economico l’aumento della disponibilità di sempre più individui, non soltanto del cosiddetto mondo avanzato, che possono permettersi di girare per il globo terracqueo, incrociata con il diffondersi di alcuni sistemi, peraltro in crisi, che abbassano il prezzo dell’offerta per andare incontro alla domanda crescente. Ma il dato più significativo è quello culturale: con più soldi e più mezzi arrivano anche più bisogni, più desideri. E quello di vedere il mondo è uno dei più istintivi, primordiali.
I viaggiatori ci sono stati sempre: pellegrini, intellettuali, esploratori. Soltanto che finché si trattava di limitate élite, chi andava da un posto all’altro poteva anche sbagliare strada o addirittura andare in direzione opposta a quella prevista, scoprendo così nuove rotte e nuovi continenti. Oggi invece la coazione a ripetere si basa su modelli assolutamente globalizzati, tutti vogliamo scattare esattamente lo stesso selfie nel posto dove lo hanno fatto migliaia di persone prima di noi, mostrandocelo sui social. E quindi mete estreme, ghiacci polari, vette sempre più alte, destinazioni esotiche che un tempo avremmo considerato soltanto in caso di una deportazione punitiva, nelle quali troveremo soprattutto caldo asfissiante e condizioni igieniche improbabili.
La curiosità è che si contrasti il turismo di massa con misure limitative e dissuasive, nel consenso pressoché generale, mentre quando si propone di frenare i movimenti migratori insorge una vibrante opposizione, che difende il diritto di recarsi nel posto dove si vive meglio. Facile dire che questa è una necessità da rispettare, se non addirittura da assecondare, mentre quella di muoversi per piacere, diletto e diporto, è un’aspirazione opzionale e quindi rinunciabile. Ma le cose non stanno affatto così ed entrambi gli spostamenti rispondono ad un’unica logica, quella dell’auspicio trasformato in diritto, della pretesa o illusione che le condizioni naturali e di nascita siano accessorie e che ciascuno di noi possa essere chi, come e dove vuole.