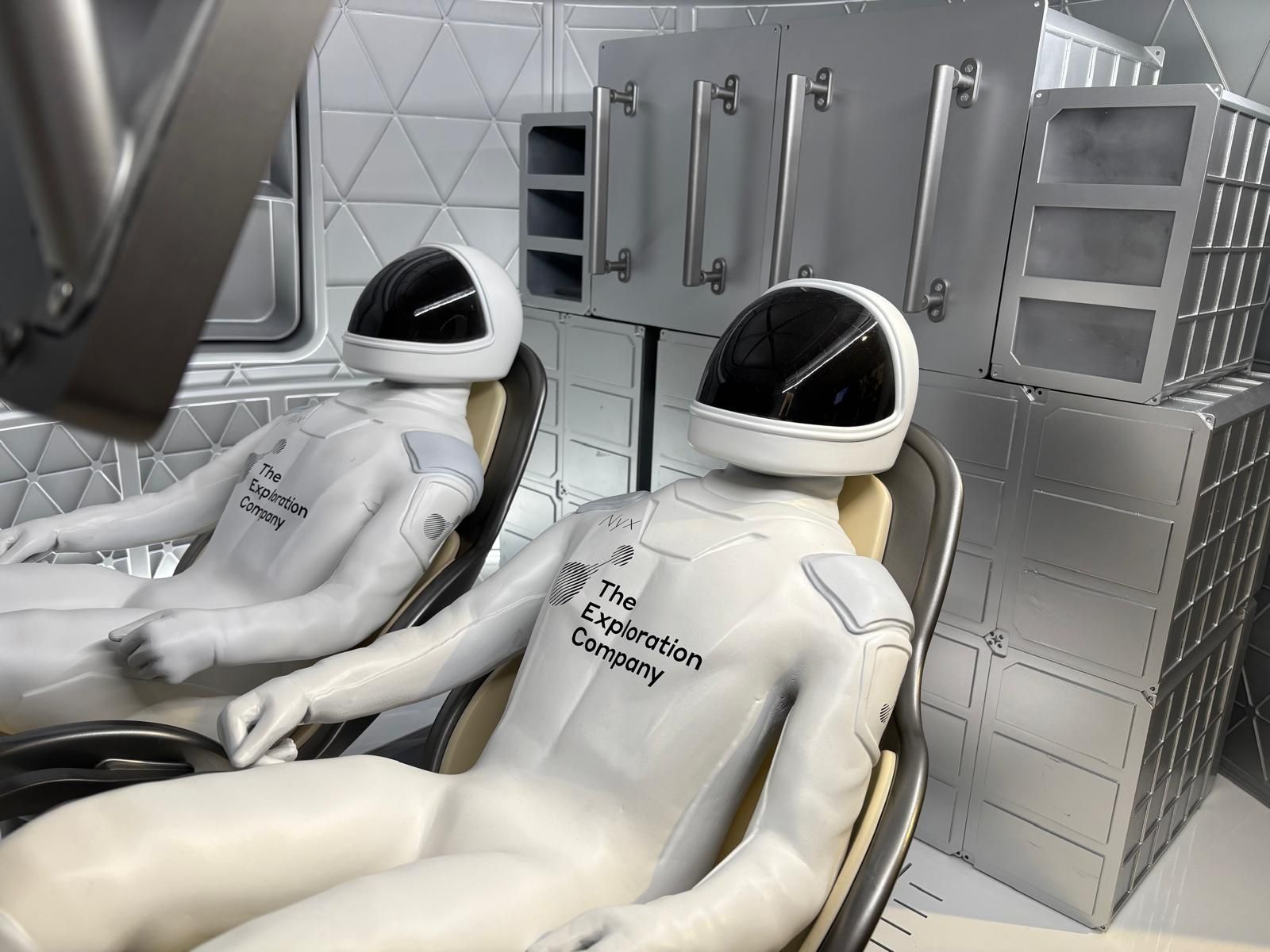Roma, città eterna, ma anche città santa. Fino al sedicesimo secolo, i suoi confini erano disegnati non soltanto dalle mura, ma dalle rogazioni. Introdotte da Papa Leone III (795-816), erano cortei di preghiera e penitenzali che delimitavano simbolicamente il perimetro inviolabile della sede apostolica. Ancora alla fine del Quattrocento, Savonarola l’aveva definita “la meretrice di Babilonia”. Pochi decenni più tardi era diventata “la nuova Gerusalemme”, centro della cristianità e delle attese millenaristiche di una Chiesa trionfante. La presenza degli ebrei, paragonati da Paolo -nelle Lettere ai Corinzi e ai Galati- al lievito che può guastare l’impasto, non rischiava perciò di corrompere il “sacro corpo” della città? Per placare l’inquietudine dei veneziani, nel 1516 la Serenissima aveva creato il primo “serraglio de’ giudei” della storia a Cannaregio,in una minuscola isola della parrocchia di San Girolamo. L’isola aveva ospitato una fonderia di cannoni e campane, chiamata “getto” (dalla gettata di metallo fuso). Nella pronuncia degli ebrei ashkenaziti di origine tedesca, priva di vocali dolci, diventerà “ghetto”.
Quarant’anni dopo, nel luglio del 1555, con la bolla “Cum nimis absurdum” Papa Paolo IV (1555-1559) ordinava la creazione di un ghetto anche a Roma. Racchiuso nel rione Sant’Angelo, già abitato da quasi tutti gli ebrei romani, aveva una superficie inferiore a tre ettari di terreno. La sua area, esposta alle frequenti inondazioni del Tevere, era attraversata da vie strettissime e case anguste accatastate una sopra l’altra: un vero e proprio alveare umano. Un malinconico spettacolo, lo definirà ancora nel 1853 Ferdinand Gregorovius nei suoi “Ricordi storici e pittorici d’Italia”: “Le donne ebree stanno sedute sulla porta delle loro abitazioni, o nella strada stessa, imperocché nelle loro stanze, basse e oscure, mancano di luce, e ivi stanno assiduamente occupate nello scernere cenci, o nel cucire o fare rappezzi. È incredibile il caos […]”. Del ghetto originario non è rimasto nulla, se non il suo significato: uno spartiacque traumatico nella vicenda della più antica comunità capitolina. Una sua magistrale ricostruzione si deve alla ricerca archivistica di Kenneth Stow, studioso eminente dell’ebraismo. Finalmente disponibile in italiano grazie a una meritoria iniziativa editoriale, proviamo a ripercorrerne qualche passaggio (“Il ghetto di Roma nel Cinquecento”, Viella Libreria Editrice, 2014) .
Gli ebrei, tra cui i venti-trentamila stanziali a Roma già dal secondo secolo a.C. (sostenitori di Giulio Cesare e invisi a Cicerone), nell’età imperiale vengono organizzati in “collegia”, strutture giuridiche con diritti corporativi, incluso quello di ereditare proprietà. Tali diritti saranno aboliti dagli imperatori cristiani, tra la fine del quarto e l’inizio del sesto secolo. D’altro canto, gli ebrei non perderanno mai lo status di cittadini romani sancito nel 212 da un editto di Caracalla, che proibiva di trattarli in modo arbitrario e garantiva la libera professione del giudaismo. Così, attorno al 600, papa Gregorio Magno dispone che venissero risarciti per i beni comunitari loro confiscati, ma senza obbligo di restituzione. Il provvedimento gregoriano fissava un principio che rimarrà in vigore per un migliaio di anni: gli ebrei dovevano essere governati da una combinazione di leggi secolari e religiose che, se osservate, avrebbero assicurato una pacifica coesistenza con i cristiani. Ciononostante, non cesseranno di essere vittime di violenze atroci, che sfuggivano all’occhio disattento delle autorità ecclesiastiche: omicidi, massacri, accuse di profanazione di ostie e di uso di sangue umano per macabre cerimonie. Nell’Umbria medievale ogni anno venivano perfino sottoposti alla “sassaiola santa”, una lapidazione ritualizzata per ricordare che erano teologicamente nemici del figlio del Signore.
Nella seconda metà del tredicesimo secolo, la condizione degli ebrei residenti nello Stato pontificio peggiora sensibilmente. Nel 1257 a quelli romani viene imposto uno “sciamanno”, cioè un segno distintivo già prescritto nel 1215 dal quarto Concilio Lateranense: un pezzo di stoffa gialla -a forma di cerchio- cucito sul vestito per gli uomini, e due strisce blu cucite sullo scialle per le donne. Più avanti si aggiungerà l’obbligo di indossare un tabarro rosso sopra il vestito (poi sostituito da un cappello giallo), da cui erano esentati solo i medici e i capi della comunità. Dopo la fine della cattività avignonese (1420), la politica del papato oscilla tra misure discriminatorie e concessione di privilegi. Nel 1432 Eugenio IV stabilisce che gli ebrei potevano beneficiare solo dei diritti previsti dallo “ius commune”, ovvero dal diritto romano applicato secondo le norme consuetudinarie. Un decennio prima, Martino V aveva invece censurato i sermoni incendiari dei francescani, perché rischiavano di ostacolare la conversione dei giudei, che andava perseguita con l’arma più efficace della benevolenza. I francescani continueranno lo stesso a dipingerli come una cancrena che avrebbe corrotto le fondamenta della società. Promuovendo la nascita a Perugia del primo Monte di Pietà (1462), tenteranno anche di scalzarli dal mercato dei piccoli prestiti. Ogni prestatore di denaro di allora doveva essere munito di una licenza, la “inhibitio foenerandi”, che proibiva a chiunque -tranne al camerlengo papale- di interferire nei suoi affari. In realtà, con tali licenze veniva di fatto legalizzato l’interesse, altrimenti vietato dalla legge canonica.
Diversamente da quanto avveniva in altre regioni della penisola, gli ebrei romani non erano -se non in minima parte- prestatori di denaro. Erano soprattutto commercianti di grano e di altri generi alimentari; oppure artigiani, particolarmente abili nei lavori di sartoria e nella produzione di pizzi pregiati. Così abili e concorrenziali con i fabbricanti di stoffe cristiani, da indurre questi ultimi a invocare per loro l’inibizione di vendere abiti nuovi. Nella stessa bolla che intimava l’apertura del ghetto, Paolo IV esaudirà pienamente la richiesta della corporazione dei sarti. Essa infatti corrispondeva all’ispirazione più generale del suo pontificato, in cui le restrizioni economiche erano concepite per forzare il processo di conversione. Del resto, l’ottantenne papa Carafa in passato aveva già inasprito pesantemente la pressione fiscale sugli ebrei; e, come prefetto del Sant’Uffizio, aveva ordinato il rogo dei libri del Talmud in Piazza Campo de’ Fiori (settembre 1553).
Appena appresa la notizia della sua morte, sarà invece una folla inferocita di fedeli a bruciare i documenti saccheggiati negli archivi dell’Inquisizione. Durante il suo pontificato, il malumore popolare era infatti salito alle stelle. La creazione del ghetto aveva rotto un equilibrio millenario, e un ottuso zelo moralistico aveva sconvolto stili di vita e costumi secolari. L’ascesa al soglio petrino di Pio IV de’ Medici (1559-1565) viene quindi accolta con un senso di liberazione, mentre sugli “Avvisi” (le gazzette d’informazione del tempo) anonimi romani -con la loro proverbiale irriverenza- si sfogavano schernendo l’ascetismo oppressivo del suo predecessore: “Le puttane cominciano di nuovo ad uscire in carrozza come prima e più rispettate di prima”.
Ma le speranze degli ebrei di riacquistare le antiche libertà svaniranno rapidamente. Pio IV si limita ad allentare alcuni vincoli che gravavano sulle loro attività mercantili, ma non abolisce il ghetto né li dispensa dall’indossare il cappello giallo. Per giunta, Pio V (1566-1572) e Gregorio XIII (1572-1585) rilanceranno con forza il rigorismo paolino. Lo stesso Sisto V (1585-1590),sebbene meno intransigente sul piano dottrinario, confermerà il loro status di “stranieri in patria”. Ed è proprio durante il suo pontificato che gli ebrei cominciano a paragonare il ghetto al “ghet”, il libello di divorzio che il marito doveva consegnare direttamente nelle mani della moglie. La comunità ebraica era stata “divorziata” dalla comunità cristiana; ma, come ogni divorziata, secondo la legge (“Halakhah”) aveva comunque il diritto di educare e curare la propria prole. La metafora alludeva alla vera natura della posta in gioco: la sfida della Chiesa aveva come obiettivo non solo il credo religioso, ma la stessa cultura sociale degli ebrei romani. Occorreva pertanto munirsi di una strategia difensiva, in grado di preservare l’identità ebraica senza alzare barriere insormontabili con i cristiani.
D’altronde, gli ebrei avevano un aspetto fisico e un modo di parlare e di vestire uguali a quelli dei romani. I primi erano attratti dai segreti dell’alchimia cristiana, i secondi dalla “Qabbalah” mistica. Ma queste erano curiosità coltivate dai ceti più colti, mentre i popolani ebrei e cristiani si incontravano nelle osterie dove giocavano, bevevano lo stesso vino e qualche volta mangiavano lo stesso cibo: alici, sarde, tonno, carne salata. Ma le affinità conviviali finivano qui. Nelle loro case tutto ciò che gli ebrei mangiavano era “kasher”: la carne veniva macellata ritualmente e cucinata in maniera meticolosa, con l’esclusione di quella di maiale e dei frutti di mare amati invece dai palati cristiani. Diversità liturgiche che erano oggetto di ironia e di disprezzo nelle cosiddette “giudiate”, farse messe in scena durante la chiassosa stagione del carnevale che precedeva la Quaresima. Le giudiate irridevano soprattutto i matrimoni e i funerali ebraici, e potevano preludere a gesti sconsiderati da parte degli animi più accesi, tant’è che i pontefici erano soliti emanare editti che invitavano a “non molestare gli ebrei”.
Nel 1471 a Roma si contavano almeno sei sinagoghe (tutte situate in un unico edificio), cinque delle quali rappresentavano nazionalità differenti, ma si ha traccia anche di una composta di sole donne. Un numero destinato ad aumentare rapidamente, in virtù dei flussi migratori provenienti dalla Provenza, dalla Spagna, dalla Germania, dalla Sicilia e dal Nord Africa. Secondo un censimento approssimativo, alla metà del secolo gli ebrei erano circa un decimo dei cinquantamila abitanti di Roma. La loro comunità (chiamata anche “Università”) era guidata da tre capi laici (“fattori” o “memunim”), uno dei quali spettava di diritto agli “ultramontani”, ossia agli immigrati non italiani. Questo vertice di governo era coadiuvato da un Consiglio e da sette “boni iudei” -un organismo che si ispirava ai sette “boni homines” dei Comuni italiani.
Luoghi essenzialmente di studio e di preghiera (per lo più orientata in senso cabalistico) erano invece le sinagoghe. Ma talvolta svolgevano anche funzioni caritatevoli, con la raccolta di fondi a scopo filantropico e l’elargizione di una dote alle ragazze più bisognose. Le confraternite, invece, non dipendevano dalle autorità religiose e operavano in piena autonomia dalle stesse istituzioni comunitarie. La “Ghemilut Chasadim” (Confraternita della carità e della morte), considerata la più influente dell’epoca, si presentava come un’organizzazione di quartiere che gestiva attività assistenziali e devozionali. In questo contesto, il ruolo del rabbino era marginale, perché ognuno poteva sviluppare un proprio modello di religiosità che escludeva il primato di un direttore spirituale.
Lo scarso valore attribuito dagli ebrei romani alla burocrazia e alle cariche pubbliche è attestato anche dall’assenza di un rabbinato civico, cioè di un rabbino nominato ufficialmente dalla comunità. Questi non era visto come un suo capo, ma come un suo “servo”. Veniva trattato con ossequio e deferenza, poteva controllare l’idoneità dei cibi e la corretta macellazione della carne (“kasherut”), oppure sovrintendere ai giuramenti di chi pagava le tasse, ma non godeva della sacralità accordata al clero cattolico. La sua autorità poggiava sul prestigio personale, come dimostra il caso del carismatico rabbino padovano Judah Mintz, autore di decreti emanati “sua sponte” nel 1506 e scrupolosamente osservati per molte generazioni. Perfino la scomunica (“niddui”), che per convenzione poteva essere pronunciata solo da un rabbino, era più una sanzione amministrativa per un comportamento scorretto che non un atto di espulsione dalla comunità di un rinnegato. Inoltre, il rabbino -per guadagnarsi da vivere- non di rado era costretto ad esercitare il mestiere profano del prestatore di denaro. La sacralità rabbinica, insomma, si svilupperà nell’Europa orientale dell’Ottocento, ma era sconosciuta sia a Roma che nell’Europa occidentale del Cinquecento.
Pur non avendo alcuna intenzione di concedere pieni poteri giurisdizionali alla comunità ebraica, i pontefici tolleravano l’intervento dei collegi di arbitrato volontario, perché si era rivelato come un prezioso veicolo di armonia sociale. Svincolato dall’interpretazione letterale delle leggi, l’arbitro poteva risolvere controversie di ogni tipo con compromessi che non avevano il carattere inappellabile delle sentenze dei tribunali. Più in generale, l’arbitro agiva da mediatore tra individui e organismi di governo, sulla falsariga di quell’istituto del patronage (costituito da reti di vicini o di amici) che stava diffondendosi nelle città rinascimentali. Nel minuscolo ghetto romano era infatti assai vivo e praticato il concetto di “shekunah” (vicinato). Ancora più rilevante, come cerniera tra sfera pubblica e sfera privata, era il “Sofer Meta” (notaio cittadino). Il perfezionamento della “ars dictaminis” (arte notarile) si deve a Isaac Piattelli, che aveva messo a punto le sue tecniche ancora prima della nascita del ghetto. Il suo lavoro era simile a quello dell’avvocato e del giudice istruttore: redigeva contratti, ascoltava testimoni, annotava gli accordi in caso di arbitrato, compilava i più svariati atti pubblici. Senza la sua penna gli ebrei non avrebbero avuto strumento alcuno per far valere patti e decisioni. E la sua penna inventava un linguaggio, formule e schemi che, pur non smentendo la tradizione ebraica, costruivano ponti culturali con il mondo cristiano.
Negli oltre seimila atti notarili (stilati tra il 1535 e il 1606) setacciati da Stowe vi sono testamenti, registrazioni di matrimoni, divorzi e adozioni, liti domestiche. Indirettamente vi sono segnalati anche molti aspetti della realtà più minuta del ghetto: intrattenimenti teatrali, lezioni di ballo e di nuoto, giochi d’azzardo, gare di musica e di poesia. Sappiamo così che gli ebrei erano golosissimi di tagliolini, carne secca e castagne. Taluni erano organizzatori di banchetti, altri acquistavano dai contadini cristiani carciofi e frutta, che poi rivendevano al dettaglio. C’erano addirittura donne macellaio, a testimonianza della loro presenza attiva nella vita economica. Drammatico era il problema dell’alloggio. Spesso le abitazioni sovraffollate e costruite con negligenza crollavano, uccidendo chi restava intrappolato tra le macerie. Notevole attenzione veniva prestata all’estetica della persona, come emerge dagli inventari delle botteghe dei barbieri e delle “stufe” (bagni pubblici).
Gli ebrei romani, in fondo, avevano affidato al notaio il compito di definire i rituali civici del ghetto e di sciogliere -insieme all’arbitro- conflitti familiari e sociali. Sotto tale profilo, gli veniva chiesto -se non di sostituirsi- di integrare istituzioni comunitarie deboli e afflitte da sterili rivalità. Grazie agli arbitri e ai notai, dunque, essi potevano contare su una certa stabilità nella loro esistenza quotidiana. Il rafforzamento di questa autonoma giurisdizione interna non tarderà ad allarmare le gerarchie ecclesiastiche. Attorno al 1640 il cardinal vicario sostituirà i notai ebrei con notai cristiani. Anche se i membri di alcune sinagoghe e di alcune confraternite proveranno a rinnovarla, l’arte notarile ideata da Isaac Piattelli subirà una irreversibile parabola discendente. Se il Cinquecento aveva consentito agli ebrei romani spazi di autogoverno virtualmente sovrani, il secolo successivo sarà segnato dalla ferma determinazione papale di ripristinare le vecchie ordinanze canoniche, al fine di rendere i giudei più vulnerabili e più disposti alla conversione. Già la bolla “Antiqua iudaeorum improbitas” (1581) aveva fatto rientrare sotto l’egida dell’Inquisizione le imputazioni di eresia, di blasfemia e di magia nera.
Per altro verso, il debito enorme accumulato nei confronti della Camera Apostolica (il ministero del Tesoro pontificio) e la chiusura dei banchi di prestito (1682) daranno un colpo di grazia al relativo benessere raggiunto faticosamente dalla comunità del ghetto. Inizia da allora un declino economico, costante quanto precipitoso, che nel 1843 verrà descritto da un viaggiatore inglese, Jeremiah Donovan, con queste parole: “Dei 3600 ebrei di Roma, comprendenti 800 famiglie, 1900 sono poveri, 1000 si mantengono arrabattandosi e il resto vive in condizioni agiate. I poveri in genere raccolgono stracci vecchi, quelli che si arrabattono commerciano in abiti usati e i più agiati sono mercanti. Pochi imparano un mestiere artigianale, le belle arti o coltivano la letteratura; la classe più abbiente è soddisfatta della porzione di sapere utile ai fini commerciali”. Cosa esattamente il nostro viaggiatore intendesse per “condizioni agiate” potrebbe essere motivo di discussione. Ma si può ragionevolmente sospettare che, se il ghetto di Roma non fosse stato abolito nel 1870, perfino i mercanti “agiati” avrebbero languito in uno stato di endemica precarietà, finanziaria e civile.