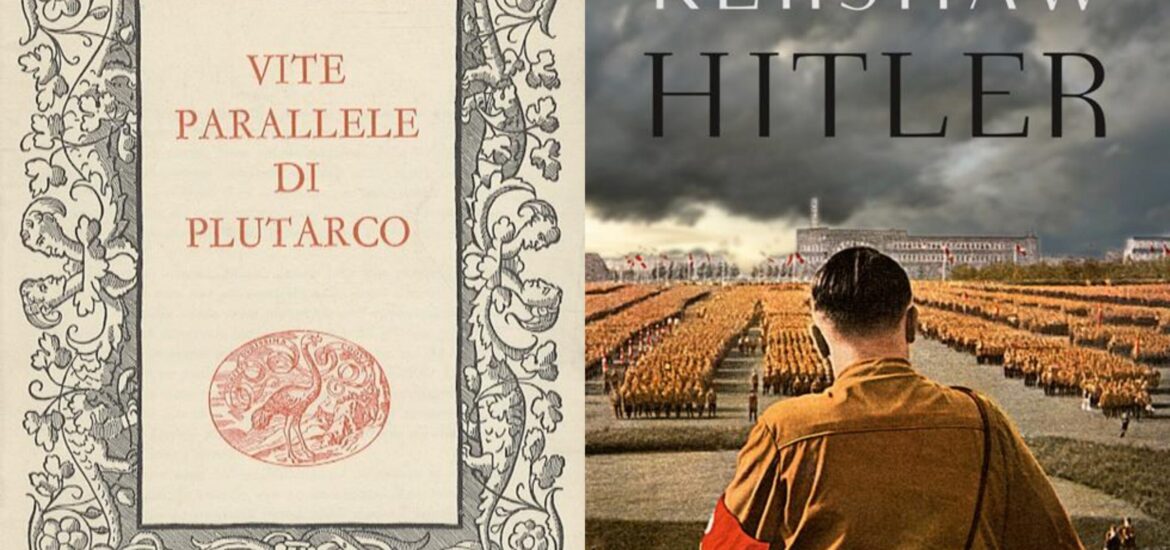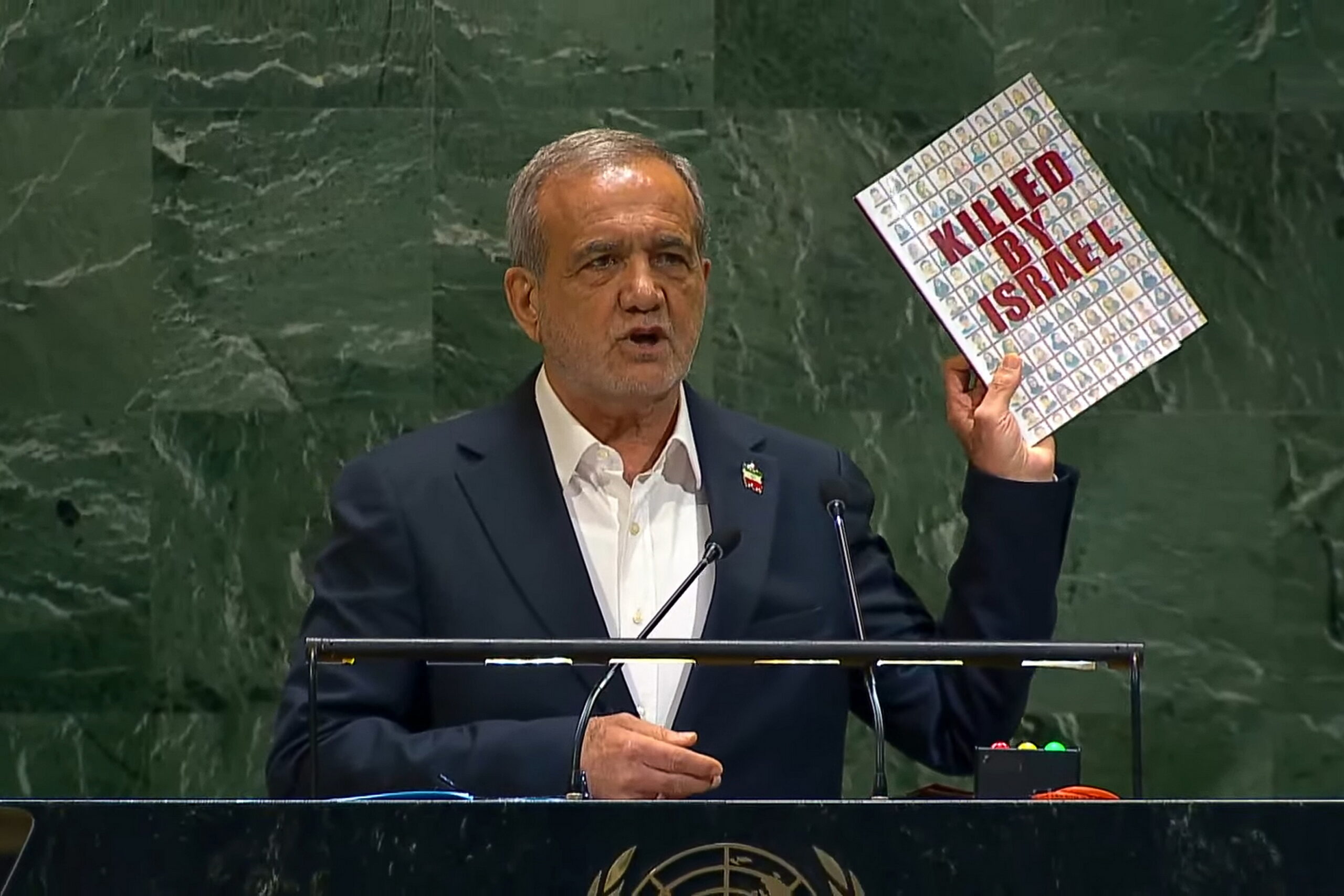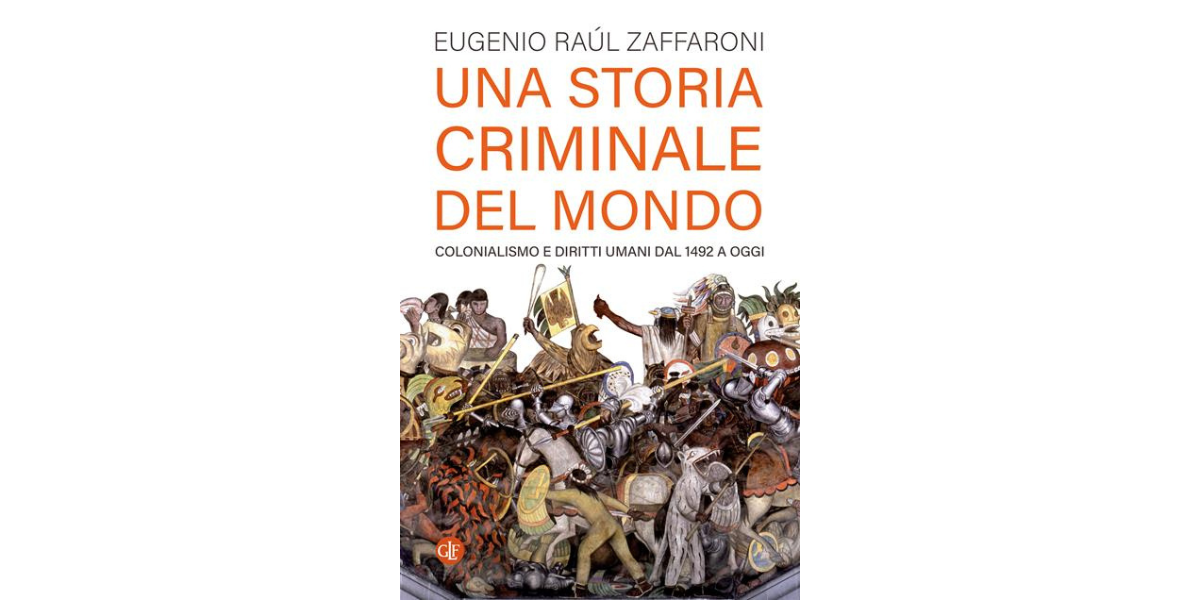La mia predilezione per la biografia nasce sui banchi di scuola, dall’incontro con le “Vite parallele” di Plutarco. Proprio per il rilievo che assegnano a fatti ed episodi spesso trascurati dall’analisi storiografica, apparentemente marginali e talvolta avvolti nell’alone del mistero, dell’avventura, dell’esotismo, del mito. So che, a questo punto, alcuni storici di professione potrebbero storcere il naso. Lo statuto scientifico della biografia resta infatti una questione assai controversa. Nonostante Plutarco, è solo nell’età moderna che essa si impone con un certo successo.
Basti pensare ad opere magistrali come “Methodus ad facilem historiarum cognitionem” di Jean Bodin (1566), “Dell’arte historica” di Agostino Mascardi, oppure “De la manière d’écrire l’histoire” di Gabriel Bonnot de Mably (1784). Come ha sottolineato la storica Monica Rebeschini, mentre i positivisti non misconoscevano le potenzialità descrittive e pedagogiche della biografia, la stagione dello storicismo -di matrice idealista o marxista- le demolisce: tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento l’attenzione viene interamente spostata sui grandi processi storici.
Secondo Benedetto Croce, “L’individuo è pensato e giudicato solo nell’opera che è sua e insieme non sua, che egli fa e che lo oltrepassa” (“La storia come pensiero e azione”, Laterza, 1954). Altrettanto autorevoli, tuttavia, sono state le voci favorevoli alla biografia: lo svizzero Jakob Burckardt la celebra addirittura come una delle più importanti scoperte del Rinascimento italiano. Mentre Arnaldo Momigliano sarà il primo a interrogarsi -in un ciclo di lezioni tenuto alla Harward University nel 1968- sul rapporto ambiguo che lega il genere biografico alla storiografia, senza tuttavia negare sua legittimità e la sua autonomia nella ricerca sociale (“Lo sviluppo della biografia greca”, Einaudi, 1971).
In Europa il genere biografico conosce una apprezzabile fioritura nei decenni terminali del “secolo breve”, complici la disgregazione dell’impero sovietico, la fine del mondo bipolare, la crisi delle ideologie di massa, i travagli della transizione postcomunista. Crollano le antiche certezze sulla dimensione teleologica della storia, già messe a dura prova dalla Shoah e dal rischio di una guerra nucleare. Emergono atteggiamenti più cauti e disincantati, forme meno ambiziose e meno totalizzanti di comprensione degli eventi storici. Il genere biografico acquista così una rinnovata vitalità.
Già nel 1986 Pierre Bourdieau aveva denunciato l’assurdo scientifico costituito dall’opposizione netta tra individuo e società (“L’illusion biographique”). Mentre nel 1989 Jacques Le Goff, sul periodico “Le Débat”, definirà la biografia come un “indispensabile strumento d’analisi delle strutture sociali e dei comportamenti collettivi”. Nello stesso anno, un numero delle “Annales” si apriva con un intervento di Giovanni Levi sull’utilità della biografia nelle scienze sociali. Del resto, gli stessi fondatori della rivista, Marc Bloch e Lucien Febvre, erano piuttosto cauti di fronte alle pretese prevaricatrici della “storia delle strutture” (istituzionali, economiche, sociali, demografiche) sulla “storia degli uomini”. Non fortuitamente, si deve proprio a Febvre una superba biografia di Lutero (1928).
Questo mutamento di clima si rispecchia in modo esemplare nel percorso intellettuale di Ian Kershaw, uno dei maggiori studiosi del Terzo Reich. Lo storico inglese, di formazione strutturalista, approda alla stesura di una biografia di Hitler (uscita nel 1998) spinto dall’insopprimibile bisogno -come confessa nella prefazione- di “approfondire la riflessione sull’uomo che fu “fulcro indispensabile e centro ispiratore” del regime nazista (“Hitler”, 2 voll., Bompiani, 2003). Servendosi del concetto weberiano di carisma per spiegare sia l’autorità assoluta del dittatore sia il gregarismo del popolo tedesco, il professore dell’università di Sheffield tratteggia un profilo del Führer che -come egli stesso ammette- si risolve in definitiva nella “storia del suo potere”.