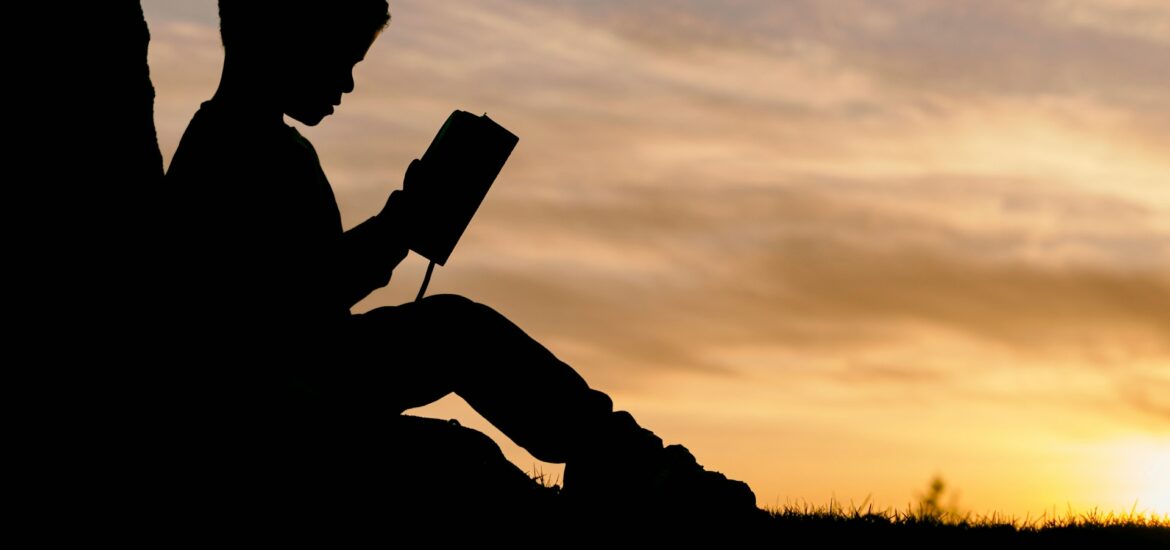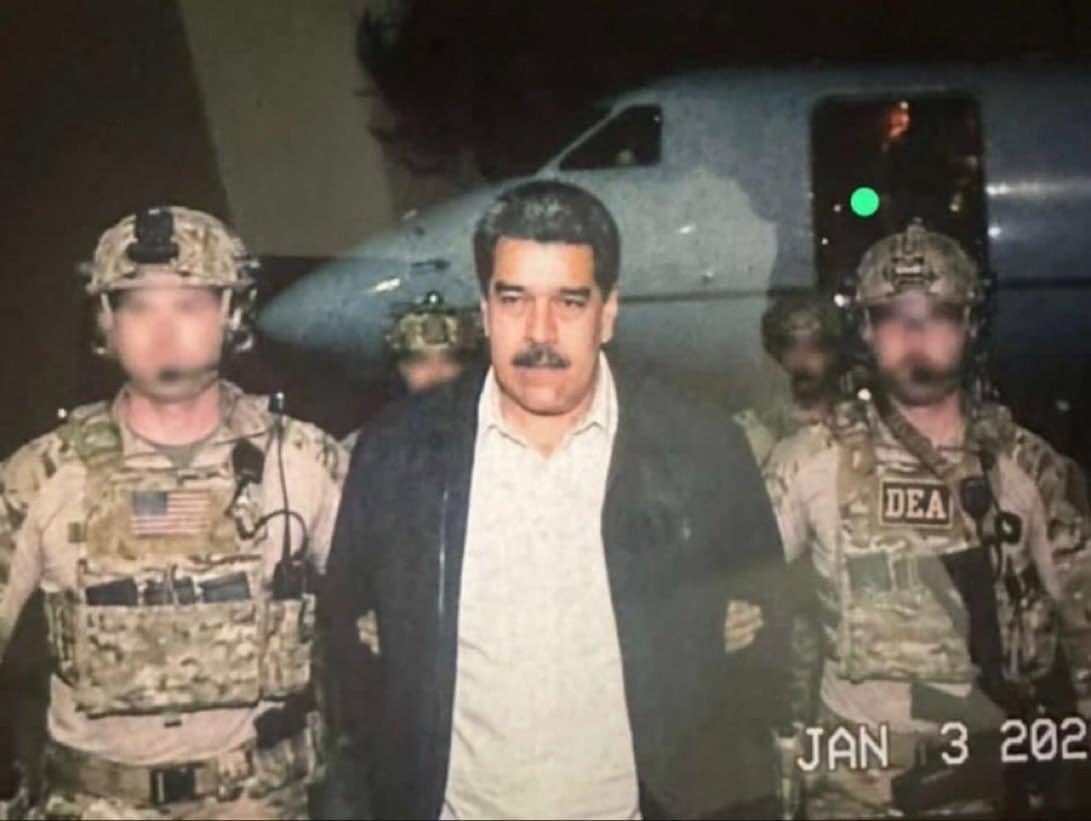Cerchiamo di fare un minimo di chiarezza e di semplificazione tra alcuni argomenti adiacenti che si stanno mescolando nel dibattito pubblico e mediatico.
Il primo è l’educazione affettiva, sentimentale, sessuale, tema che ha suscitato ieri vivaci polemiche parlamentari, con il ministro Valditara che ha accusato le opposizioni di «sfruttare i femminicidi». I quali sono in calo ma suscitano, a ogni atto di violenza contro le donne, il medesimo e sacrosanto sdegno: vedi ieri il caso a Seregno, con un uomo che perseguita l’ex con il GPS e le getta benzina negli occhi.
In sostanza, la maggioranza è contraria, paventando in quest’innovazione didattica un attacco alla famiglia tradizionale e alla distinzione dei generi, un’altra mazzata che segue il “genitore 1, genitore 2” o l’adozione da parte delle coppie LGBTQ+. Maschio, femmina, papà, mamma finiscono cancellati come i mercati rionali, le sale cinematografiche, la Messa domenicale: questo lo scenario che si paventa, con parecchia ragione.
Il centrodestra teme l’azzeramento delle distinzioni e delle regole, l’indottrinamento dei bambini a seguire qualunque pulsione e desiderio, che è in effetti quanto almeno una parte delle sinistre politiche e ideologiche perseguono. Nascondendosi dietro la scusa di spiegare ai bambini (“non insegnate ai bambini la vostra morale” ammonisce il geniale Giorgio Gaber nella sua canzone-testamento) come non usare violenza sessuale.
Ieri è stato approvato all’unanimità in commissione Giustizia alla Camera l’emendamento che punisce “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero ed attuale”, un principio adamantino ma difficile da declinare in norme, tanto che in Francia si è giunti all’estremo del consenso formale: “Ti voglio…” “anch’io…” “dove si firma?”…
Ernesto Galli della Loggia sostiene: il problema serio non è l’educazione affettiva, ma la condizione generale dell’istruzione in Italia, l’ignoranza diffusa, che si esprime nel basso numero di laureati e diplomati e nell’analfabetismo funzionale, l’incapacità di comprendere un testo complesso. Ma anche qui si mescolano cose diverse.
Una è l’ignoranza relativa, che aumenta a causa dell’aumento di conoscenze disponibili, l’infodemia, la circolazione di contenuti, messaggi, notizie sempre maggiori e superiori alla nostra possibilità di gestirle. Altra è il livello di formazione raggiunto, che si tende a far crescere non con più impegno nello studio ma abbassando i criteri di giudizio, vedi le lauree triennali e il calo, anzi il gelo, della didattica: si entri in un’aula scolastica o in una facoltà universitaria per rendersene conto e inorridire.
La soluzione la conosciamo, quella che sosteneva Bertinotti ai suoi tempi: istruzione a pagamento e sconti, anzi premi, per meritevoli bisognosi. Con il “pubblico” sono i poveri, con le loro tasse, a pagare gli insegnanti e le aule per i ricchi. Ma se il parametro sono le percentuali e l’istruzione è un mercato, è inevitabile che la situazione degradi, abbassando il livello dell’offerta per invogliare la domanda.
Si pensi solo agli atenei telematici che riesumano, peggiorandolo, il vecchio “tre anni in uno” per studenti ciucci che volevano finire la scuola comunque fosse. Si resta al vecchio “pezzo di carta”, insomma. Che, come sappiamo, è carta straccia. Specialmente in alcune aree del Paese, il che contribuisce al sempiterno problema del Mezzogiorno: dal Sud emigrano ancora ogni anno 134.000 studenti e 36.000 laureati, costo stimato 4 miliardi.
La questione più grave è però forse la terza, la progressiva inadeguatezza dell’istruzione per il mondo di oggi e domani, la vetustà del modello per il quale un giovane ascolta parlare degli adulti, spesso dei vecchi, sostanzialmente dipendenti pubblici, dovendo ricavarne nozioni e metodi utili per navigare in una realtà che cambia a velocità inimmaginabili in passato. Ne hanno parlato nei giorni scorsi Paolo Balduzzi, Paolo Ferrario e Raffaella Troili.
La preoccupazione di molti è il privato che surroga lo Stato, come nella Sanità, quasi che il problema fosse chi sostituisce e non chi manca, cioè gli insegnanti e i sanitari non all’altezza. Peraltro, che le aziende cerchino di tirarsi su lavoratori e manager da soli non sarebbe il peggiore di tutti i mali, lo facevano un tempo gli artigiani e anche gli industriali del Nord ed è un sistema usato con soddisfazione in Giappone, dove al lavoro ci tengono davvero.
Perché da noi, e in gran parte del mondo, l’altra cosa che, come la famiglia, sta crollando sotto i colpi dei tecno-media è proprio il lavoro-valore. Che manchi il passaggio generazionale di conoscenze e competenze, questo è il problema maggiore che ci troviamo ad affrontare. Non abbiamo davanti un gran domani. Il gelo demografico si sposa perfettamente con il gelo educativo.