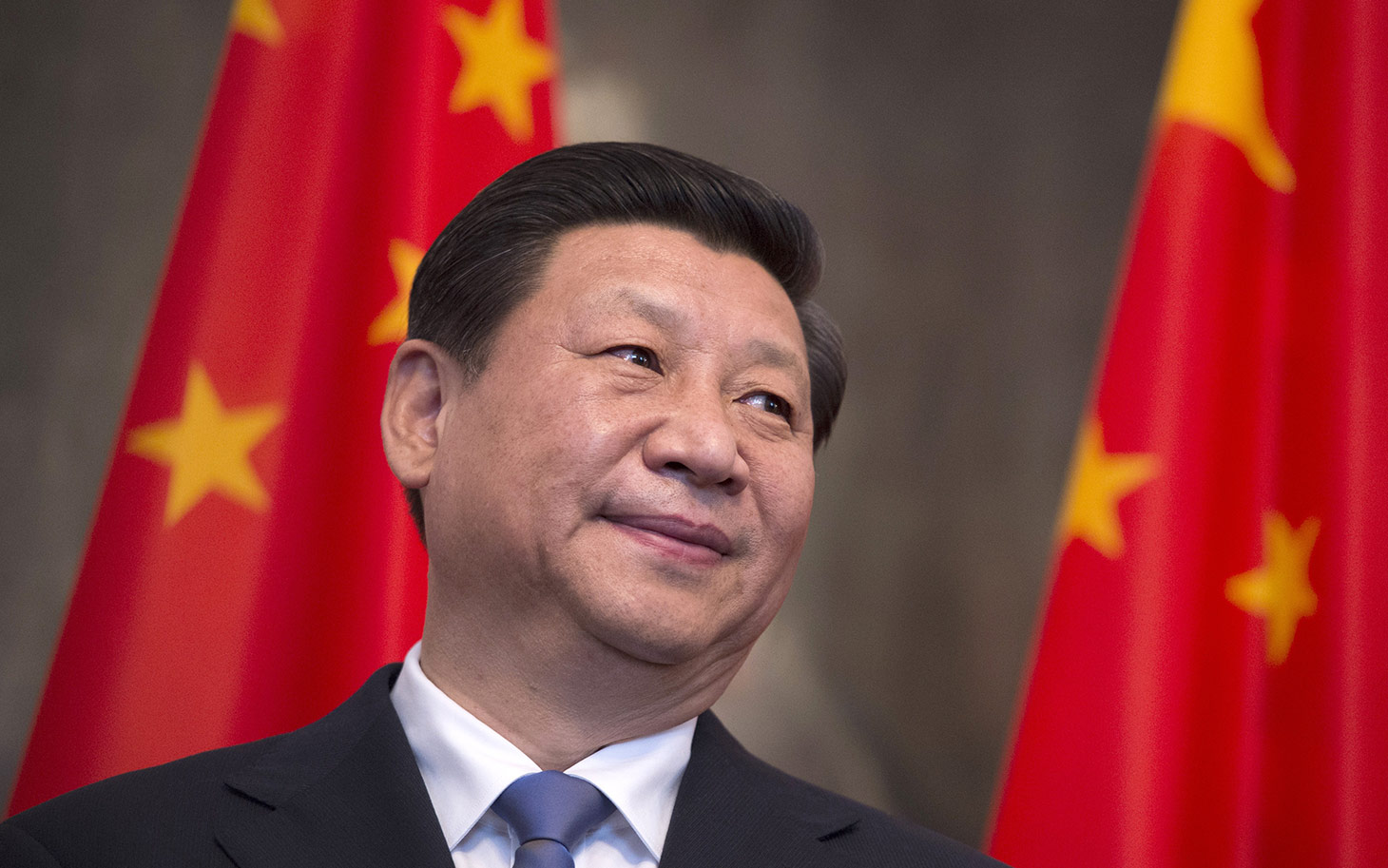Si parla molto di Italia–Israele – in campo a Udine stasera –, ma la verità è che per capire come il calcio finisca sempre per essere un linguaggio della politica conviene tornare a Roma, autunno 1975, quando Lazio–Barcellona non si giocò mai. Allora come oggi le piazze premevano, le federazioni temporeggiavano, i dirigenti cercavano una formula che non esiste: disputare una partita senza decidere nulla sul mondo attorno. Quella Lazio finì per scegliere da sola, pagandone il prezzo sportivo e consegnando alla memoria un episodio che dice più delle conferenze stampa di mille comitati.
Cinque fucilazioni e un minuto di silenzio
Il contesto lo fa la Storia con la S maiuscola. Il 27 settembre 1975 la Spagna franchista fucila cinque militanti di FRAP ed ETA. L’Europa reagisce con una miscela di sdegno e calcolo: ambasciatori richiamati, manifestazioni, appelli. In Italia, dove gli stadi sono ancora agorà civili, il tema entra dritto nelle coppe europee. La Lazio di Giorgio Chinaglia in Coppa UEFA ha pescato il Barcellona, una grande d’Europa e, insieme, un simbolo: il club catalano è da sempre il contenitore di un’identità ostile al franchismo. Ma il calendario dice che la prima si gioca all’Olimpico. Umberto Lenzini, presidente biancoceleste, preoccupatissimo prende carta e penna. Chiede alla FIGC di farsi ascoltare dalla UEFA, e alla UEFA di prendere una decisione piena: spostare, sospendere, isolare. Se si gioca come nulla fosse, ragiona Lenzini, si normalizza l’eccezione. E, otto giorni dopo le esecuzioni, Lenzini e l’armatore doriano Glauco Lolli Ghetti trasformano Marassi in un rito civile: Sampdoria e Lazio aprono con un minuto di silenzio per i martiri di Spagna. La FIGC approva, ma non lo istituzionalizza: resterà un unicum.
Le piazze esplodono, il calcio esita
E intanto le piazze esplodono. A Genova i portuali annunciano il boicottaggio delle navi spagnole; in poche ore diciassette Paesi richiamano gli ambasciatori; perfino Paolo VI condanna le fucilazioni. Parigi porta in strada centomila persone, migliaia marciano in Germania Ovest e nei Paesi Bassi, a Utrecht c’è Joop den Uyl, a Stoccolma Olof Palme; Lisbona assedia l’ambasciata spagnola, Atene fa lo stesso, Firenze prende di mira il consolato. A Roma sfilano in cinquantamila, a Milano in ventimila. I giornali titolano “Nessuno giochi con gli spagnoli”, i sindacati sostengono la richiesta, il Viminale alza la guardia sull’ordine pubblico. Artemio Franchi, presidente federale e poi numero uno UEFA, ascolta tutti e non decide. La UEFA, incalzata da una grana che può diventare regola, rifiuta l’idea di bandire i club iberici. Lenzini insiste, torna a bussare, costruisce un “dossier” che finirà sui tavoli di Nyon. Intanto la macchina della competizione corre. Il Barcellona parte per Roma, i suoi giornali parlano di “mistero laziale” e intanto prefigurano una richiesta di indennizzo. A ogni ora che passa, la decisione non presa diventa la sola possibile: o scendere in campo, o rinunciare.
La scelta solitaria della Lazio
Il paradosso è evidente: la Lazio chiede una scelta “generale” e riceve in risposta la regola “particolare”. Se non giochi, perdi a tavolino. Punto. Lenzini raduna i suoi, valuta il clima, ascolta le autorità, misura la piazza. Sceglie la strada più impegnativa: non giocare. Il giudice sportivo recepisce, omologa lo 0–3, archivia senza chiedersi se quell’assenza sia un gesto politico o solo un’inadempienza. Il calcio non possiede aggettivi per graduare la coscienza. Il risultato è uguale per tutti.
Camp Nou: la resa dei conti
Il ritorno, al Camp Nou, toglie ogni velo di retorica. La Lazio scende in campo con una banda di ragazzini talentuosi come Giordano e Manfredonia, a fianco di alcuni degli eroi dello Scudetto del 1974. Troppo poco. Dall’altra parte Neeskens e Cruyff prodigano superiorità, il Barcellona vince 4–0, con Chinaglia che si fa parare un rigore da Mora. Il doppio confronto dice 7–0 e la Lazio esce. Resta la scia delle interpretazioni. In Italia molti salutano l’atto di Lenzini come solidarietà concreta al popolo spagnolo; in Catalogna qualcuno fa notare che proprio il Barça, per storia e identità, era l’avversario meno “franchista” che si potesse incontrare, con Cruijff che ha chiamato il figlio Jordi in sfregio al divieto dei nomi catalani. La solidarietà, spiegano i cronisti barcellonesi, è bene orientarla: punire il Barça significa colpire chi, sotto il franchismo, ha pagato prezzi in lingua, simboli, persino colori. Eppure l’Europa del pallone non si ferma: Real Madrid, Atlético, Real Sociedad, tutti continuano a viaggiare. L’isolamento politico di Madrid non diventa isolamento sportivo.
Franco muore, la Lazio crolla
Pochi giorni dopo, come se la storia avesse fretta di chiudere una parentesi, il 20 novembre 1975 Franco muore; due giorni più tardi Juan Carlos I sale al trono e apre la transizione. Per la Lazio, però, il conto sportivo resta: dopo la sconfitta al Camp Nou, il campionato si fa in salita, l’allenatore Giulio Corsini viene esonerato di lì a poco e a dicembre torna Tommaso Maestrelli, l’allenatore dello Scudetto, per riportare la squadra in acque sicure. È un ritorno che commuove e ferisce: Chinaglia se n’era andato in America, la salvezza arriverà solo all’ultima giornata (pari a Como), e il 5 dicembre 1976 Maestrelli, vinto l’ultimo duello con la classifica, perderà quello con la malattia.
Intanto, in Italia, l’autunno 1976 apre la stagione del “compromesso storico”: governo Andreotti monocolore DC con astensione PCI, Pietro Ingrao alla Presidenza della Camera, inflazione alta e “stangata” fiscale, ricostruzione del Friuli e terrorismo in crescita; la vicenda Lockheed corrode la fiducia nelle élite, mentre la Consulta spalanca l’etere locale. È la cornice che spiega perché le piazze restano centrali e perché il calcio continua a vibrare di politica, anche quando finge neutralità.
Brera, il referto laico
In mezzo a tutte quelle righe resta una voce che allora valeva come un referto antropologico: Gianni Brera. Di fronte ai moralismi a ore, Brera si tenne su un crinale laico. “Tutto quanto si svolge nella polis è politico”, annotò, ricordando a chi fingeva di non vedere che il pallone non è mai neutro. E aggiunse, con la ferocia dell’osservatore che non fa sconti a nessuno: “Ricevere il Barcellona di Cruijff e Neeskens non le convenisse”. Più che un’accusa, un promemoria: quando i principi s’incontrano con i calendari, nessuno è innocente. La democrazia, scriveva ancora, non si impone “con la forza, a meno che non si tratti di una rivoluzione”; e quella, in Spagna, toccava agli spagnoli. Il punto non era sminuire il gesto della Lazio, ma misurarlo nel campo lungo della politica, dove gli atti simbolici hanno valore solo se si accetta di pagarne le conseguenze.
Il presente come lente
Se oggi si evoca Italia–Israele, è per dire che le dinamiche sono identiche, pur nei contesti incomparabili. Le piazze chiedono un segno, le federazioni difendono l’ordinamento, i club e le nazionali si ritrovano a reggere l’urto. Ci si attacca alle parole – “neutralità”, “pace”, “diritti” – e intanto si cerca un escamotage che non esiste. O giochi, o non giochi. Nel mezzo ci sono i riti ormai standardizzati – minuti di silenzio, bracciali, proventi devoluti – che raramente bastano a chi invoca il boicottaggio. È qui che la vicenda del 1975 diventa una lente: quando l’istituzione non decide, la responsabilità scivola sul singolo. Allora fu la Lazio, oggi potrebbe essere una Nazionale. E, per inciso, un’eventuale rinuncia non è un comunicato: è una sconfitta a tavolino e, spesso, altro ancora, come hanno ben spiegato sia il CT Rino Gattuso che il Ministro dello Sport, Andrea Abodi.
Cosa resta: il prezzo della coerenza
C’è un’immagine che racconta meglio di qualsiasi editoriale quel passaggio. Da una parte l’“El Misterio Lazial” raccontato dalla stampa catalana, come se a Roma si stesse inventando una novella a puntate. Dall’altra, le colonne di l’Unità e degli altri quotidiani italiani che seguono, quasi ora per ora, la trattativa con Franchi e Carraro, l’andirivieni in FIGC, l’ipotesi di rinvio, la formula del campo neutro, la parola “solidarietà” ripetuta fino a diventare un rumore di fondo. In mezzo, un presidente che capisce che gli appelli non si trasformano in delibere, e decide di portare fino in fondo il ragionamento: se l’Europa non isola il franchismo, io mi isolo da sola. Lo fa, e il calcio la punisce. Non perché abbia torto sul piano morale, ma perché onora un regolamento scritto per funzionare quando la storia dorme.
La lezione è amara ma chiara. Il calcio non ha il vocabolario per valutare i contesti, e quando prova a inventarselo crea precedenti ingestibili. Per questo UEFA e FIFA, salvo shock sistemici, preferiscono la continuità. Nel 1975 temevano che l’eccezione diventasse prassi, come era accaduto due anni prima con l’URSS che rifiutava di giocare a Santiago del Cile; oggi temono di dover scrivere una gerarchia dei conflitti, distinguendo le guerre “che contano” da quelle che non contano. È una paura anche legittima. Ma ha un costo politico: lasciare che la piazza scarichi le sue attese su chi entra in campo con un numero sulla schiena e i cartellini nel taschino dell’arbitro.
Il caso Lazio–Barcellona è il paradigma del cortocircuito tra pallone e politica: un gesto pensato come universale che lasciò il club solo, nobilitato nel racconto ma punito dai regolamenti. Ogni boicottaggio ha un prezzo: sconfitta a tavolino e possibili sanzioni; chi lo invoca deve accettarlo, chi lo rifiuta deve spiegare perché giocare non equivale ad assolvere. Con Brera, va riconosciuto che ogni partita che entra nella polis è politica e richiede responsabilità. Quella non-partita fu un referendum: Lenzini disse “no” e il calcio disse “no” al suo no. In questi giorni Italia–Israele ha riaperto la domanda; la Lazio del ’75 scelse di perdere – costretta dall’ignavia delle istituzioni calcistiche e politiche – lasciando però una traccia più pesante di molte vittorie.