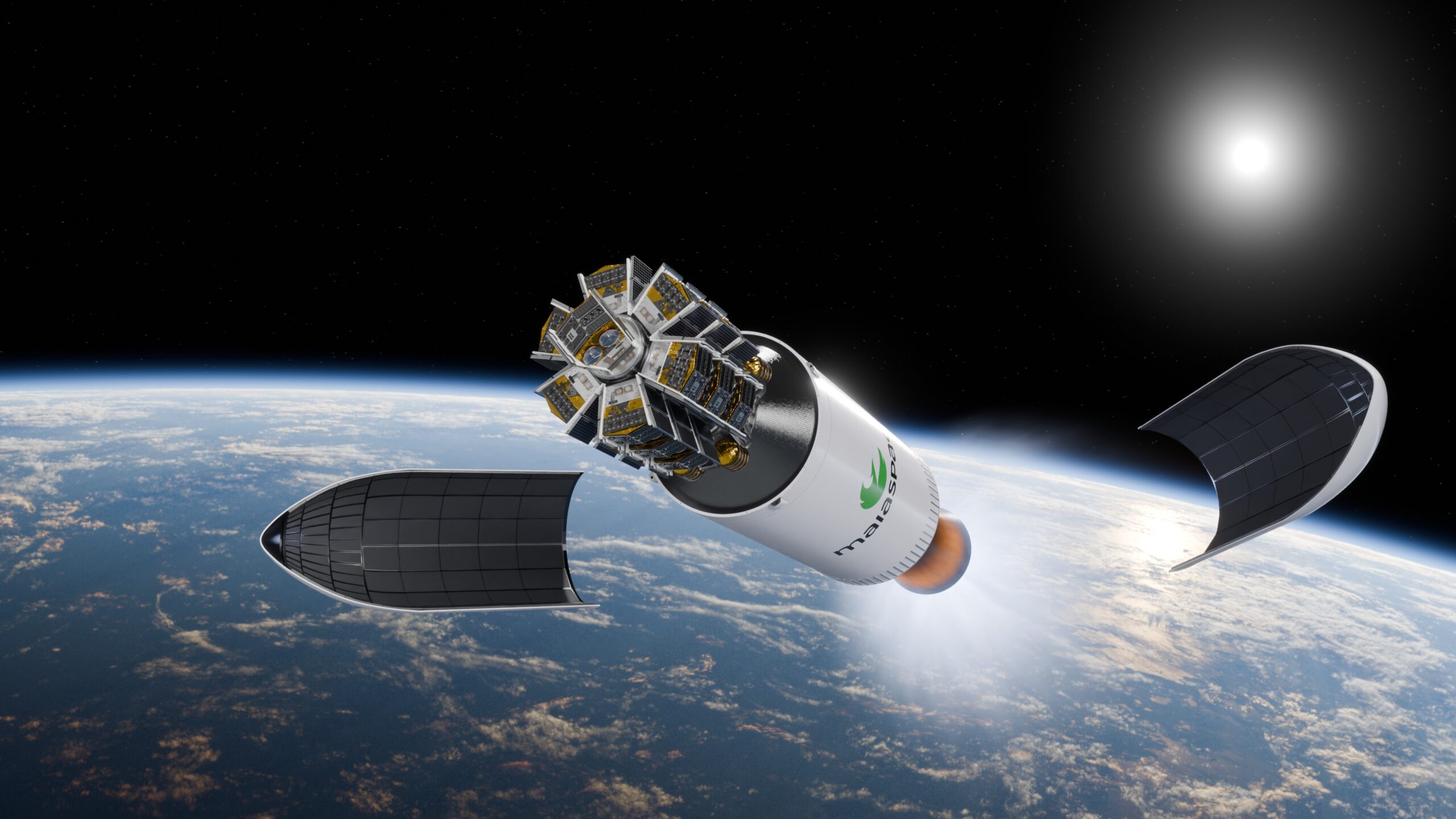Prima il cessate il fuoco poi, oggi, la consegna di tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Il secondo anniversario del 7 ottobre, il giorno in cui nel 2023 Hamas massacrò 1.194 civili israeliani e ne rapì altri 250, ha portato la buona notizia di un’intesa per far terminare le ostilità in corso nella Striscia di Gaza. Una guerra che ha causato la morte di 67mila palestinesi per la maggio parte civili e, tra questi, circa 19mila minori (i dati sono quelli del Ministero della salute di Gaza, ritenuti attendibili anche dall’Onu).
Di questi due anni l’Unione delle comunità ebraiche italiane ne ha discusso lo scorso 12 ottobre nel corso del convegno “La storia stravolta e il futuro da costruire”, ospitato nella sede del CNEL.
I NUMERI DEI REATI D’ODIO ANTISEMITA IN ITALIA E IN EUROPA
La guerra a Gaza ha avuto impatti negativi anche sulla recrudescenza di sentimenti antisemiti in Europa. I dati di un’indagine del 2024 dell’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali rilevano che il 96% degli intervistati ebrei aveva vissuto episodi di antisemitismo nell’anno precedente agli attacchi del 7 ottobre, successivamente, i media hanno segnalato un aumento sia del numero che della gravità degli episodi nei paesi dell’UE. In Italia, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel corso del Question Time alla Camera dei deputati dello scorso 8 ottobre ha ricordato i numeri degli atti discriminatori antisemiti. “L’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori – ha detto il ministro -, operante presso il ministero dell’Interno, ha registrato 733 segnalazioni per atti di antisemitismo, di cui 140 a Roma e 86 a Milano, con un fortissimo incremento rispetto al periodo pre-conflitto”.
“PREVEDIBILE UN CALO DI TENSIONE”: LE PAROLE DEL RABBINO CAPO DI ROMA DI SEGNI
Numeri che sono cresciuti nel corso del conflitto a Gaza. “Può essere prevedibile un calo di tensione, però, non sappiamo come evolveranno le cose”, ha detto a Startmag il Rabbino Capo Comunità Ebraica di Roma, Rav Riccardo Shemuel Di Segni. Riflesso, anche, di una “comunicazione unilaterale, che ha criminalizzato Israele, con conseguenze preoccupanti nella formazione dell’opinione pubblica”. Un percorso la cui rotta non è facile da riassestare. “Si sarebbe dovuto impostare una nuova narrazione. Rifarla completamente”, ha chiosato il rabbino Di Segni.
ANTISEMITISMO O ANTISIONISMO?
Antisemitismo e antisionismo sono temi sui quali le comunità europee hanno ripreso a confrontarsi. “Sin dagli anni 50’ e 60’ c’è stato uno scivolamento verso l’antisionismo che si presenta come una sorta di antisemitismo ripulito, più nobile”. A dirlo a Startmag è il prof. Claudio Vercelli, storico e docente di Studi ebraici all’Università WSUS di Poznan. “Qual è il senso di dire che si rigetta l’esistenza di uno Stato – ragiona il prof. Vercelli -? È così che va impostata la questione del conflitto israelo – palestinese. Succede che i temi del dell’indegnità etico, morale e civile degli ebrei che hanno accompagnato l’antisemitismo nel corso delle epoche sono stati rielaborati dentro i temi della indegnità storica dell’esistenza di uno Stato. Il quale è indegno proprio perché raccoglie il patrimonio culturale, storico e morale di una collettività definita ebraica”. In questo modo, secondo il prof. Vercelli, i temi antisemiti “migrano” nei discorsi antisionisti. “Dall’indegnità civile dell’ebreo all’indegnità storica dello Stato d’Israele, perché lo Stato di Israele è tutto ciò che uno stato non dovrebbe essere: parassitario, colonialista, uno stato dei ricchi”.
GENOCIDIO: UNA PAROLA CHE SERVE A “MOSTRIFICARE L’ALTRO”
Dall’idea di questa indegnità è facile che derivi la necessità di “mostrificare l’altro”. L’idea di genocidio evoca molte idee tra queste l’uccisione dell’altro fine a sé stessa”. Una forma, amplificata, di sadismo. “Il genocida è colui che trova un compiacimento, tra le altre cose, nell’assassinare una collettività o segmenti di esse, rivendica presunte ragioni razionali e l’obiettivo di ricostruire un mondo diverso, basato su categorie etnico-razziali e razziste. Il tema del genocidio è all’interno di questo dispositivo che arresta la critica, non consente dialogo”. Il genocida è un mostro. Tuttavia, mettere in dubbio la sussistenza di un genocidio nella Striscia di Gaza, non è incompatibile con l’ammissione che “a Gaza siano successe cose inaccettabili” e con considerazioni anche molto critiche nei confronti “di questo governo e di quelli che l’hanno preceduto che hanno fatto cose deprecabili”.
PRESIDIARE LA NARRAZIONE DEL CONFLITTO: LA SCONFITTA DI ISRAELE
Da un punto di vista puramente comunicativo lo Stato di Israele ne è uscito sconfitto, pur partendo dalla posizione di vantaggio di chi l’offesa l’aveva subita, non è riuscito a presidiare la narrazione del conflitto. “Ma come si fa a condurre il racconto di una guerra rendendolo più compatibile con uno sforzo di comprensione – si chiede il prof. Vercelli -? La guerra è l’azzeramento della razionalità quotidiana o, per meglio dire, la sostituzione della razionalità dei rapporti di pace a una razionalità violenta e prevaricatoria. Più che condurre una narrazione sarebbe stata utile la capacità di offrire strumenti di lettura critica che oggi è molto impegnativo e che contrasti la semplificazione e la banalizzazione”.
Un ruolo lo hanno svolto i social network e la comunicazione che su di essi viaggia veloce. “Viviamo in uno spazio virtuale – aggiunge il prof. Vercelli -. È lì che molte opinioni si formano. In una società in cui immagine, immaginario e immaginazione sono aspetti non meno importanti di dati fattuali come si riesce a veicolare un pluralismo di interpretazioni? Come si stimola il dubbio?”.
CESSATE IL FUOCO NON È LA FINE DEL CONFLITTO
Essere arrivati a un cessate il fuoco non scrive la parola fine conflitto tra Israele e Palestina. Cosa che farebbe la “soluzione due popoli e due Stati, ma è una soluzione tanto auspicabile da un punto di vista etico morale quanto impraticabile un punto di vista politico”. Una strada tortuosa. “C’è un vizio d’origine: quando lo Stato di Israele si costituì, peraltro in un lungo processo antecedente alla sua nascita nel 1948, la comunità arabo-palestinese non aveva la stessa forma di organizzazione sociale, non aveva gli stessi tempi, così come non aveva un’élite politica sufficientemente spregiudicata, capace di giocare le carte giuste sui tavoli appropriati”. Questo ha pesato, come ha pesato il fatto che il mondo arabo era organizzato secondo “categorie politiche e sociali differenti da quelle occidentali, non c’era l’idea di lealtà a un centro politico che non fosse il clan allargato. Nel caso palestinese questo è evidente: sono le grandi famiglie arabe che controllano il territorio”. Quando c’è il mutamento di regime procurato dalle due guerre mondiali “questo sistema in parte si sfalda ma non viene sostituito da un tipo di organizzazione politica stato-centrica”.
IL POPOLO SENZA TERRA E LA TERRA CON DUE POPOLI
Quindi ci sono stati due modi distinti di intendere i processi in atto. “Se dovessi andare fino in fondo, dovrei dire che l’identità palestinese si struttura negli anni ’60, ‘70. Anche se uno storico palestinese non sarebbe d’accordo con me. Un prodotto generazionale costruita dalla generazione di Arafat che si è allontanata dalla Lega araba, quello sì un prodotto coloniale – conclude il prof. Vercelli -. Se perdi il treno della storia difficilmente riesci a recuperarlo. Un popolo senza terra pensava di andare in una terra senza popolo ma il popolo c’era anche se non lo era come lo intendiamo noi”.