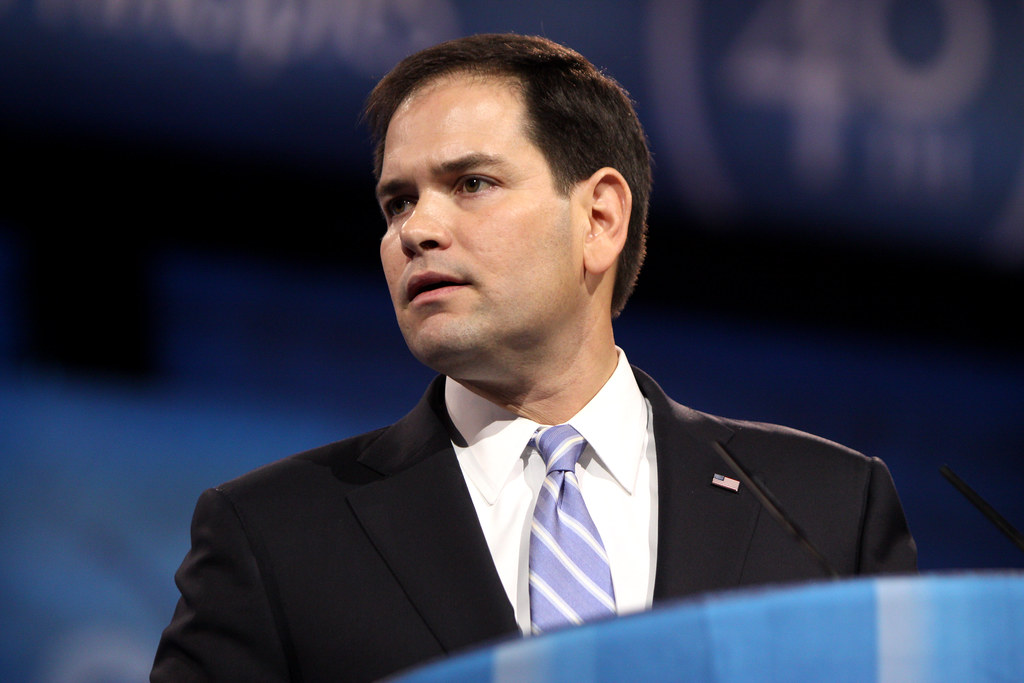Tifoserie all’attacco sui media e nelle aule parlamentari. Troppo ghiotta l’occasione e ricco il piatto della partita. Con un sol colpo si poteva accusare il Governo in carica di aver subito le pressioni dell’odiato Trump e di non aver difeso, contro i dazi, gli interessi del Paese. Anzi della Nazione, come avrebbe detto Giorgia Meloni. Che pure aveva tentato fino alla fine di evitare che il Presidente degli Stati Uniti si cacciasse in un cul de sac senza prospettive. Niente da fare. Ad impossibilia nemo tenetur. Ma nemmeno l’esistenza di questo antico brocardo (nessuno è tenuto all’impossibile) ha introdotto elementi di moderazione. E così, per una sorta di proprietà transitiva, la critica si è ritorta soprattutto nei confronti di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, di cui almeno il Pd era stato grande elettore.
Contraddizioni della politica. O meglio di una sorta di accecamento che impedisce di guardare alle cose per quelle che sono. E cercare le possibili soluzioni, nella speranza di limitare il danno. Che indubbiamente vi sarà, ma che è conseguenza di una lunga storia che ha coinvolto tutte le forze politiche italiane, con l’eccezione forse di Fratelli d’Italia, in passato da sempre all’opposizione. Bastano pochi dati per dimostrare questo assunto. Anche se i particolari dell’accordo sui dazi, che ancora mancano, impediscono una stima precisa. Tuttavia l’ordine di grandezza può essere stimata: uno 0,5% del Pil, secondo le comunicazioni del Ministro Giorgetti, al Parlamento italiano.
Troppo poco? Come si sono affannati a sostenere i teorici del tanto peggio, tanto meglio. Staremo a vedere. Per quanto ci riguarda 10 miliardi di euro non sono poca cosa. Per paura di essere fin troppo prudenti, proviamo a raddoppiarla. Non lo 0,5 ma 1 punto di Pil. Nel periodo 2014/2024 le spese per la difesa in Italia, secondo i calcoli della Nato, sono state pari in media a 22,7 miliardi di euro, pari all’1,33% del Pil. Secondo gli accordi internazionali dovevano invece essere pari a 38 miliardi: il 2 per cento del Pil. Un semplice confronto mostra quindi i conti del dare e dell’avere nei confronti di quei Paesi – gli Stati Uniti che hanno sostenuto circa il 70% della spesa complessiva – che oggi reclamano una diversa ripartizione. Anche se lo fanno con l’antipatia che è tipica di tutti i creditori.
Nell’aula di Montecitorio sono risuonate, invece, le parole indignate dell’On. Ricardo Ricciardi, dei 5 stelle. “Oggi scopriamo – testuale – che l’Italia chiederà 14 miliardi di prestito per le armi!” Indebiterà di tanto le future generazioni italiane. Una vergogna, se non un vero e proprio crimine. Purtroppo: poca attenzione ai numeri. Ma soprattutto scarsa conoscenza dei reali impegni pregressi e futuri dell’Italia. Come detto in precedenza, quei 14 miliardi di maggiori spese per la difesa equivalgono al debito contratto e non pagato di un solo anno, come mostrano le cifre precedentemente indicate. Meglio sarebbe stato allora risparmiare l’indignazione per cause meno improbabili.
Del resto se l’opposizione avesse speso qualche minuto nel documentarsi avrebbe scoperto cose di un certo rilievo. A partire dal possibile costo futuro della nuova politica commerciale destinato a scaricarsi sull’economia italiana per effetto delle decisioni assunte in quel campo di golf della Scozia. Gli accordi definitivi sono ancora scritti sull’acqua, almeno per quanto riguarda aspetti non secondari. Un dato general generico, tuttavia, è stato indicato: quella soglia all inclusive che sarà pari al 15 per cento sulle esportazioni verso gli States. L’incremento netto, considerato che in media i dazi pregressi erano pari al 4,9%, sarà quindi del 10,1%. Su questa base andrà poi aggiunta l’eventuale svalutazione del dollaro rispetto all’euro. In questo scorcio d’anno essa è stata pari, in media, al 10%. Al netto tuttavia di un 3% ch’era maturato all’inizio dell’anno. Il totale complessivo (dazio più svalutazione) porta, pertanto, il tutto al 17 per cento.
Un onere insostenibile? Talmente gravoso dal legittimare il ricorso alle barricate, come avrebbe voluto l’opposizione, in vena di rodomontate? Difficile concordare. Dalla nascita dell’euro, il dollaro ha subito una svalutazione media di circa il 15 per cento. Con alti e bassi nel corso di questi 25 anni, ma con un segno negativo sempre prevalente, salvo limitate eccezioni. Una differenza del 2% è quindi foriera di quegli sfracelli che pure sono stati preconizzati, o non si tratta di esagerazioni, almeno in parte, interessate? In tutti questi anni le esportazioni europee, anche negli Stati Uniti, hanno marcato un successo straordinario. Nonostante lo svantaggio derivante dagli andamenti valutari. Perché tutto questo, oggi dovrebbe cambiare? È solo per una differenza così contenuta?
Certo c’è sempre il rischio che il dollaro si deprezzi ulteriormente, fino a mettere fuori mercato le esportazioni europee. Ma se questo accadesse sarebbe, innanzitutto, il fallimento della politica economica americana, a causa di un tasso di inflazione destabilizzante: destinato a rendere quanto mai difficile rinnovare quel debito pubblico, che pesa come un macigno. E che, già oggi, si veda il rialzo del corso dell’oro, incontra non poche difficoltà. Come mostra lo scontro tra lo stesso Trump ed Jerome Powell il Governatore della Fed. Sarebbe uno scenario da incubo: con gli Stati Uniti in preda dell’aumento dei prezzi ed il Resto del mondo nella spirale di una preoccupante recessione.
A dimostrazione dei possibili rischi, basta citare lo scritto di uno dei supporter del Presidente, come l’economista Stephen Miran. Secondo il quale, durante il primo mandato di Donald Trump (2918/19): “il tasso tariffario effettivo sulle importazioni cinesi è aumentato di 17,9 punti percentuali dall’inizio della guerra commerciale nel 2018 al tasso tariffario massimo nel 2019. Mentre i mercati finanziari digerivano la notizia, il renminbi cinese si è deprezzato rispetto al dollaro in questo periodo del 13,7%, in modo che il prezzo di importazione in USD posttariffa sia aumentato del 4,1%. In altre parole, la variazione valutaria ha compensato più di tre quarti della tariffa, spiegando la trascurabile pressione al rialzo sull’inflazione.“ Per cui l’onere dell’aggiustamento si è scaricato interamente sull’economia cinese.
Queste quindi le conseguenze di una possibile rivalutazione del dollaro anche rispetto all’euro. Ma se si verificasse il contrario, come in effetti sta avendo, quella relativa tranquillità verrebbe meno. Sarebbero gli Stati Uniti nella bufera e forse lo stesso inquilino della Casa Bianca costretto a rivedere le sue posizioni.