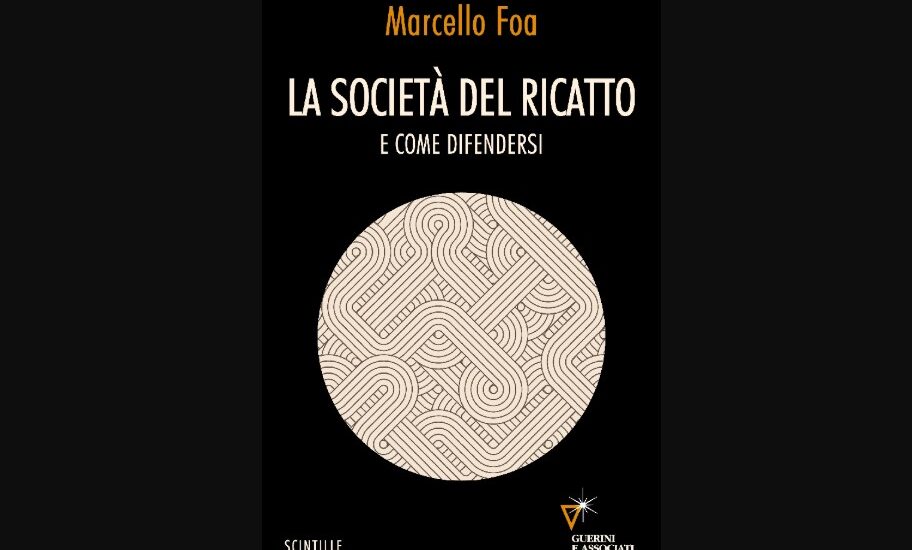Marcello Foa non ha bisogno di presentazioni. Dal visionario “Gli stregoni della notizia” del 2006, a cui ha fatto seguito l’atto secondo nel 2018. Passando per “Il sistema invisibile” del 2022 e per terminare al suo ultimo saggio “La società del ricatto”, pubblicato nel 2025 da Guerini e Associati.
Sempre almeno un paio di giri avanti nello spiegare i complessi, delicati e spesso oscuri meccanismi che governano il mondo dell’informazione e dei media in generale e denunciarne le storture. Sempre con la soddisfazione di vedere qualche anno dopo l’informazione mainstream accodarsi alla sua lettura di quel mondo.
“La società del ricatto” esplora la pervasività del ricatto come fenomeno sistemico che corrode i valori della società contemporanea. La tesi centrale è che il ricatto, inteso come strumento di coercizione e manipolazione, si manifesta in molteplici ambiti: dalla politica internazionale alle dinamiche aziendali, dai rapporti familiari alle relazioni personali. Questo “virus subdolo” erode l’autenticità dei valori proclamati, come la meritocrazia, la democrazia e il rispetto reciproco, senza che la società ne sia pienamente consapevole. Foa propone un’analisi multidisciplinare, per evidenziare le connessioni tra contesti apparentemente lontani, con l’obiettivo di stimolare una presa di coscienza e suggerire strategie di difesa. Il saggio non si limita a denunciare, ma cerca di offrire un percorso costruttivo verso il recupero di valori autentici.
Sono questi i capisaldi di cui abbiamo discusso con l’autore e che vi raccontiamo di seguito.
Il libro impressiona per la descrizione della numerosità e della vastità degli ambiti in cui si manifestano i ricatti.
Politica: soprattutto attraverso la character assassination, ovvero la distruzione della reputazione personale dei politici.
Relazioni internazionali, infatti a livello geopolitico, il ricatto è uno strumento delle “guerre asimmetriche”, che mirano a sottomettere uno Stato senza conflitti aperti.
Economia e nel lavoro: il ricatto si manifesta quando il capitalismo si trasforma in “debitalismo”, con individui e aziende intrappolati da debiti insostenibili, come mutui a lungo termine che limitano la libertà personale; nel mondo del lavoro, il ricatto si concretizza in culture aziendali tossiche, dove il mobbing, il nepotismo e il servilismo prevalgono sul merito.
Relazioni personali: a proposito delle quali Foa esplora il ricatto emotivo nelle relazioni familiari e di coppia.
Un elenco impressionante, puntualmente arricchito da esempi e casi che le cronache di questi anni hanno dettagliatamente descritto. Foa ritiene che ci sia stato un unico brodo di coltura: il silenzio, la mancanza di consapevolezza. Il ricatto prospera col silenzio del ricattato e perde di efficacia quando se ne parla. E qui intravediamo già un primo elemento della pars costruens. È il mercato, inteso nella sua più ampia accezione, che impedisce i ricatti, li rende vani, demolisce le rendite di posizione, le forche caudine da cui bisogna obbligatoriamente passare.
Quando a Foa abbiamo fatto notare che dovremmo avere degli organismi sovranazionali (UE, Onu, Wto, Fmi, Ocse…) che nei diversi ambiti di competenza dovrebbero regolare la capacità di minaccia o di vera e propria estorsione, la risposta è stata quella dello schiacciatore di pallavolo che riceve l’alzata perfetta, e non lascia spazio a dubbi: quelle istituzioni, aldilà della terzietà di facciata, sono là per assecondare un disegno, che non è certamente quello dei riequilibrio dei rapporti di forza e del potere di coercitivo di una parte politica o di una Nazione sull’altra.
Per Foa, siamo ancora lontani da un adeguato sistema di pesi e contrappesi che impediscano la la prevaricazione e bilancino i rapporti.
Niente affatto tenero anche con la stampa. Spesso veicolo dei ricatti più beceri, dove viene utilizzata come “buca delle lettere”. Sotto questo aspetto è rilevante il ruolo dei social come strumento di pluralismo e ampliamento del panorama informativo.
Nell’ultimo capitolo, Foa propone un approccio costruttivo per contrastare la cultura del ricatto. La chiave è la consapevolezza: riconoscere il problema è il primo passo per sviluppare anticorpi sociali e personali. In politica, invita a superare la character assassination e a promuovere un confronto basato su idee e programmi, ridando fiducia ai cittadini. Nelle relazioni internazionali, suggerisce di perseguire una leadership basata su valori autentici, come auspicato dal discorso di J.D. Vance a Monaco nel 2025.
C’è bisogno di situazioni e soggetti che “rompano gli schemi” e va riconosciuto a Donald Trump che sta interpretando molto bene questo ruolo. Anche aldilà del merito delle decisioni politiche finora prese.
In economia, raccomanda di riscoprire il liberalismo di Einaudi, opponendosi a monopoli e promuovendo concorrenza e creatività. Nel lavoro, le aziende devono valorizzare il merito e bandire pratiche tossiche. A livello personale, Foa insiste sull’importanza di riconoscere i segnali del ricatto emotivo, come gelosia eccessiva o manipolazione, e di cercare supporto da amici, familiari o psicoterapeuti. Citando Tolstoj e Gandhi, sottolinea che il cambiamento inizia da noi stessi: coltivare l’autenticità e il rispetto reciproco è l’antidoto alla società del ricatto.
In conclusione, “La società del ricatto” è un invito a guardare oltre la superficie della realtà, unendo i puntini tra macro e micro dinamiche per comprendere il ricatto come vizio sistemico della nostra società. Foa non propone soluzioni semplicistiche, ma un percorso di consapevolezza e azione, individuale e collettiva, per preservare i valori che rendono la società giusta e umana. Il saggio si chiude con un messaggio di speranza: il Bene, perseguito con autenticità, può sconfiggere il Male del ricatto, rendendo possibile un mondo più libero e rispettoso. “Scuotiamo l’albero”, ci ha detto Foa al termine della conversazione.