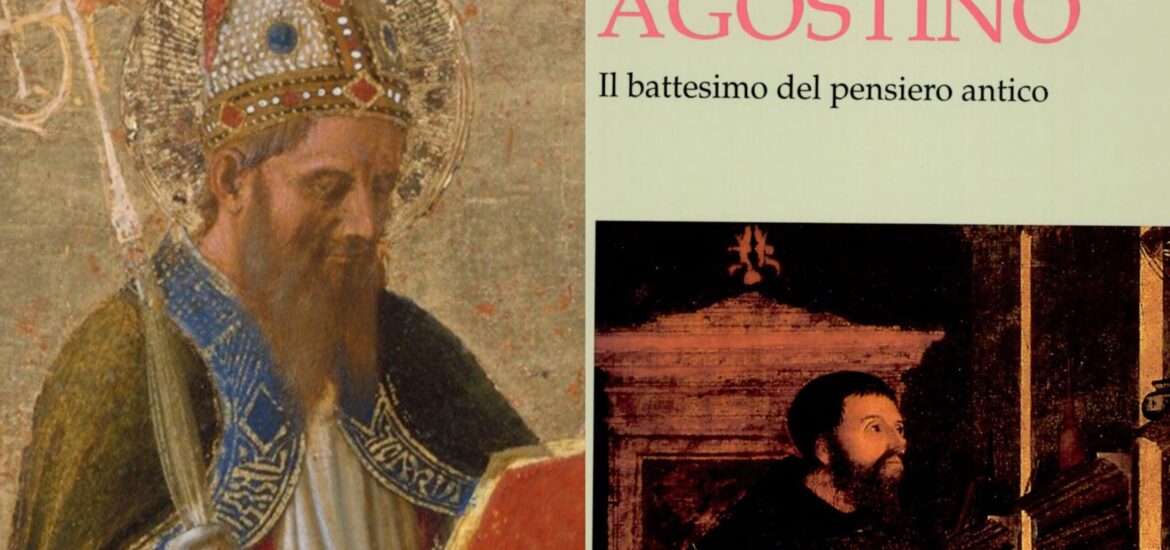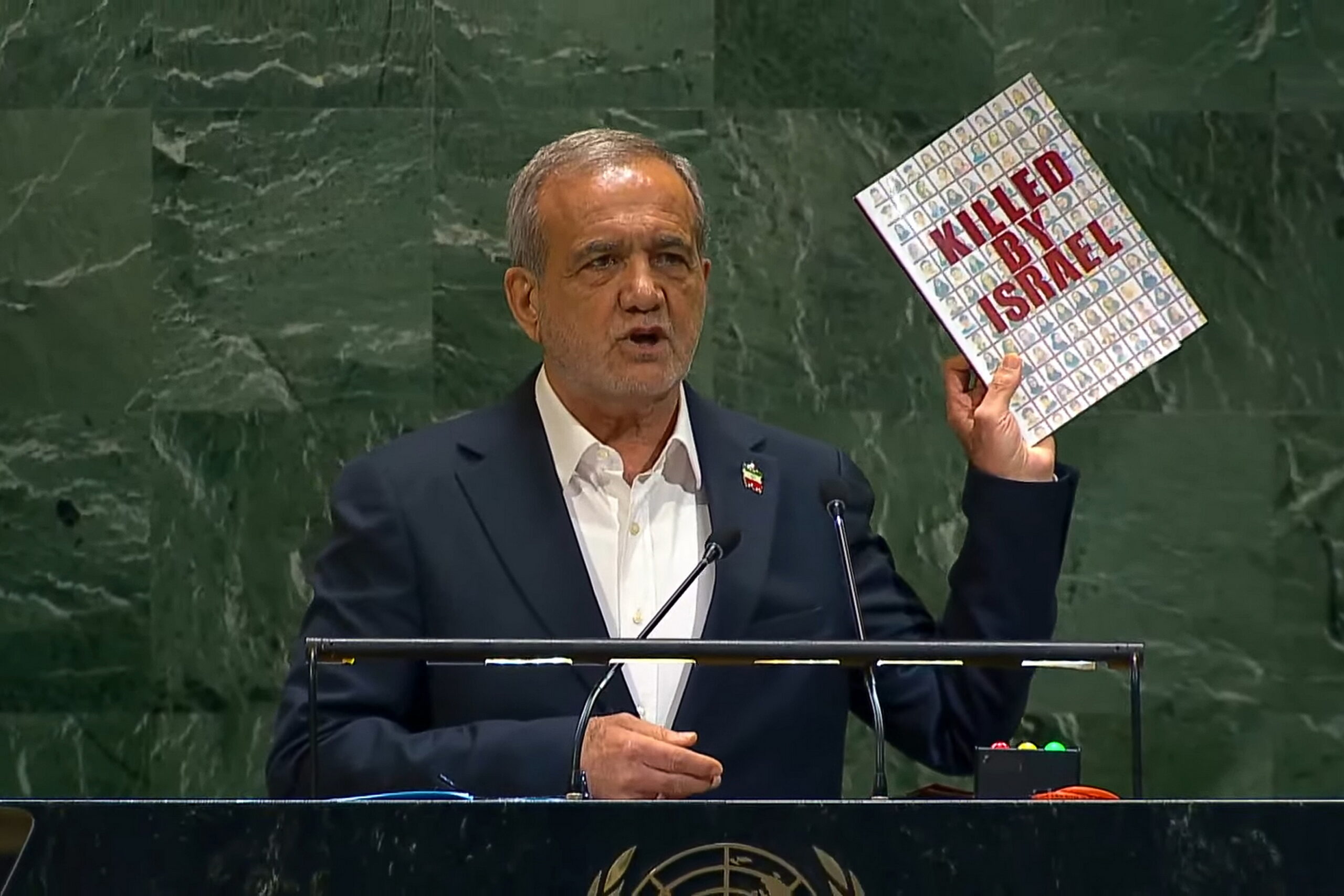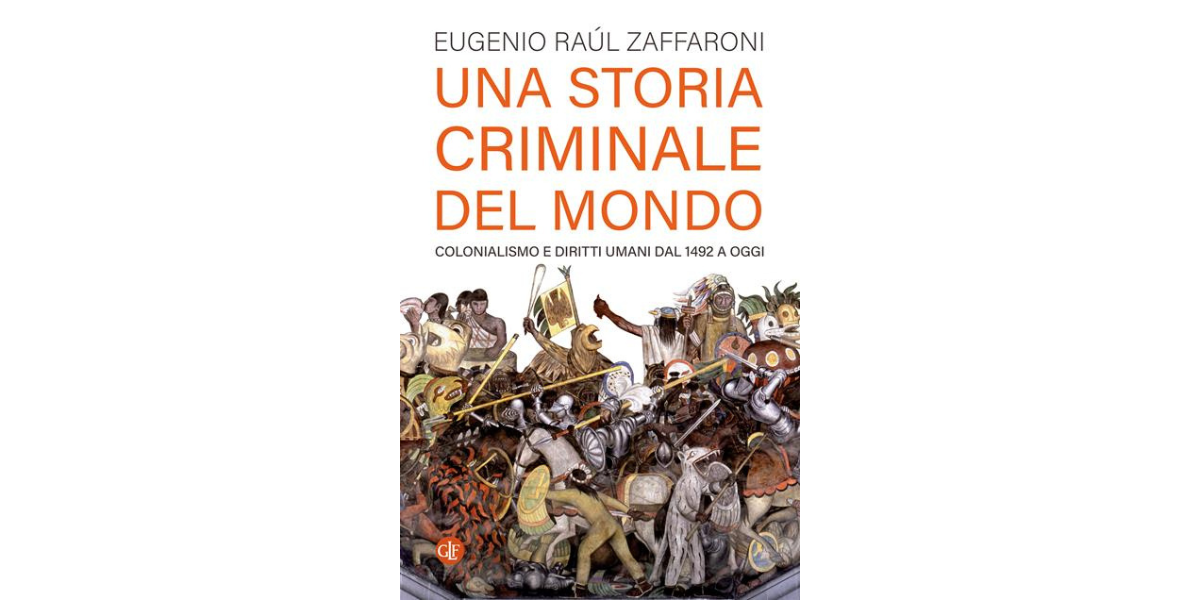Lo studioso inglese di filosofia antica John Rist, nella sua opera dedicata ad Agostino ha posto un problema la cui soluzione risulta problematica per ogni teodicea, ovvero per ogni tentativo di scagionare Dio dalla responsabilità del male: la sofferenza degli innocenti. In effetti, la spiegazione di tale fenomeno appare molto difficile: come può Dio permettere che una persona virtuosa e “senza macchia” patisca grandi dolori e subisca immani tragedie? In altre parole, come può essere giusto quando punisce i “buoni”? (“Agostino: Il battesimo del pensiero antico”, Vita e Pensiero, 1997).
Pensiamo alle deformità mentali e fisiche dei bambini. C’è una distinzione fra i “mali naturali”, quelli che ci colpiscono indipendentemente dalle nostre azioni, e i “mali morali”, quelli che invece siamo noi a causare attraverso i nostri crimini e peccati. Sebbene tale distinzione non possa essere cancellata, le sofferenze dell’innocente sono sofferenze genuine, quali che siano le loro origini. Perché, allora, accadono? Vi sono infatti fenomeni che sembrano esulare da quella logica di azione e reazione che riguarda il male come corruzione: parrebbe, insomma, che non tutti i mali naturali siano riconducibili a semplici punizioni dei nostri peccati.
Se il sorgere di alcune malattie fisiche è causato, per esempio, dall’amore deviato per alcune bevande o alcuni cibi, se la debolezza e la disgregazione del corpo hanno spesso il loro principio in uno stile di vita che predilige, amandole, le creature rispetto al loro Creatore, come possiamo comprendere l’insorgere del male fisico in un neonato, o in chi ha dedicato la propria esistenza o servire autenticamente Dio? Gli innocenti sembrano patire le stesse pene di chi si è volontariamente allontanato dal Padre. Le possibili risposte al problema posto da Rist sono due. La prima è lo stesso Rist a formularla, sulla scorta dell’interpretazione agostiniana del peccato originale:
“In quanto discendenti di Adamo siamo tutti membri della ‘moltitudine del peccato’, colpevoli del peccato di Adamo. Dal momento che siamo tutti colpevoli, siamo tutti puniti. […] Dal momento che Dio è giusto, allora, può permettere le sofferenze del genere umano, in particolar modo dell’innocente, solo per una di queste due buone ragioni: o per punirlo a causa di una colpa reale -il peccato di Abramo che tutti noi condividiamo-, oppure per iniziare il processo di purificazione dell’anima umana. Dunque, il castigo, in senso lato, è purificatore o punitivo, o forse una combinazione delle due cose, e in un mondo governato da un Dio giusto non ci può essere altra spiegazione della sofferenza apparentemente inspiegabile e immeritata. Soffriamo perché siamo colpevoli e dobbiamo soffrire”.
Si può dunque essere colpevoli qui e ora, e quindi essere puniti per un peccato che abbiamo concretamente compiuto nel corso della nostra vita, oppure si può essere colpevoli semplicemente in quanto figli di Adamo; nell’uno e nell’altro caso la colpevolezza è comunque un dato. Questa prima risposta dunque riconduce tutti gli uomini, dai presunti innocenti ai peccatori più incalliti, alla loro radice comune, cioè quella del peccato originale, mostrando che non vi è un singolo uomo che non possa essere dichiarato colpevole: ogni uomo ha già da sempre peccato in Adamo.
La giustificazione presentata da Rist assomiglia più che a una soluzione dell’impasse filosofica, alla dissoluzione del problema: un procedimento, questo, che sarà poi caro ad un filosofo come Ludwig Wittgenstein. Una volta mostrato “che non esistono uomini innocenti, la sofferenza di quest’ultimi costituisce uno pseudo-problema. Non si tratta quindi di dare ragione della sofferenza di un innocente, quanto invece, rovesciando i ruoli di interrogante e interrogato, di chiedere, a chi prima esigeva una spiegazione, il motivo per cui abbia presupposto qualcosa come l’innocenza di chi soffre” (Roberto Silvestrin, “Agostino e il male. La polemica antimanichea”, Università Ca’ Foscari, 2013).
Questa prima risposta, per quanto sia coerente con il pensiero di Agostino, fa riferimento al pensiero del filosofo nella sua ultima fase di elaborazione, quella legata al tema della Grazia. C’è però anche una seconda risposta, rintracciabile in un passo del “Manuale della fede, della speranza e della carità” (“Enchiridium ad Laurentium”, 421): “[Dio] ritenne preferibile infatti operare il bene a partire dal male, anziché non lasciar sussistere alcun male”.
Qui Agostino affronta la grande questione del rapporto tra il male ed il bene che da esso può scaturire, ossia come il male venga ricompreso nell’ordinamento divino e provvidenzialistico dell’universo. Infatti il male, secondo l’Ipponate, pur non essendo voluto da Dio, è da lui però tollerato, sempre e comunque in vista di un bene più alto. Se il male non è contemplato nel progetto originario della creazione, una volta che si introduca un elemento di disordine nel creato, esso viene impiegato da Dio al fine di produrre un bene più grande. L’onnipotenza di Dio si manifesta perciò anche nel rovesciamento da lui operato dopo che il male ha fatto il proprio ingresso nel mondo a causa del peccato.
Non lasciando la possibilità che si producesse alcun male, Dio avrebbe negato all’uomo il suo libero arbitrio e il merito di resistere alla tentazione: preferì allora la trasfigurazione del male in un bene maggiore rispetto alla pura, semplice -e deterministica- assenza di male. In che modo tutto questo può giustificare la sofferenza degli “innocenti”?
Innanzitutto il dolore e la pena sofferti dai virtuosi potrebbero essere una prova decisa da Dio per verificare l’effettiva saldezza della fede e del servizio all’Onnipotente. Dimostrando a Dio la propria devozione anche tra le sciagure più terribili, un innocente sarebbe ricompensato con la vita eterna, bene infinitamente maggiore rispetto all’assenza di dolore nella vita terrena. In secondo luogo, egli svilupperebbe la virtù tipicamente cristiana della sofferenza, cioè la virtù tipica di chi sa caricarsi il dolore sulle spalle, cogliendone il significato più profondo in relazione all’esistenza umana.
Le disgrazie rappresentate dalle deformità e dalle malattie dei propri figli, ad esempio, potrebbero significare il punto di partenza per il progresso morale di un’intera famiglia, la quale può ricavare momenti di gioia infinita nel constatare anche solo dei piccoli miglioramenti nella condizione di chi soffre il male. Il male non ha pertanto un’esistenza assoluta: il male non è mai soltanto un male, proprio perché da ogni male Dio può sempre ricavare un bene ancor maggiore rispetto a quello che avremmo avuto in sua assenza.
La demolizione kantiana della teodicea e gli orrori del “secolo breve” hanno contribuito al rigetto della dottrina agostiniana che nega la realtà del male. Il punto di vista di Søren Kierkegaard, secondo cui il massimo che la filosofia possa fare è dare conto dell’incomprensibilità del male, è stato così assunto anche da un teologo protestante come Karl Barth e da due filosofi cattolici come Paul Ricoeur e Luigi Pareyson. Barth affronta il problema del male nella “Dogmatica ecclesiae” (1939), in cui il male è il Nulla, e il Nulla è ciò che Dio ha rifiutato. Proprio per tale motivo esso è incomprensibile. Questa tesi è stata accolta da Pareyson, mentre la posizione di Ricoeur è ancora più drastica: l’uomo di fede crede in Dio a dispetto del male.
Dopo queste noterelle, mi sia consentita un’ultima considerazione. Quando scoppia un’epidemia, una guerra, un terremoto, non scomodiamo l’Altissimo. La crisi del “Dio-tappabuchi” (l’espressione è del pastore luterano Dietrich Bonhöffer, impiccato dai nazisti nel 1945), acuita in misura irrimediabile dal trauma della Shoah, dovrebbe aver congedato definitivamente l’idea di un male strumentale che serve a far meglio risplendere la bontà di un Dio sapiente alchimista, ovvero che trae il bene dal male.