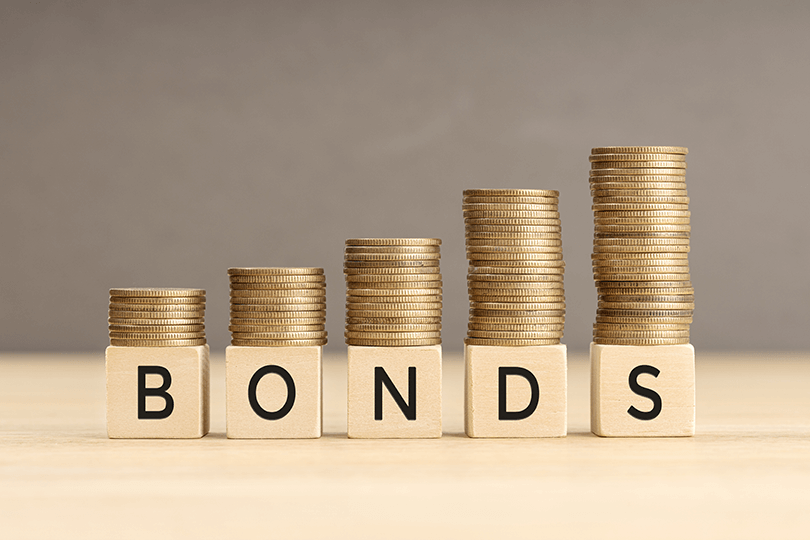Le elezioni politiche di ieri in Germania, per alcuni un “test di democrazia”, sono state le più importanti degli ultimi anni. La Germania si trova a un nuovo crocevia della storia, ortocentro di un triangolo politico rappresentato dal disimpegno americano, dal “negazionismo” dell’Europa occidentale che ha messo la sicurezza militare in fondo alla lista delle priorità, dalla determinazione russa a perseguire gli obiettivi neoimperialisti di espansione territoriale.
A dominare le elezioni sono stati però i problemi interni, delimitati dal perimetro di un altro triangolo, quello che ha governato il modello di crescita della Germania per decenni e i cui vertici sono stati l’energia a basso costo fornita dalla Russia, l’assorbimento del surplus manifatturiero fornito dalla Cina, la sicurezza militare fornita dagli Stati Uniti.
Quel modello è stato spazzato via e la Germania è di nuovo il “malato d’Europa”, come titolò l’Economist nel 1999; in una sorta di nemesi, il paese che è stato modello di virtù economica e politica si scopre povero e vulnerabile.
A guardare bene, la crisi tedesca non è originata solo dai cambiamenti nello scenario internazionale, in realtà viene da lontano, le vulnerabilità di oggi sono il frutto velenoso di un malinteso senso della disciplina economica, esito di decenni di inerzia e di miopia.
Angela Merkel è stata una brava amministratrice ma incapace di slanci riformisti, le ultime riforme furono realizzate tra il 2003 e il 2005 dal governo Schroeder sul mercato del lavoro. Misure impopolari che costarono al Cancelliere la rielezione ma assicurarono alla Germania anni di successo.
Da allora i governi tedeschi non hanno promosso altre riforme ma solo politiche neo-mercantiliste, tutte le fiches sono state puntate sulla supremazia tecnologica e sulle esportazioni.
Il successo economico, la stabilità e i legami troppo stretti tra industria, banche e politica hanno offuscato la percezione della realtà, le élite industriali e politiche non hanno visto i segni dei cambiamenti, la rivoluzione digitale del XXI secolo ha trovato una Germania impreparata, tecnologicamente arretrata, dipendente dalla Russia e dalla Cina.
A quella miopia si è aggiunto l’orrore per il debito, termine che in tedesco coincide con la parola “colpa”, e dal mito dello “schwarze null”, il vincolo del pareggio di bilancio inserito nella Costituzione nel 2009. Il “freno al debito” è stato però anche un pericoloso freno agli investimenti pubblici.
I Land orientali sono stati lasciati senza adeguato sostegno. Nei trentacinque anni dalla caduta del Muro le differenze economiche tra le due Germanie sono state attenuate ma i Land della ex Repubblica Democratica sono ancora i più poveri, con la popolazione più anziana, i salari medi e i tassi di risparmio sono di molto inferiori a quelli dei connazionali dell’Ovest. Delle 500 più grandi aziende tedesche, meno di una quarantina hanno sede nella parte Est del paese, la condizione di povertà e la percezione dell’abbandono sono state il brodo di cultura del consenso per l’AfD, alimentato dai sentimenti del rancore e della rivalsa.
Come previsto dai sondaggi, il risultato delle elezioni consegna la vittoria al leader della CDU Friedrich Merz, precipita il partito dell’ex cancelliere Scholz e Alternative für Deutschland, il partito che flirta con il passato nazista e che piace a Trump e a Putin, ha raddoppiato i consensi rispetto al 2021.
Ci vorranno settimane per formare una coalizione di governo e se è chiaro che Merz non vorrà essere ricordato come il Cancelliere che avrà fatto cadere il “Brandmauer”, il “muro di fuoco” che esclude dal governo l’estrema destra dalle simpatie neonaziste, è ancora presto per speculare su come il neo-Cancelliere costruirà la coalizione di governo. È probabile una riedizione dell’alleanza con la SPD, l’”usato sicuro” che dovrebbe assicurare stabilità all’azione di governo e rassicurare anche i mercati.
A poche ore dalla chiusura delle urne, Merz si è affrettato a dichiarare che la Germania dovrà affrancarsi dalla tutela degli Stati Uniti e ripensare alla radice gli accordi sulla sicurezza. Merz è un europeista convinto, è probabile che avrà con il presidente francese una sintonia migliore di quella del suo predecessore Scholz.
L’altro argomento cruciale che il nuovo governo dovrà affrontare è relativo alla questione del debito e del freno previsto dalla Costituzione: la crisi economica, le condizioni delle infrastrutture e l’arretratezza digitale richiederanno investimenti pubblici e creazione di nuovo debito. Durante la campagna elettorale nessuna forza politica si è esposta su questo aspetto temendo di apparire “spendacciona” e irresponsabile. Ma la crisi della Germania è esito anche dell’avversione alla spesa; i mercati ci sperano, l’euro si sta rafforzando sulla previsione di investimenti pubblici in Germania e in Europa.
Gli investitori tornano a credere nell’Europa o, perlomeno, nei suoi mercati. I listini europei hanno segnato (finalmente) un’inversione attesa da molto. Crescono i dubbi e torna l’attenzione agli investimenti anche al di fuori dagli Stati Uniti. La migrazione dai costosi titoli tecnologici americani, i dati economici in Europa migliori del previsto, la politica espansiva della banca centrale hanno sostenuto le performance in queste settimane di avvio d’anno.
Le elezioni in Germania hanno tolto un elemento di incertezza, è stato evitato il “wurst-case scenario”, quello di una affermazione eclatante dell’estrema destra, si è però formata una “minoranza di blocco” con l’AfD a quasi il 21%, che si oppone agli aiuti militari all’Ucraina e all’allentamento del freno al debito, e con Die Linke a circa il 9%, contraria alla spesa in armamenti ma favorevole all’allentamento dei vincoli al debito.
L’appuntamento è ora con la coalizione che Friedrich Merz dovrà comporre nelle prossime settimane.