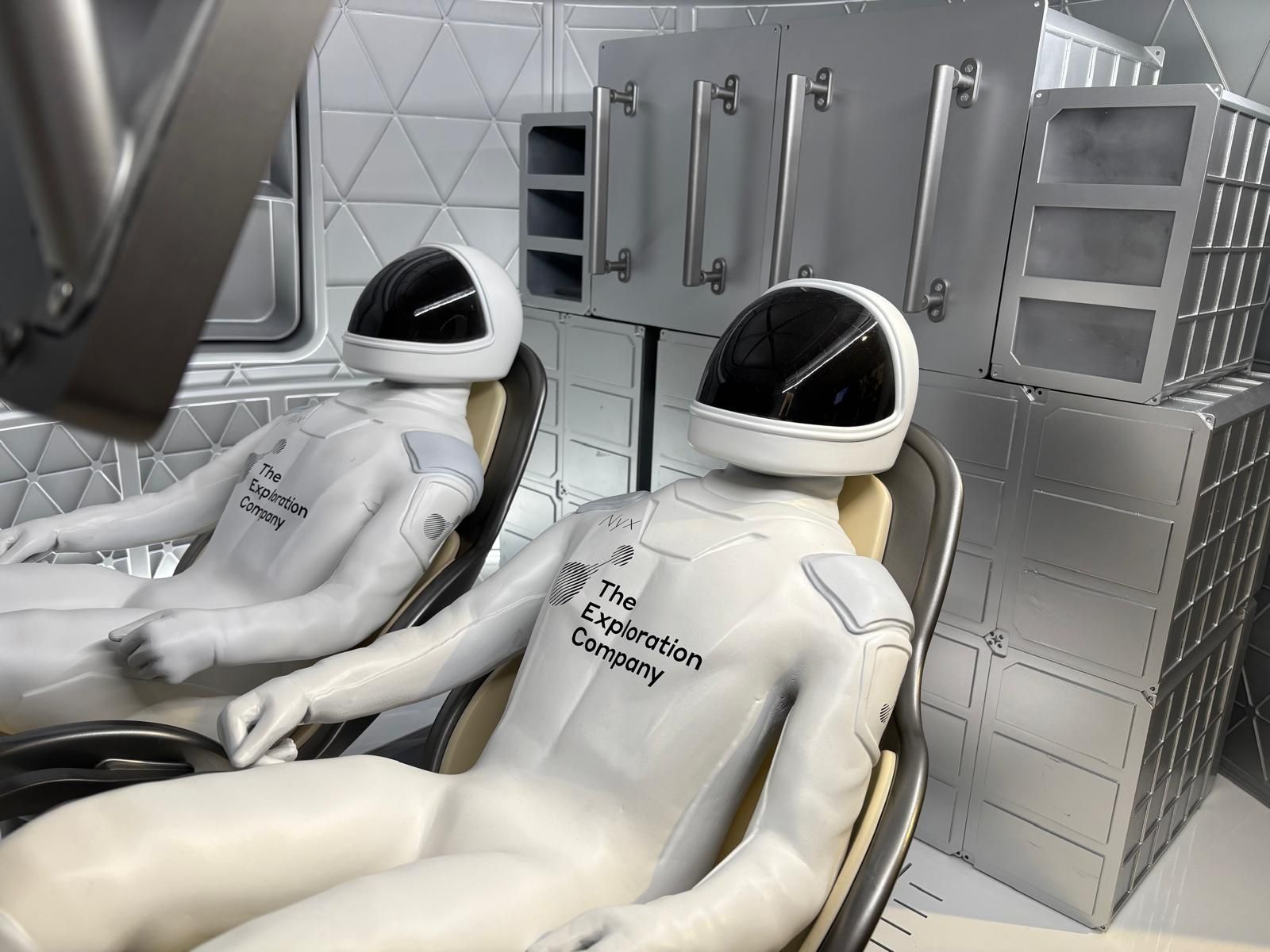Le dichiarazioni del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dello scorso 12 ottobre sulla strategia di salvataggio di Alitalia, forse premature nei tempi, forse ingenue nell’ampiezza dei dettagli, sono servite in ogni caso a ridare fiato alle analisi degli alfieri italiani del liberismo. Una filosofia della politica che, nella versione italiana, sarebbe meglio declinare come liberalpopulismo, ovvero il pendant ideologico del tanto deprecato nazionalpopulismo che sembra ora godere dei maggiori favori dell’opinione pubblica nazionale. Il tema principale su cui in tanti si stanno dilettando da giorni è quello dello spreco dei pubblici danari nel finanziamento della compagnia di bandiera.
Nella furia investigativa dei liberalpopulisti sono stati scomodati perfino gli antichissimi governi degli anni ’70 per denunciarne l’allegra prodigalità nei confronti dell’azienda. Si parte, nell’elenco della denuncia, dal governo Moro del 1975 e, attraverso Andreotti, nel 1976 e nel 1977, Cossiga nel 1980, Spadolini nel 1981, Craxi tra il 1983 e il 1985, De Mita nel 1988 e ancora Andreotti nel 1990 si carica sulle spalle di questi defunti, e non ce ne voglia De Mita felicemente e brillantemente ancora attivo, la responsabilità di aver promosso aumenti di capitale, attraverso la holding dell’IRI, per un totale monetario, attualizzato ai valori di oggi, di 1,9 miliardi di Euro. Gli aumenti di capitale che l’azionista ha fatto sono presentati come sperpero politico del pubblico danaro. Nessuno degli alfieri sembra essersi chiesto a cosa mai quei denari possano essere serviti.
Se accanto alla lista degli aumenti di capitale si producesse l’altrettanto analitica lista degli investimenti realizzati dall’azienda in quei medesimi anni si scoprirebbe che, nei quindici anni tra il 1976 e il 1991, Alitalia ha investito nell’acquisizione di 18 B727, 12 B747, 13 A300, 89 MD82, 44 A321, 8 MD11 per un valore totale, attualizzato, pari 6 miliardi di euro. A mettere accanto le due liste emerge dunque una sorta di rendiconto delle fonti e degli impieghi di un’azienda che sembrerebbe non aver usato quel danaro per arditi, rischiosi, imprudenti, incongrui atti. In effetti una compagnia aerea trasporta persone e merci e, per poterlo fare, si dota di aeroplani al pari di un fabbricante di abiti che si dota di telai o un fabbricante di merendine che si dota di forni. E l’azionista dell’impresa, come in ogni mercato, si presenta alle banche chiedendo di finanziare gli acquisti e dimostrando di crederci lui per primo all’impresa attraverso il conferimento del proprio capitale.
Certo, ci sarebbe da chiedersi come mai l’azionista si limitò allora ad un ratio equity/debt del 31% in un’epoca in cui i tassi bancari raggiungevano perfino il 20%. Forse, una più attenta valutazione finanziaria avrebbe potuto portare a considerare una partecipazione maggiore del capitale proprio all’investimento. E questo avrebbe evitato per i circa vent’anni successivi, fino al 1998 almeno, l’esborso annuale di interessi sul debito compreso in un arco fra 400 e 800 milioni di euro. Tant’è, ma ancor più interessante è forse notare che dal 1991 in avanti la compagnia non fa più investimenti importanti in flotta, limitandosi, nei quasi trent’anni intercorsi, a mere, sporadiche, disorganiche, sostituzioni di macchine oramai obsolete e superammortizzate.
Inoltre, l’arresto del flusso di investimenti nell’ammodernamento e ampliamento della flotta ha coinciso con la fase di pieno dispiego della deregulation in Europa, quando, posto termine al regime di oligopolio, sarebbe stato necessario più che mai adeguarla, in quantità e qualità, al nuovo scenario di selvaggia concorrenza. Invece, per estremo paradosso, le mere sostituzioni sono state fatte in modalità che gli esperti definiscono, con magna pompa, downgauging, ossia la diminuzione della capacità unitaria degli aeromobili.
Cosa è successo dopo il 1991? Perché mentre ogni altra compagnia in Europa si affrettava ad incrementare la flotta con il capitale degli azionisti, prevalentemente ancora pubblici, ma ugualmente quelli privati, Alitalia ha interrotto gli investimenti? La risposta è semplice e si legge nella famigerata lista degli ‘sprechi’ addebitati ai governi. Dopo l’ultimo aumento di capitale promosso dal governo Andreotti, nel 1990, per 464 milioni di Euro vi è un lungo buco temporale di ben sette anni durante il quale la compagnia non avendo il supporto dell’azionista non può investire per fare bene il suo mestiere nel nuovo e selvaggio scenario in cui all’orizzonte appare perfino l’onda barbarica delle compagnie low cost.
Finalmente nel 1997 il governo Prodi sembra reinvestire e, da allora, altri governi, fino all’ultimo recente governo Gentiloni iniettano nella compagnia ben 4,6 miliardi di Euro. Che cosa è stato fatto di questa massa di danaro certo ingente? E’ servita forse per fare feste e festoni? Purtroppo no. Le nuove norme europee varate nella metà degli anni ’90 e divenute sempre più ferree da allora, in omaggio allo spirito liberalpopulista che non risparmia nemmeno l’Europa, hanno stabilito una discriminazione cruciale fra l’azionista pubblico e quello privato.
Al secondo è concessa ogni cosa, nello spirito del liberismo, al primo non è più concesso di investire liberamente dal momento che il capitale pubblico, nella aziende di proprietà in fase critica, è considerato ‘aiuto di Stato’ e questo può essere concesso alle seguenti condizioni, one time, only time e comunque non può essere utilizzato per finanziare sviluppo e crescita ma solo ‘ristrutturazioni’ dove il termine è l’eufemico sinonimo di ridimensionamenti. Purtroppo però, in un mercato di esasperata concorrenza, ridimensionarsi vuol dire perdere competitività a favore della concorrenza.
E’ come se il proprietario di un’impresa che produce merendine impiegasse il suo capitale non per aumentare la produzione e conquistare il maggior numero di scaffali possibili nei punti di distribuzione, ma per fare esattamente il contrario, cedere, al costo del proprio capitale, interi scaffali agli altri concorrenti che producono merendine. Alitalia ha dovuto, non voluto, dovuto impiegare i 4,6 milioni di euro ricevuti dal 1998 ad oggi per ridurre la flotta, ridurre la capacità unitaria dei propri aerei, licenziare il suo personale e ridurne i salari, oltre che astenersi da pratiche commerciali orientate all’incremento delle quote di mercato.
Nel 2008 il governo italiano di allora ha ritenuto che ostinarsi a iniettare capitali come ‘aiuti di Stato’ fosse inutile e ha passato la proprietà della compagnia di bandiera ai privati, liberi sì di investire come, quanto e dove lor pare. Purtroppo, i privati italiani non hanno sostenuto gli investimenti richiesti dal mercato e hanno invece continuato la sciagurata strategia del downsizing arrivando, nel 2014, prossimi al fallimento.
A quel punto il governo italiano ha ritenuto che forse era meglio passare la mano ad una grande compagnia straniera senza affanni finanziari, ma anche Etihad non ha investito il capitale nello sviluppo dell’offerta proseguendo nel famigerato downsizing. E il ridimensionamento ha generato ulteriore inefficienza, perdita di competitività e perdite finanziarie. Insomma, si potrebbe concludere che i 4,6 miliardi di Euro di capitale pubblico conferito dal 1998 in Alitalia, ai quali vanno aggiunti gli accolli di circa altri due miliardi di oneri sociali per licenziamenti e casse integrazioni speciali, sono stati in effetti il contributo dello Stato italiano allo sviluppo di ogni altra compagnia europea che, facendo strame della derelitta Alitalia, ha registrato incrementi e successi con il traffico di passeggeri e merci che l’Italia produce.
Se oggi Alitalia è certamente irrilevante per dimensioni raggiunte, tale non è il traffico prodotto dal nostro paese. Rassegnarsi all’idea che questa miniera debba essere ceduta definitivamente ad imprese e proprietari i provenienti da altrove equivale a rassegnarsi all’ineluttabilità del declino italiano. Piuttosto che flagellarsi nel denunciare la genetica incapacità nazionale a fare impresa, i tanti cervelli di questo paese potrebbero forse ingegnarsi a trovare soluzioni ai problemi.
Paolo Rubino ha lavorato in Alitalia occupandosi di marketing, operazioni, flotta e commerciale tra Roma, Milano e New York. Ha contribuito, nel periodo tra il 1995 e il 1998, alla fondazione e ai primi successi di Air One. Dal 2010 ha fondato la società di consulenza direzionale d&r advisors con la quale ha sviluppato progetti in particolare nei settori del petrolio e gas e delle public utilities. Attualmente è alla guida di tre società, di cui una negli Stati Uniti che opera nel settore petrolifero, due in Italia che operano rispettivamente nei settori delle ricerche di mercato e dell’ospitalità turistica.