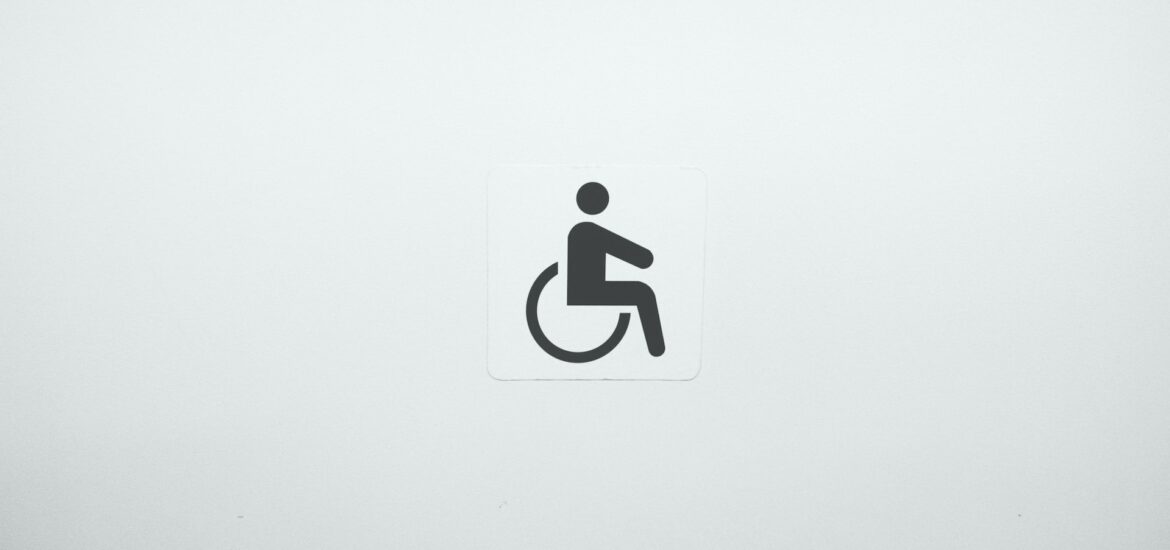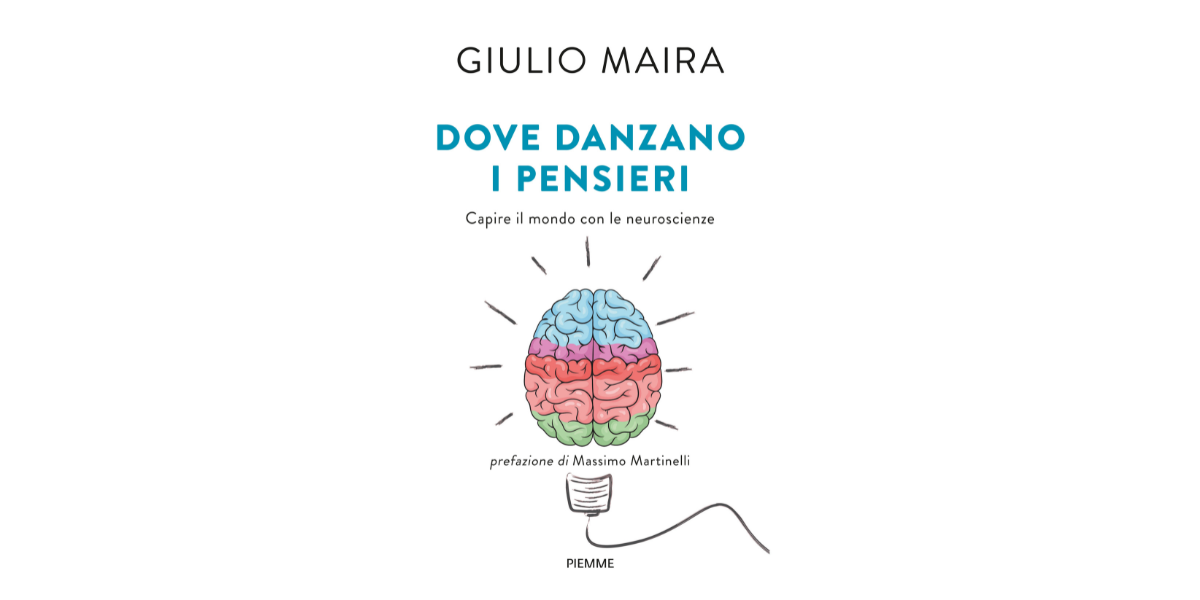Occorre partire dal numero 94 per comprendere la portata della ricognizione sulle pensioni di invalidità e di inabilità che Daniele Cirioli compie su Italia Oggi Sette del 4 agosto e per capire perché queste continuino a essere un cantiere aperto più nelle aule giudiziarie che in quelle parlamentari.
I due istituti mantengono i capisaldi fissati dalla legge 222/1984 — cinque anni di contributi, di cui almeno tre nel quinquennio che precede la domanda, e la verifica medico-legale dell’assoluta o della permanente riduzione della capacità lavorativa — ma la misura dell’assegno resta appesa alle decisioni della Corte costituzionale.
Così l’integrazione al trattamento minimo, per gli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo a seguito sentenza n. 94/2025, è partita solo dallo scorso 10 luglio 2025, segnando un punto a favore della formula «dalla data di pubblicazione», scelta per contenere gli oneri retroattivi ma destinata, come molte altre pronunce analoghe, a lasciare senza ristoro chi ha maturato il diritto in precedenza.
Che cosa significhi oggi questa tempistica, è quali siano gli scenari futuri per la sostenibilità del sistema ce lo dicono i numeri dell’INPS.
Nel 2024 le nuove pensioni di invalidità sono salite a 73.042 — un balzo dell’11,8 per cento rispetto alle 65.360 del 2023 — e il totale delle nuove prestazioni di ogni genere ha superato quota 1.569.000. L’importo medio mensile degli assegni di invalidità vigenti è passato da 1.090 a 1.151 euro in dodici mesi, ma restano vistose le differenze territoriali e di genere, con valori spesso ben al di sotto dei mille euro nel Mezzogiorno.
Intanto la dinamica demografica rende più precario l’equilibrio finanziario del sistema: al 1° gennaio 2023 il tasso di dipendenza, cioè il rapporto fra popolazione in età non attiva e popolazione in età lavorativa, si è attestato al 57,4 per cento; secondo le proiezioni OCSE, nell’arco di una generazione avremo quasi un anziano ogni 1,3 occupati.
Di fronte a questi dati il legislatore ha lasciato spesso alla Consulta il compito di correggere storture evidenti. La Sentenza n. 70/2015 ad esempio ha riattivato la perequazione dopo il blocco imposto nel 2012-2013.
Ma è sulla disabilità il nervo scoperto di un sistema che sembra essere entrato in crisi, con sentenze della Consulta che giungono anche dopo decenni. La sentenza n. 152/2020, ad esempio, che ha raddoppiato l’assegno di inabilità civile portandolo a 516 euro, arriva 19 anni dopo legge 448/2001, la recente sentenza n. 94/2025, dopo ben 30 anni visto che riguarda la Riforma delle pensioni del 1995 e, solo oggi, ha riconosciuto l’integrazione al minimo agli assegni contributivi.
In tutti e tre i casi la Corte ha dichiarato l’illegittimità delle norme, ma ne ha fatto valere gli effetti solo per il futuro.
È il sintomo di un doppio fallimento: il Parlamento sembra non previene le violazioni costituzionali e la giustizia costituzionale, che è costretta a intervenire, limita retroattività e ristori pur di non mettere a rischio i saldi di finanza pubblica.
Non che in questi anni siano mancate riforme in materia di disabilità: il decreto legislativo 62/2024, sebbene non pienamente operativo e ancora in via sperimentale, ha unificato nell’INPS l’accertamento medico-legale sulla base del modello bio-psico-sociale e la “riforma anziani” tenta di integrare sostegni economici e servizi socio-sanitari. Ma nessun correttivo strutturale sin qui proposto ha toccato criteri di adeguatezza e indicizzazione degli importi delle pensioni delle persone con disabilità, cioè la materia viva anche della recente sentenza della Corte costituzionale n. 94. Il risultato è un ciclo che si ripete: la legge emanata crea il problema, il cittadino è costretto a ricorrere al Giudice con un percorso ad ostacoli, la Consulta interviene anche dopo decenni, concede aumenti ex nunc, il legislatore prende atto ma rinvia la soluzione organica, con inevitabili ricadute di nuovo contenzioso e di progressivo e inarrestabile aumento della sfiducia nelle istituzioni.
Ed allora cosa fare? La soluzione in realtà è scritta proprio nei regolamenti parlamentari ed è uno dei rimedi più immediati e meno costosi ai quali prestare attenzione: le questioni pregiudiziali e sospensive disciplinate rispettivamente dagli articoli 93 del Regolamento del Senato e 40 del Regolamento della Camera dei Deputati.
In particolare sono proprio le questioni pregiudiziali che possono riguardare profili di legittimità costituzionale del testo sottoposto all’esame dell’assemblea che, se approvate prima dell’avvio della discussione, ne sospendono o annullano l’esame sino a che non sia adottata una soluzione correttiva.
Questa procedura non è un esercizio di tattica politica, ma è la sede in cui deputati e senatori possono vagliare i testi loro sottoposti alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza consolidata. Se questo filtro avesse funzionato con la riforma del 1995, l’esclusione degli assegni contributivi dall’integrazione al minimo sarebbe stata corretta in anticipo e la sentenza 94/2025 non avrebbe visto la luce ma, soprattutto, non si sarebbero limitati gli effetti con quel «da ora in poi» che mortifica il cittadino.
Restituire autorevolezza e valore alle pregiudiziali non basterà certo a risolvere la sfida demografica e garantire sostenibilità al sistema previdenziale nel suo complesso, ma eviterebbe il ripetersi di quel ciclo descritto precedentemente, tutt’altro che virtuoso, segnando così un passo importante per riportare il Parlamento al centro della tutela dei diritti sociali, prima che l’ennesimo intervento della Consulta decreti di nuovo — per tutti — che la correzione, attesa magari da decenni, parte solo dal giorno dopo.