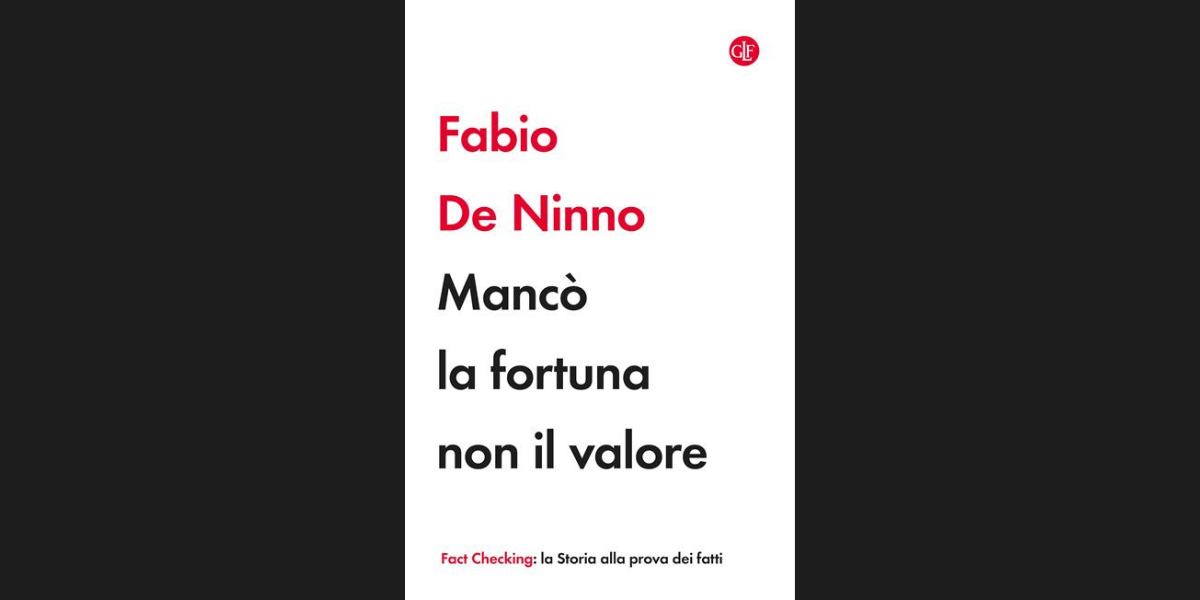Nel corso dei secoli, il cibo spazzatura ha raccontato le nostre disuguaglianze, le nostre priorità economiche o i nostri desideri contraddittori. Se l’obiettivo principale delle prime civiltà urbane era soprattutto la sopravvivenza, a partire dal Neolitico (tra il 5800 e il 2500 a.C. circa) si affacciano due tipi distinti di alimentazione: quella di prestigio e quella di sussistenza. Questo embrione di gerarchia culinaria si sviluppa nell’antichità, portando a regimi alimentari differenziati tra élite e classi lavoratrici – scrive Le Monde.
L’ALIMENTAZIONE NELL’ANTICHITÀ
Contrariamente all’immagine idealizzata dei banchetti greco-romani, la maggior parte degli abitanti di quell’epoca mangiava poco, in modo ripetitivo e codificato. La dieta quotidiana del popolo era quasi vegetariana: pane, fagioli, lenticchie, olio d’oliva. La carne, segno di potere e virilità, veniva consumata durante le grandi cerimonie in cui gli animali offerti agli dei venivano divisi tra i fedeli. I tagli nobili andavano alle élite, mentre i poveri ricevevano le frattaglie o le parti grasse, meno pregiate.
LA DIETA COME DISCIPLINA FILOSOFICA
Mangiare carne è una pratica sospetta per i filosofi, che criticano gli eccessi alimentari e i gusti corrotti. Platone, nella Repubblica, critica aspramente le diete carnivore che incitano all’eccesso e alla violenza. Per i medici ippocratici come per i filosofi stoici, mangiare bene significa soprattutto controllarsi. «Il saggio mangia per vivere, e non il contrario», sintetizzava già Socrate. La diaita (dieta) degli antichi greci, pratica sia filosofica che medica, è molto lontana dal nostro rapporto contemporaneo con il cibo. Piuttosto che soddisfare i propri piaceri, si tratta di rispettare un equilibrio naturale e sociale, dettato dalla classe sociale, dal sesso o dalla costituzione fisica.
I “FAST FOOD” DELL’ANTICA ROMA
A Roma, la popolazione povera, priva di cucine, mangia spesso fuori casa. Le thermopolia, una sorta di fast food dell’antichità, vendono piatti semplici ed economici: stufati, frittelle, pesciolini. Per esaltare il sapore degli ingredienti di scarsa qualità, si usavano abbondantemente salse forti, come il garum, una salsa a base di visceri di pesce fermentati al sole, a volte per diversi mesi. Questo condimento, prodotto industrialmente in Hispania e in Nord Africa ed esportato in tutto l’Impero, era onnipresente, anche se disprezzato. Alcuni autori, come Seneca o Plinio il Vecchio, lo deridono o diffidano di esso, ritenendo che alteri il gusto naturale e stimoli l’appetito in modo irragionevole. […]
Il cibo spazzatura è già presente, ai margini della storia ufficiale, come una necessità vergognosa. Questa pratica del cibo veloce, economico e venduto per strada è criticata dai moralisti, che la associano alla pigrizia, alla gola o alla decadenza dei costumi urbani. Anche in questo caso, la rapidità e la facilità del pasto diventano segni di classe e di indegnità.
IL MEDIOEVO E L’ALIMENTAZIONE DI SUSSISTENZA
Per la maggior parte della popolazione rurale del Medioevo, pane nero, zuppa chiara e birra a bassa gradazione alcolica costituivano la base di un’alimentazione di sussistenza insipida e monotona. Le frittelle vendute nelle città costituivano una forma di ristorazione veloce, anch’essa considerata sospetta dalle autorità sanitarie e morali.
RINASCIMENTO: LA CUCINA COME DISTINZIONE SOCIALE
Questa opposizione tra cucina raffinata e cibo popolare si accentua nel Rinascimento. In un contesto di crescente gerarchizzazione sociale dei gusti e delle pratiche alimentari, le élite ridefiniscono l’arte della tavola come un segno di distinzione, codificando le buone maniere, complicando le ricette e moltiplicando i banchetti fastosi.
I TRATTATI DI CUCINA E L’EREDITÀ DI CLASSE
È anche l’epoca in cui vengono pubblicati i primi trattati di cucina raffinata, come quelli di Bartolomeo Scappi (1500-1577), cuoco dei papi, che descrivono minuziosamente i banchetti serviti a corte. Questa dissociazione culinaria riflette una divisione sociale del gusto, che il filosofo Pierre Bourdieu (1930-2002) analizzerà diversi secoli dopo, ma che qui affonda le sue radici nelle disuguaglianze materiali e simboliche del Rinascimento. La frattura tra “mangiare per vivere” e “mangiare per apparire” si instaura in modo duraturo.
IL CIBO COME EQUILIBRIO INTERNO
Nel XVII secolo, mentre il corpo veniva moralizzato attraverso l’alimentazione, Franciscus de le Boë, medico meglio conosciuto con il nome di Sylvius, suggeriva che ciò che mangiamo può disturbare l’equilibrio interno del corpo. […]
L’ERA INDUSTRIALE E LA DIETA DELL’OPERAIO
Due secoli dopo, con la rivoluzione industriale, questa preoccupazione assume proporzioni diverse. La trasformazione dell’alimentazione accelera: la meccanizzazione, l’arrivo delle conserve, degli additivi e delle prime catene logistiche modificano profondamente il rapporto con il cibo. Si mangia meno regolarmente a casa, più velocemente, spesso in fretta, tra un turno di lavoro e l’altro. Per la prima volta, gli operai hanno accesso a piatti economici, ricchi di calorie ma poveri di nutrienti.
L’INVENZIONE DEL FAST FOOD MODERNO
È in questo contesto che nasce, negli Stati Uniti, un nuovo modello. White Castle, fondata nel 1921, è la prima catena a proporre un hamburger standardizzato, veloce da servire e da consumare, pensato per rassicurare con la sua uniformità. Il successo è immediato e apre la strada ai giganti del fast food come McDonald’s, Burger King o Kentucky Fried Chicken. Il fast food industriale è ormai una realtà.
È nell’America degli anni ’70 che la critica prende una svolta decisiva. Mentre i supermercati traboccano di prodotti trasformati, colorati, zuccherati e grassi, Michael Jacobson, un giovane nutrizionista, lancia un’espressione destinata a segnare l’epoca: “junk food”. Con questo termine indica alimenti privi di valore nutrizionale, ma ricchi di sale, grassi o zuccheri. […]
GLOBALIZZAZIONE DEL CIBO SPAZZATURA
A partire dagli anni ’80, il modello americano ha ampiamente superato i confini nazionali. Esportato con grande successo grazie al marketing, il junk food si è infiltrato nelle abitudini alimentari di tutto il mondo. La Francia, da sempre legata al suo patrimonio culinario e alla ritualizzazione dei pasti, finisce per cedere. Si mangia in piedi, per strada o nei corridoi delle stazioni. Il kebab e l’hamburger diventano simboli di modernità a basso costo. Questa nuova cultura alimentare racconta anche l’urbanizzazione, la precarietà di vite frenetiche, il multiculturalismo dei centri urbani.
LO STREET FOOD OGGI
Nel 2023, più di un francese su due dichiarava di mangiare street food almeno una volta alla settimana. Il cibo spazzatura, ricco di zuccheri, sale e grassi, si impone dove mancano tempo, denaro o accesso a prodotti freschi. Dietro ogni cono di patatine fritte o ogni vaschetta che esce dal microonde, c’è tutto un sistema economico, sociale e culturale che si esprime. […]
TRA DENUNCIA E RIVALUTAZIONE
Ma mentre se ne denunciano gli effetti, il junk food viene anche riabilitato. Chef stellati rivisitano l’hot dog. I food truck propongono hamburger biologici a 15 euro. Il cibo spazzatura non è più solo qualcosa che si subisce, ma diventa anche un oggetto estetico, nostalgico, persino politico. Piuttosto che un’anomalia moderna, è una costante della storia, che cambia forma a seconda delle epoche e ridefinisce le tecniche e i rapporti di forza. Se oggi rappresenta una sfida importante per la salute pubblica, mette anche in discussione le nostre rappresentazioni del gusto, del corpo e del legame sociale.
In un’epoca in cui le grandi città sono piene di fast food che vendono hamburger, tacos e bubble tea, il cibo spazzatura non può più essere considerato una semplice degenerazione culinaria, ma un linguaggio culturale da decifrare.
(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)