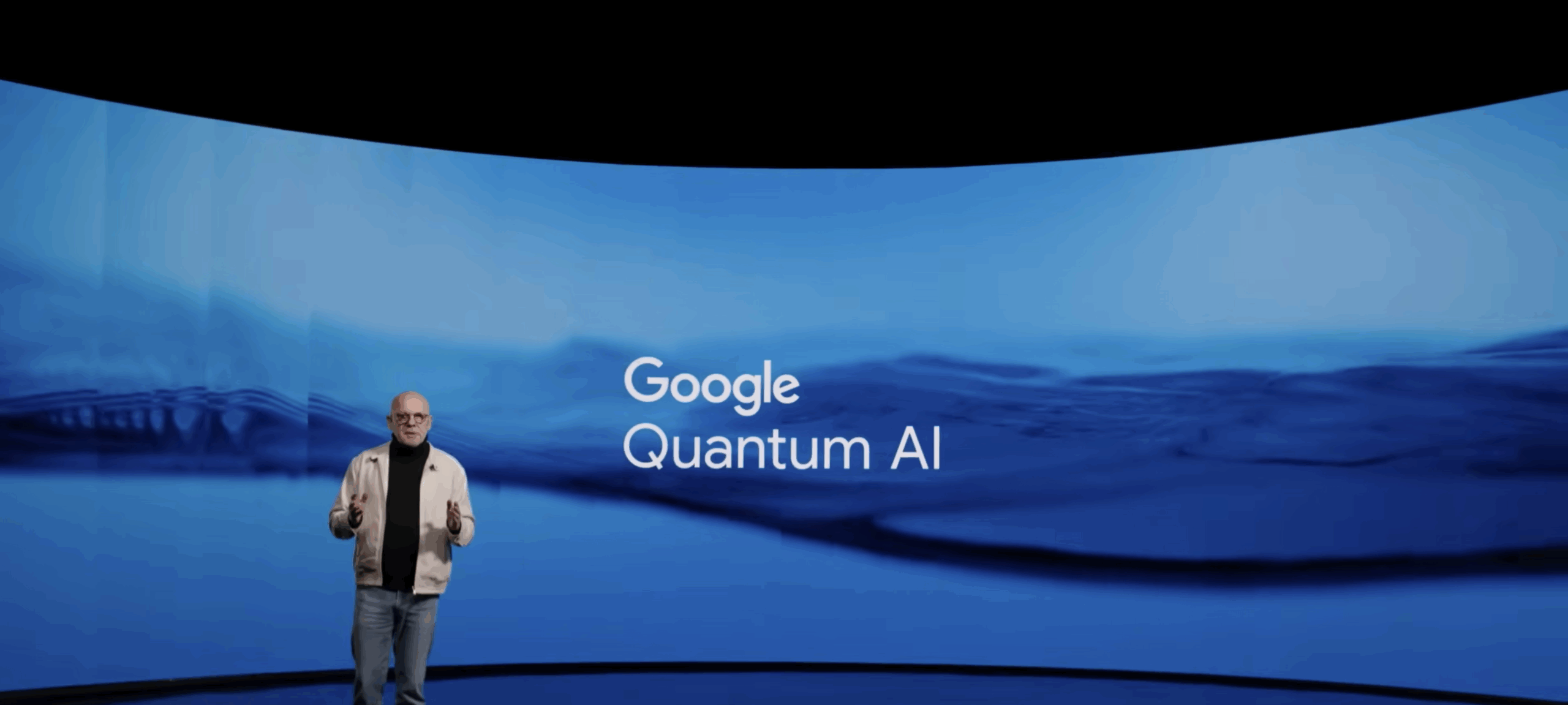Un nuovo studio rilancia l’allarme sulla fuga delle imprese che operano in Germania, segnalando che la delocalizzazione della produzione e degli investimenti si sta accentuando. Dopo un primo allarme lanciato dalla Camera di commercio e dell’industria tedesca, una nuova indagine, questa volta condotta dalla società di consulenza Simon-Kucher e anticipata da Handelsblatt, mostra come sempre più aziende ad alto consumo energetico stiano spostando i propri investimenti all’estero, attratte da condizioni economiche più favorevoli e costi energetici più bassi.
Secondo il sondaggio, che ha coinvolto 240 dirigenti di imprese europee e statunitensi, il 31% delle aziende che operano in Germania sta già trasferendo parte della produzione fuori dai confini nazionali o sta ampliando la propria presenza in altri continenti, mentre un ulteriore 42% preferisce investire in altri Paesi europei o rinviare le decisioni di spesa sul territorio tedesco. Il fenomeno, osservano gli autori, coinvolge in particolare i settori della chimica di base, dell’acciaio, del vetro e del cemento.
COSTI ELEVATI E FIDUCIA IN CALO NELL’IDROGENO
Tra le cause principali della fuga industriale figurano i costi energetici e la perdita di fiducia nella transizione verso l’idrogeno come fonte alternativa. La riconversione degli impianti, sostenuta da miliardi di euro tra fondi pubblici e privati, appare oggi troppo onerosa. Il prezzo dell’idrogeno rimane elevato e le prospettive di una riduzione nel medio periodo sono scarse. Un caso emblematico, ricorda il quotidiano di Düsseldorf, è quello di Arcelor-Mittal, che ha sospeso la costruzione di impianti a impatto climatico zero a Brema ed Eisenhüttenstadt, optando invece per la Francia, dove l’energia costa meno.
Le aziende temono inoltre che l’aumento del prezzo dei certificati di emissione di CO2, oggi parzialmente compensato da sussidi europei, possa aggravare ulteriormente la situazione. Il presidente di Evonik, Christian Kullmann, ha definito la tassa sul carbonio “un ostacolo alla competitività”, mentre molte imprese ritengono che la sua abolizione sia politicamente irrealistica, data la rigidità degli obiettivi climatici europei.
INCERTEZZA POLITICA E PESO DELLA BUROCRAZIA
Il cambio di governo a Berlino non ha finora restituito fiducia al mondo produttivo. Un sondaggio dell’Associazione federale delle piccole e medie imprese mostra che l’80% delle aziende non prevede miglioramenti concreti dalle riforme promesse. Anche gli incentivi statali, come il contributo da 6,5 miliardi di euro per alleggerire i costi della rete elettrica, appaiono insufficienti. Per l’impianto chimico di Leuna, nell’est del paese, il beneficio coprirebbe ad esempio appena il 2-3% delle spese energetiche.
Oltre ai costi elevati, le imprese lamentano la carenza di personale qualificato e un eccesso di burocrazia. “Gli investimenti in Germania comportano rischi e costi elevati”, ha dichiarato all’Handelsblatt Christiane Nelles, direttrice dell’Associazione dell’industria del vetro. Anche secondo rappresentanti del settore chimico, la Germania resta un paese complesso per chi vuole produrre e innovare, nonostante le promesse di semplificazione amministrativa e sostegno alle imprese.
COMMERCIO MONDIALE E NUOVI EQUILIBRI
L’industria tedesca deve inoltre confrontarsi con il mutato quadro dei dazi internazionali, proseguono gli autori dello studio. Le politiche commerciali introdotte dal presidente americano Donald Trump hanno alterato i flussi globali di merci: la Cina, penalizzata dalle tariffe statunitensi, ha aumentato le esportazioni verso l’Europa, mentre gli Stati Uniti beneficiano ora di condizioni più favorevoli per i loro prodotti chimici sul mercato europeo.
Il settore siderurgico tedesco parla di “importazioni sleali” da paesi extra Ue, mentre aziende come Schott, specializzata nella produzione di vetro, hanno rivisto la propria strategia adottando un modello “local for local”, basato su produzioni decentrate e vicine ai mercati di consumo, per ridurre i rischi legati alle tensioni commerciali e geopolitiche.
DOMANDA IN CALO E RALLENTAMENTO ECONOMICO
La debolezza dell’economia tedesca accentua le difficoltà. La Bundesbank prevede una stagnazione del Pil nel terzo trimestre, e l’industria risente pesantemente della contrazione della domanda interna ed estera. Gli impianti chimici operano in media al 71% della capacità, mentre per garantire la redditività sarebbe necessario un utilizzo superiore all’80%.
Secondo Simon-Kucher, la produzione dei settori ad alta intensità energetica “è oggi inferiore del 15% rispetto ai livelli pre-crisi del 2019,” con cali particolarmente marcati nella chimica, nel vetro, nella ceramica e nella carta. Anche il valore aggiunto industriale complessivo è diminuito del 3,6% rispetto al periodo pre-pandemico, “segno di una perdita strutturale di capacità produttiva”.
A pesare, oltre alla congiuntura, è la concorrenza globale. La crescita industriale si sposta verso l’Asia, dove le grandi imprese vedono nuove opportunità. La multinazionale tedesca BASF, ad esempio, sta costruendo un vasto impianto integrato a Zhanjiang, in Cina, puntando sul fatto che entro il 2030 la regione Asia-Pacifico rappresenterà il 70% del mercato chimico mondiale.
UN DECLINO IRREVERSIBILE?
Nonostante il quadro preoccupante, alcuni analisti ritengono che il declino non sia irreversibile. Handelsblatt conclude la sua analisi pescando le parole del presidente di Deutsche Bank Christian Sewing, intervenuto al Frankfurt Finance & Future Summit del Weimer Media Group. Sewing ha affermato che la consapevolezza politica della crisi industriale sta crescendo e che un’azione più decisa del governo potrebbe trattenere una parte degli investimenti. “Quando arriveranno i cambiamenti strutturali necessari – ha dichiarato – alcuni degli investimenti che oggi sembrano destinati all’estero potranno restare nel paese”.
Resta tuttavia il dato principale dello studio: sette aziende su dieci guardano ormai oltre i confini tedeschi per salvaguardare la propria competitività, segno che la Germania, culla storica dell’industria europea, rischia di perdere il suo ruolo di polo produttivo e quello di locomotiva economica.