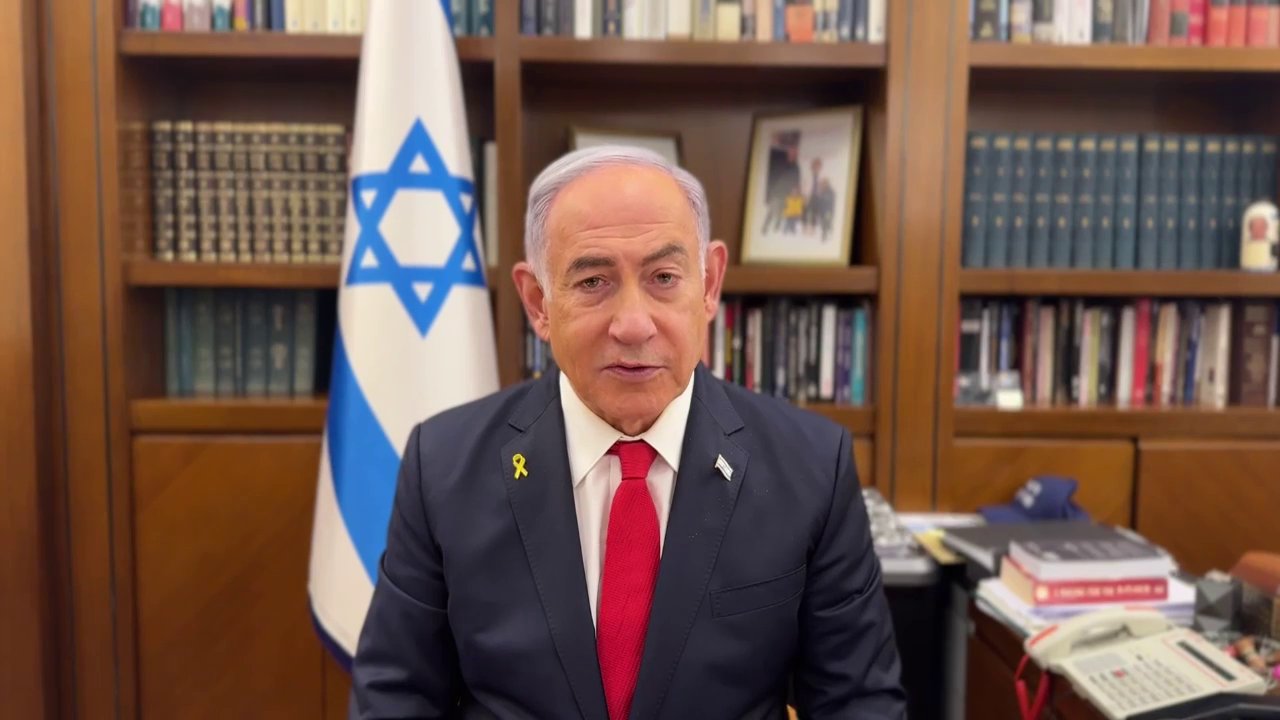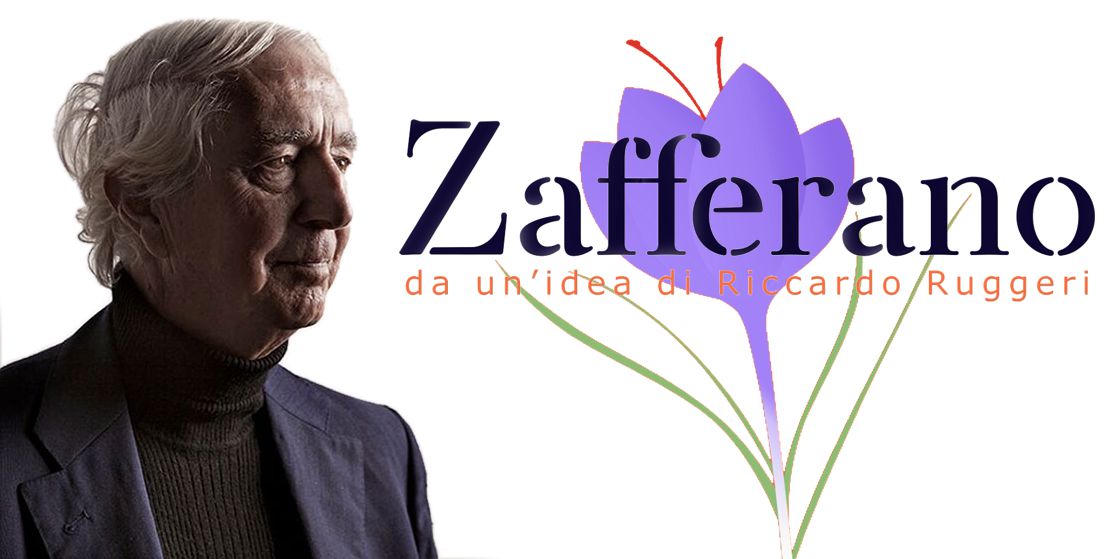C’è un guazzabuglio digitale dove concetti tecnici e finanziari e sogni di ricchezza democratica si fondono generando una miscela infida: è il mondo delle “monete digitali”. La miscela è considerata, anche nelle tassonomie ufficiali, parte di un melting pot più ampio denominato fintech.
La confusione concettuale ha generato entusiasmi ingiustificati e, parimenti, anacronistici ostracismi.
C’è, infatti, chi le vede come il nuovo oro, chi come un cavallo di Troia della finanza speculativa, chi infine come la futura infrastruttura della moneta globale. Sta di fatto che il mondo delle valute digitali – dalle criptovalute alle stablecoin, fino alle monete digitali delle banche centrali – è oggi un terreno in rapida evoluzione, stratificato e confuso per i non addetti ai lavori e foriero di controindicazioni che sono anche politiche.
Comprendere le differenze tra le varie forme di “denaro digitale” non è soltanto un esercizio accademico: significa leggere in controluce le linee di faglia dell’economia e della finanza del futuro.
Proviamo dunque a proporre una mappa che ordini le alternative, mettendo in luce le promesse, i limiti e i rischi strutturali di ogni ramo di questo mondo estremamente fluido.
A che serve la moneta
Prima di addentrarci nella tassonomia, è però necessario richiamare alcuni concetti economici di base.
In primo luogo, quello di bene economico, scarso e costoso necessitando di lavoro, capitale, tecnologia, organizzazione per essere prodotto o distribuito, da contrapporsi a quello di bene illimitato e disponibile senza sforzo.
In secondo luogo, quello di moneta che assolve a tre funzioni classiche: mezzo di scambio, atto a superare i limiti del baratto; unità di conto, quale metro comune per misurare e confrontare i valori, e riserva di valore, cioè strumento capace di trasferire potere d’acquisto nel tempo.
Tali funzioni si perfezionano se la moneta esprime un valore “certo”, da intendersi come costanza del potere di acquisto ad essa associato, attribuibile al supporto (ad esempio un metallo prezioso) come nel caso della moneta-merce o garantito da altri beni che ne costituiscono il fondamento (ad esempio gli attivi della banca centrale che emette la moneta legale) come nel caso della moneta-segno.
Infine, la moneta segno si distingue a sua volta in moneta legale, come l’euro, la cui circolazione è su base legale e moneta bancaria, la cui diffusione è su base fiduciaria come nel caso degli assegni bancari.
La storia delle criptovalute ha origine nel 2008, con la pubblicazione del white paper di Satoshi Nakamoto e il lancio nel 2009 di Bitcoin.
L’idea era radicale: creare una moneta priva di banca centrale, basata su un registro distribuito e immutabile (la blockchain) e protetta da meccanismi crittografici.
A Bitcoin hanno fatto seguito centinaia di cloni e varianti. Tra di essi Ethereum (2015) ha aggiunto la possibilità di programmare smart contract, aprendo la strada alla finanza decentralizzata (DeFi).
L’obiettivo di liberarsi del ruolo di garante svolto dagli intermediari emittenti “moneta segno” o anche più spesso definita “moneta fiduciaria” valorizzando un nuovo paradigma di “denaro nativo digitale”, si è trasformato in illusione per l’estrema volatilità del suo valore, che non ne consente l’utilizzo come riserva di valore, pena sopportare un grande rischio, e per l’opacità della governance, rimessa sostanzialmente a community ristrette di piattaforme “exchange”, sviluppatori e miner.
Il miner è il “notaio digitale” delle criptovalute: garantisce che ogni transazione sia valida, aggiunge i blocchi alla catena e viene ricompensato con il conio di nuova moneta secondo una predeterminata curva di probabilità discendente. Il suo ruolo, originariamente acclamato come simbolo di libertà e decentralizzazione, è oggi sotto accusa per i consumi energetici e per la crescente concentrazione del potere di calcolo.
La capacità di utilizzare i wallet elettronici, necessari per la custodia delle criptovalute, può costituire barriera all’ingresso per i potenziali utilizzatori e l’anonimato che caratterizza queste transazioni ha originato limitazioni regolamentari al loro impiego diffuso, diminuendo le funzioni di mezzo di scambio e di unità di conto.
La conseguenza è che le criptovalute, del tipo Bitcoin, hanno assunto la caratteristica di bene economico ma non quella di moneta in senso proprio e si sono trasformate in beni speculativi su cui investire seguendo gli erratici percorsi della domanda e dell’offerta.
Quanto stabili?
Il tentativo di superare il problema dell’instabilità del valore ha dato origine alle stablecoin, termine traducibile appunto come “moneta stabile”. Si tratta di token – gettoni – digitali ancorati a monete legali come il dollaro. La stablecoin più “antica” (2014) e ancora oggi la più scambiata al mondo è Tether ancorata al dollaro statunitense ed emessa da Tether Ltd.
L’emissione, analoga a quella della moneta fiduciaria, è collegata ad un patrimonio di attivi che ne garantiscono il valore, con un particolare critico: se le banconote emesse dalla banca centrale figurano al passivo del suo bilancio ed il controvalore delle riserve a supporto è all’attivo del medesimo bilancio secondo criteri di valutazione rigidamente definiti e controllati, non può dirsi lo stesso per le stablecoin i cui emittenti sono giudicati opachi nella valorizzazione degli attivi corrispondenti.
Come per altri ambiti, la fantasia degli operatori si è, poi, sbizzarrita e ha prodotto stablecoin ancorate a criptovalute, come Dai ancorata ad Ethereum, ovvero stablecoin algoritmiche, come Terra USD (UST), sostenuta dal token gemello Luna, il cui meccanismo aveva l’obiettivo – del tutto mancato – di mantenere per ogni unità sempre il valore di 1 dollaro.
Anche per le stablecoin la promessa di uno strumento dal valore stabile, utile nei pagamenti e nei protocolli di finanza decentralizzata si rivela ingannevole: stante la scarsa trasparenza delle riserve, non vi è modo di stabilire se esse siano in grado di sostenere una richiesta di conversione immediata e simultanea in moneta legale, replicando il problema della corsa agli sportelli bancari risolvibile, come ci insegna la Disney nel famosissimo film Mary Poppins, solo con la sospensione dei pagamenti.
Il paradosso è evidente: quanto più le stablecoin cercano di essere “moneta” affidabile, tanto più rischiano di replicare i problemi e le fragilità del sistema bancario tradizionale.
Il ruolo delle banche centrali
All’estremo opposto dello spettro si trovano le monete digitali emesse dalle banche centrali. Qui non c’è anarchia, né decentralizzazione: il progetto è istituzionale, essendo versioni elettroniche della moneta legale, emesse direttamente dalla banca centrale.
La Cina è già molto avanti con lo yuan digitale (e-CNY). La Banca Centrale Europea sta portando avanti il progetto dell’euro digitale, mentre l’amministrazione Trump ha bloccato il progetto avviato dalla Federal Reserve nel 2022.
L’obiettivo sottostante è quello di modernizzare i sistemi di pagamento, rafforzare il controllo delle banche centrali sulla circolazione monetaria e potenzialmente ridurre i costi di transazione.
Anche questa via è però irta di difficoltà per la tracciabilità delle transazioni, con riflessi sulla privacy e sulle libertà individuali, per la maggiore facilità da parte delle istituzioni centrali di bloccare i conti o limitare l’utilizzo del contante e, elemento di preoccupazione maggiore, per il potenziale di disintermediazione delle banche commerciali a favore della banca centrale, il cui ruolo finirebbe per modificarsi.
Questi strumenti, la cui portata innovativa è relativa se si considerano gli attuali strumenti di pagamento a mezzo telefonia mobile, rischiano, invece, di essere terribilmente invasivi e ben lontani dal liberismo economico di Adam Smith e dei suoi epigoni.
Gli altri token e coin
Accanto alle monete digitali vere e proprie, si è sviluppata una galassia di token ibridi, utilizzati per scopi specifici come utility token, adoperabili per pagare commissioni o accedere a servizi di piattaforma, governance token, conferenti diritto di voto nelle decisioni di sviluppo di un protocollo e Non Fungible Token (NFT), rappresentativi di quote, diritti o beni digitalizzati.
Le criticità sono qui rinvenibili nella eccessiva dipendenza dal progetto cui sono agganciati e la difficoltà di distinguere tra un titolo regolamentato e un gettone digitale.
Infine, un cenno meritano le monete emesse da banche o big-tech, come ad esempio JPM Coin, stablecoin ancorata al dollaro, di JP Morgan Chase, lanciata a febbraio 2019 come servizio interbancario.
Se per le banche, queste monete possono essere considerata una versione digitale della più tradizionale moneta bancaria, non altrettanto può dirsi per quanto eventualmente originato da colossi come Amazon o Google, che, privi di controlli ad hoc, potrebbero entrare in conflitto con la sovranità monetaria degli Stati.
Tutte le fragilità
In sintesi, ogni eroe ha il suo punto debole. Superman aveva la kryptonite. Anche le criptovalute e i loro parenti stretti hanno la loro “cryptonite”: un insieme di fragilità strutturali che ne minano la promessa originaria di libertà, sicurezza e stabilità.
Il primo e più evidente tallone d’Achille è la volatilità. Bitcoin, il capostipite delle monete digitali, si è trasformato in un asset speculativo, più vicino a un titolo tecnologico ad alto rischio che a una valuta stabile. Per aggirare il problema sono nate le stablecoin, la cui “cryptonite” prende la forma dell’opacità.
Un’altra debolezza sta nell’impatto ambientale del mining. Il processo di validazione delle transazioni richiede enormi quantità di energia elettrica. Questo rende la criptomoneta contendibile: in un’epoca di transizione ecologica, una tecnologia tanto energivora rischia di diventare insostenibile.
Il mondo “crypto” è nato sotto il segno della sicurezza crittografica, ma nella pratica ha spesso mostrato crepe. La cronaca è costellata di scandali. La decentralizzazione promessa si è tradotta spesso in un’assenza di controlli e garanzie, lasciando milioni di utenti senza protezione.
Forse la più potente delle “cryptonite” è l’incertezza normativa.
Negli Stati Uniti le autorità faticano ancora a decidere se trattare i token come titoli finanziari o come beni, pur valorizzando le stablecoin agganciate al dollaro. In Europa il regolamento MiCA è un passo avanti, ma resta molto da chiarire su tassazione, trasparenza e tutela dei risparmiatori. L’assenza di regole chiare alimenta l’attrattiva per chi cerca zone grigie, ma scoraggia la fiducia dei grandi investitori e dei cittadini comuni.
La più grande contraddizione del mondo “crypto” è proprio questa: nata per emanciparsi dal bisogno di fiducia in banche e governi, finisce per dipendere dalla fiducia nella tecnologia e nei suoi operatori. Una fiducia fragile, perché non sostenuta da istituzioni pubbliche né da regole condivise.
È qui che la “cryptonite” mostra tutta la sua forza corrosiva: senza fiducia, nessuna moneta può sopravvivere a lungo.
Non a caso la parola credito origina dal latino credere che significa “credere, affidarsi, avere fiducia” e la parola moneta dal latino monere che significa “ammonire, avvertire”. Siamo dunque chiamati a riflettere sui soggetti a cui “affidarci” e sugli “ammonimenti” che da questa fiducia derivano, senza cedere a facili conclusioni sul futuro, luminoso o nefasto che sia, dell’economia digitale, che, al momento, più che esprimere innovazioni di prodotto sembra dar luogo innovazioni di processo.
Le mosse di Trump
In questa prospettiva, il recente intervento legislativo del senato statunitense di luglio 2025 (Genius Act) nel consolidare il ruolo primario delle stablecoin, consentendone l’emissione agli intermediari vigilati del sistema statunitense, ripropone in veste moderna l’epocale passaggio al deposito irregolare che ha dato luogo alla banca attuale con una “trascurabile” variante: agganciate le stablecoin al dollaro, è agevole ipotizzarne la sua supremazia con tutte le conseguenze del caso e la debacle di altre valute (tra cui l’euro) “forti”, negoziate a livello globale e considerate bene rifugio affidabile e stabile.
Il giubilo con cui la Casa Bianca ha accolto il passaggio al Senato, per una volta, non pare del tutto fuori luogo, mentre l’Europa resta a guardare.
In definitiva, qualunque sia l’evoluzione del panorama digitale, la moneta per come l’abbiamo conosciuta e apprezzata nel corso della storia non può essere abbandonata né relegata a un ruolo secondario.
Essa deve rimanere un diritto irrinunciabile dei cittadini, presidio di libertà economica e di inclusione sociale, anche a fronte delle innovazioni introdotte dalle monete elettroniche. Il contante non è solo un mezzo di pagamento: rappresenta una rete di protezione contro i rischi tecnologici, una barriera alle possibili derive di sorveglianza e una garanzia di riservatezza delle transazioni.
Rinunciarvi significherebbe esporre la società a nuove vulnerabilità, affidando la gestione della fiducia a infrastrutture fragili o concentrate nelle mani di pochi grandi attori, pubblici o privati.
Il buon senso impone dunque di accompagnare l’innovazione con la salvaguardia di strumenti essenziali di autonomia, affinché la tecnologia non diventi una gabbia dorata ma resti un supporto al servizio della comunità.
In questa prospettiva, appare chiaro che il futuro non sarà segnato da una sostituzione radicale, bensì da una coesistenza regolata e complementare tra moneta tradizionale e soluzioni digitali. Solo così si potrà coniugare la spinta verso l’efficienza con la necessaria tutela dei diritti fondamentali, garantendo stabilità, equità e fiducia.
Si deve certamente affermare che la moneta, quale istituzione sociale oltre che strumento economico, non deve mai essere ridotta a semplice tecnologia di scambio: la sua forza storica risiede proprio nella capacità di incarnare fiducia collettiva, certezza giuridica e libertà individuale, elementi che costituiscono la base di ogni ordine economico e politico durevole.
(Estratto da Appunti di Stefano Feltri)