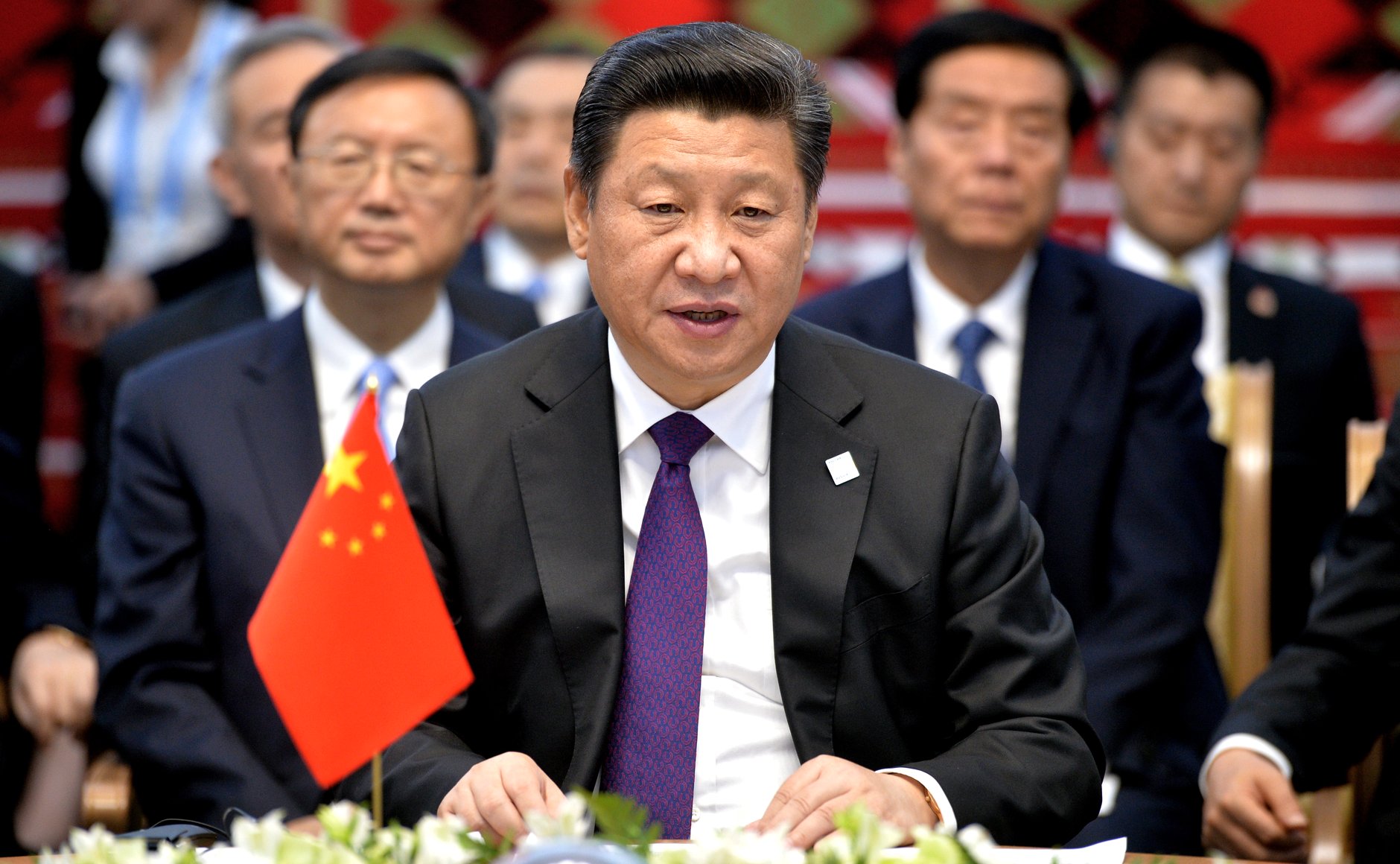“Terra dei fuochi”: lo hanno ribattezzato così il decreto – legge che dovrebbe cambiare il volto del nostro diritto penale dei rifiuti. Il titolo non è proprio originale: un altro decreto legge si fregiò di questo stesso titolo già dodici anni fa.
Cos’è questo decreto?
Nel 2013 erano “disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali”; oggi sono “disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti…”
Il testo normativo odierno dà l’idea che il suo analogo predecessore non abbia sortito esiti proprio risolutivi. Come, peraltro, capita con una certa frequenza ai decreti legge in ambito penale.
In ogni caso, l’efficacia di una legge va testata sul campo, ossia nella pratica giurisprudenziale. La legge “ecoreati” del 2015 (per fare un esempio vicino a questo decreto), che pure aveva ricevuto un’accoglienza diffusamente scettica, il test delle aule d’udienza, al momento, lo ha superato a pieno; specie quello delle aule della Cassazione, che è quello che più conta.
Fatte queste doverose precisazioni di metodo, da molte reazioni e commenti “social” (per quello che possono rappresentare statisticamente queste esternazioni) si ha l’impressione, però, che questa nuova normativa sia presa un po’ sottogamba da ampi settori proprio dei destinatari reali delle norme, a partire dagli imprenditori: “non cambierà niente; è la solita sceneggiata; si risolverà tutto con la prescrizione dei reati, come sempre…” e amenità simili.
Quindi, forse è il caso di fare un po’ di chiarezza, partendo dai dati, ossia dalle norme reali, come sempre; in particolare, dai reati introdotti e dalle relative sanzioni. Per provare a capire se è davvero una sceneggiata.
Il cuore della riforma: le imprese
Per anticipare la conclusione, questo decreto – legge ha tutto l’aspetto di una riforma che trasforma le regole del contrasto a quel variegato mondo di aggressioni all’ambiente e alla salute che hanno a base i rifiuti. Con un elemento di fondo: al centro di questo decreto ci sono le imprese – dal manifatturiero alla logistica al nevralgico trattamento rifiuti.
Nessuna invenzione del legislatore nazionale, neanche sotto questo specifico profilo: queste sono le indicazioni perentorie che arrivano sul punto dall’Unione Europea e dalla sua vasta e cruciale legislazione in materia ambientale degli ultimi anni, dalla direttiva CSRD a quella sulla due diligence a quella sulla tutela penale dell’ambiente, per citare solo alcuni atti dei più significativi.
Per le aziende, dunque, questa normativa comporta impatti di assoluto rilievo: in termini di nuovi obblighi e, quindi, di pesanti sanzioni, in caso di inadempimento di quegli obblighi.
Per tutte le aziende!
Per gli imprenditori ignorare queste novità non sarebbe, comunque, molto igienico: i rischi legali, economici e reputazionali sono diventati troppo elevati.
Proviamo a spiegarlo, analizzando cinque punti particolarmente significativi di questa riforma, tra gli altri, che ogni dirigente d’azienda dovrebbe conoscere.
Delitti al posto delle contravvenzioni – L’abbandono di rifiuti
La prima dirompente novità è la trasformazione in delitti – ossia il tipo di illecito penale più grave del nostro ordinamento – di quasi tutti i reati in materia di rifiuti previsti dal Testo Unico Ambientale, da contravvenzioni che erano.
Con conseguenze pratiche enormi, sia in ambito sostanziale che processuale; per citare solo due esempi: nel primo, i tempi di prescrizione di questi reati si allungano sensibilmente (minimo sei anni, che in presenza di atti interruttivi arrivano a sette anni e mezzo); in ambito processuale, date le pene massime sancite con la riforma, scatta la possibilità di disporre misure cautelari personali a carico degli indagati, a partire dalla custodia in carcere, per la quasi totalità di questi delitti.
A partire dall’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, ossia quando:
- dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna…
In questi casi, la pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Quando lo stesso comportamento, con le stesse conseguenze, viene tenuto da titolari di imprese e responsabili di enti, si sale da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
In più, quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi.
Giusto per iniziare a far capire, da subito, ai diretti interessati l’aria che tira con questo decreto!
Poi si passa ai rifiuti pericolosi. Qui l’abbandono costituisce delitto sempre, senza, cioè, necessità che esso provochi danni o pericoli per l’ambiente o la pubblica incolumità, ed è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Quando ricorre uno dei casi particolari visti sopra (pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria…), la sanzione penale sale: reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Questo quando a commettere i fatti sono privati cittadini; ossia coloro che, fino a ottobre 2023, erano esclusi a monte dal campo penale in questa materia: l’abbandono di rifiuti commesso da privati costituiva, infatti, mero illecito amministrativo, fino a ottobre 2023 per l’appunto, epoca della prima riforma in questo contesto. Per dare l’idea della quantità e qualità di cambiamenti normativi intervenuti in questo ambito in meno di due anni!
Poi ci sono le previsioni ad hoc per le imprese e chi le dirige.
Il mero abbandono di rifiuti pericolosi da parte di titolari di imprese e responsabili di enti comporta la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi particolari già visti, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
Per far capire a chi legge, in queste ultime ipotesi in materia di abbandono di rifiuti pericolosi (i “casi particolari”), che sono le più gravi, la pena minima per un imprenditore è di due anni. E quelle che contano davvero nella prassi giudiziaria sono le pene minime, non le massime.
Per esempio, due anni di minimo complicano già maledettamente l’ipotesi della sospensione condizionale della pena, il primo e più importante paracadute per un condannato nel nostro ordinamento, da che mondo è mondo.
Già da questa prima ricostruzione, pure relativa alle condotte illecite “più lievi” in ambito di rifiuti -ossia quelle di mero abbandono – emerge il livello di rischio penale reale per le imprese che deriva da questa riforma. Non pare eccessivo ricavarne che quel livello di rischio imponga, ormai, una complessiva gestione dei rifiuti – a partire dalla tracciabilità – limpida come l’acqua e granitica nella sua conformità a legge, specialmente per quelli classificati come pericolosi.
La gestione illecita: un terreno minato
Il decreto interviene pesantemente anche sul reato principe, per diffusione, in materia di rifiuti in ambito aziendale: la gestione non autorizzata, articolando e inasprendo le pene.
La gestione illecita di rifiuti non pericolosi diventa, anch’essa, delitto, tout court, ed è ora punita – nella sua ipotesi base e se realizzata da un privato cittadino – con la reclusione da sei mesi a tre anni; che sale da uno a cinque anni se i rifiuti sono pericolosi.
La pena s’impenna negli ormai noti “casi particolari”, già per i rifiuti non pericolosi: reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ….
In questi ultimi casi, se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
Tutto questo, è il caso di ribadirlo, se i fatti sono commessi da un autore “qualunque”.
Se i fatti, invece, sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata, scatta l’aumento secco di un terzo di pena.
Questa aggravante si applica al reato di gestione non autorizzata, appena visto, e a quelli di discarica abusiva, combustione illecita e spedizione illegale di rifiuti, pure disciplinati dal Testo Unico Ambientale e pesantemente coinvolti dalla riforma.
A proposito della discarica abusiva, si conferma il reato più grave (oggi delitto) tra quelli previsti da questo articolo. La relativa pena può arrivare, per rifiuti pericolosi e nei consueti casi particolari, alla reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. A cui si aggiunge, in caso di reato commesso in ambito aziendale, la già conosciuta aggravante dell’attività d’impresa: un terzo di aumento di pena.
Infine, oltre alle pene principali previste per i vari reati sopra esaminati, sono previste due misure accessorie di grande impatto per le aziende:
- la confisca del mezzo utilizzato per commettere l’illecito di gestione non autorizzata, salvo che esso appartenga a persona estranea;
- la confisca dell’area, per la realizzazione di discarica abusiva, fatti salvi gli obblighi di bonifica.
Insomma, restrizione della libertà (una pena detentiva questo è), per periodi di tempo non proprio fugaci, per dirigenti e rappresentanti dell’impresa; ablazione di beni strumentali essenziali come veicoli o terreni per il patrimonio aziendale.
Per essere una riforma – sceneggiata, niente male!
L’imprenditore e i suoi obblighi: l’omessa vigilanza
Una delle previsioni più emblematiche del ruolo che questa riforma attribuisce agli imprenditori sotto il profilo degli obblighi di tutela ambientale è quella che riguarda lo specifico obbligo di vigilanza sui loro sottoposti.
“Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa.”
Questa norma codifica un principio di responsabilità diretta dell’imprenditore per non aver adeguatamente controllato i propri dipendenti o collaboratori, peraltro già ampiamente consolidato nel diritto pretorio. Non sarà sufficiente (non lo era già da un pezzo, in effetti) affermare di non essere a conoscenza dell’illecito commesso dal singolo operaio o autista; l’imprenditore dovrà dimostrare di aver messo in atto tutte le misure necessarie per prevenire tali condotte.
Quanto alle sanzioni a tutela di quest’obbligo, oltre a quelle previste per le persone fisiche, sopra esaminate, la norma in questione ne prevede di autonome per l’impresa. In particolare, qui scatta una delle tagliole sanzionatorie più minacciose per il patrimonio aziendale, se non per la sua stessa sopravvivenza: la responsabilità diretta dell’azienda per fatti di reato commessi a suo vantaggio o nel suo interesse.
Per la precisione, in caso di omessa vigilanza, ai titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni cosiddette interdittive: parliamo di interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione…; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ancora sulla responsabilità degli enti: un altro terreno minato
Dato che abbiamo accennato il discorso, completiamolo.
Il decreto interviene in modo massiccio sulla normativa che disciplina la responsabilità amministrativa (di fatto, penale) degli enti per i reati ambientali. Le modifiche sono sostanziali:
Aumento delle sanzioni pecuniarie: le sanzioni in “quote” sono drasticamente aumentate per quasi tutte le fattispecie di reato ambientale. Ad esempio, per il traffico organizzato di rifiuti, le sanzioni sono quasi raddoppiate.
Nuovi reati presupposto: la responsabilità da reato viene estesa ai nuovi delitti introdotti dal decreto, come l’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e l’abbandono di rifiuti pericolosi.
Sanzioni interdittive: viene ampliato il ricorso alle sanzioni interdittive, sopra elencate. In particolare, per i reati più gravi, la durata delle sanzioni interdittive può arrivare fino a un anno. Nei casi estremi, se l’ente è stato utilizzato allo scopo unico o prevalente di commettere o agevolare questi delitti, si applica l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività: in pratica, la chiusura dell’impresa, d’imperio.
Per prevenire le conseguenze esiziali per un’azienda che possono comportare, da sole, queste ultime sanzioni, i titolari devono dotare la loro attività dell’unico scudo che possa difenderla seriamente: il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) per la prevenzione dei reati ambientali in azienda.
Le imprese di autotrasporto: un rischio in più
Per le imprese di autotrasporto per conto terzi il cui personale commetta qualcuno di questi reati, c’è un “bonus”: l’impresa che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali e realizzi una violazione in materia di rifiuti nell’ambito dell’attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, da quindici giorni a due mesi.
Se poi, i responsabili di questa impresa dovessero avere la brillante idea di reiterare le violazioni, si applicherebbe la sanzione accessoria della cancellazione dall’Albo, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.
Conclusioni provvisorie
Un decreto – legge deve essere convertito in legge, e il Parlamento resta sovrano anche in quest’ambito, a partire dalla fase degli emendamenti; ergo, prima di lanciarsi in giudizi definitivi, è buona regola attendere la definizione dell’iter legislativo.
Ciò posto, per le imprese il messaggio di questo decreto pare, comunque, difficilmente equivocabile e non sovvertibile: la gestione dei rifiuti non è più un mero costo operativo, ma un’area di compliance strategica ad altissimo rischio. Un approccio superficiale o estemporaneo alla normativa ambientale espone oggi l’azienda e i suoi vertici a conseguenze penali e patrimoniali senza precedenti.
Questo nuovo quadro normativo, in conclusione, impone un’immediata e approfondita revisione delle procedure interne, rendendo indispensabile l’adozione di pratiche di compliance strutturate ed un’organizzazione complessiva dell’attività produttiva all’insegna di un principio di fondo, cogente e immediato: la tutela ambientale – a partire da quella in materia di rifiuti – è un limite invalicabile al business d’impresa.
Con i meccanismi incentivanti, con le regolamentazioni volontarie, con la soft law, si è cercato, per lungo tempo, di far rispettare quel limite con le buone.
Non si è raccolto granché.
Anche in questo caso, è l’UE, nel suo Organo Esecutivo, a dare la linea: “le norme volontarie non creano certezza del diritto né per le società né per le vittime in caso di danni. L’azione volontaria non sembra aver portato a miglioramenti su vasta scala in tutti i settori e, di conseguenza, si osservano, sia all’interno che all’esterno dell’Unione, esternalità negative derivanti dalla produzione e dal consumo dell’UE.” E’ uno dei considerando della direttiva sulla cosiddetta “due diligence”.
Con questo decreto – legge, si torna all’antico: comando, controllo, sanzione (penale).
Potrà essere più o meno condivisibile. Ma non è seriamente contestabile che sia così.
Superare quel limite, oggi, può costare molto caro, a imprenditori e imprese.