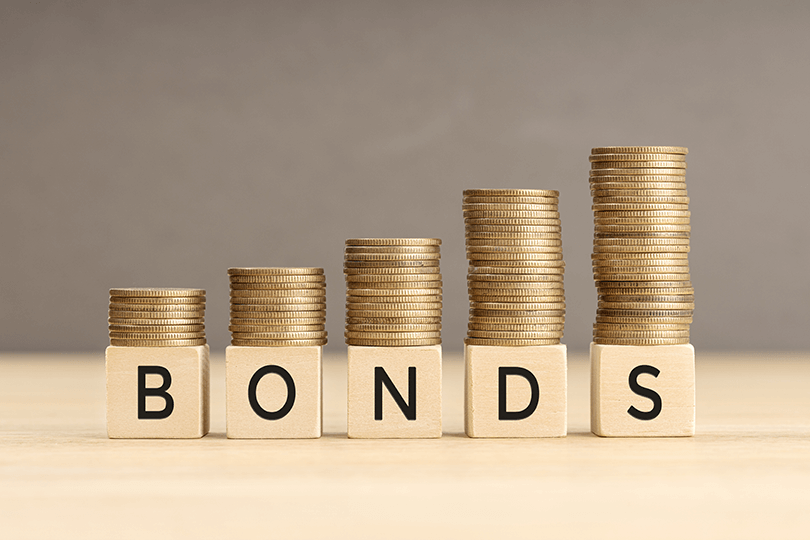Il suo segreto era tutto lì, in quella rabbia nervosa con cui spingeva i cerchi della sedia a rotelle che lo sosteneva da più di trent’anni, da quella maledetta notte d’autunno di Oppenau nel 1990, a due passi da casa e a pochi giorni dalla festa della riunificazione, quando alla fine di un incontro elettorale uno squilibrato gli scaricò addosso tre colpi di pistola, paralizzandolo per il resto della vita.
Ieri, Wolfgang Schäuble, l’ultimo grande vecchio della politica tedesca, è morto a 81 anni, portando via con sé le ultime tracce di una stagione politica non più ripetibile. Ma fino all’ultimo non permetteva quasi mai che fosse qualcuno dello staff a spingerlo sulla carrozzina lungo i corridoi. Era lui che, un colpo dopo l’altro, imprimeva alle ruote un ritmo nervoso, mai uguale, mai banale. Agli altri era al massimo concesso di aprirgli cortesemente qualche porta, di scortarlo discretamente lungo la via, mai di alleggerirgli il peso della fatica. Ha ottenuto molto da quella politica cui ha dedicato l’intera esistenza, ma l’impressione che trasmetteva all’esterno era quella di un uomo che si sente comunque in credito: Schäuble era il dottor Sottile della politica tedesca, cui il destino aveva sempre negato l’opportunità di affondare la zampata decisiva.
DESTINO E CARATTERE DI SCHÄUBLE
Anni fa, quando la sua immagine anche all’estero, anzi soprattutto all’estero, era legata al suo ruolo di ministro del Tesoro di Berlino nella tempesta dell’euro, la prima rete pubblica tedesca gli aveva dedicato un lungo documentario girato dal giornalista Stephan Lamby (Wolfgang Schäuble, Macht und Ohnmacht, potere e impotenza), che incollò ai teleschermi due milioni e mezzo di spettatori. Fu di fatto una sorta di omaggio-bilancio di un’interminabile carriera politica. Negli istanti conclusivi di quella intervista, l’ex ministro delle Finanze tracciò un bilancio di se stesso: “Sono sempre stato un soldato particolarmente scomodo”. È forse questa quella che gli anglosassoni chiamerebbero la sua legacy.
Destino e carattere si sono intrecciati sul suo percorso, il primo modellato dal secondo. Ed è sorprendente che uno con un carattere tanto ruvido e indipendente sia riuscito a tenersi a galla al fianco di politici altrettanto forti e ambiziosi come Helmut Kohl e Angela Merkel, specie nel momento in cui le strade, invece di scorrere parallele, iniziavano a collidere.
Fin dagli inizi il suo cammino in politica è apparso quello di un predestinato. Fino al 1990, un’ininterrotta salita verso i piani alti del potere: dall’ingresso al Bundestag nel 1972 fino alla guida del gruppo parlamentare, poi dal 1984 al fianco di Kohl come capo della cancelleria e quindi ministro dell’Interno nel suo terzo governo. Da quel ministero, nel 1990, dirige le trattative per la riunificazione e firma il trattato che la sancisce. Tre mesi dopo l’attentato, l’immobilità e, per dirla con le parole di colui che fu il suo miglior biografo, il giornalista Hans Peter Schütz, l’inizio della sua seconda vita. Che lo portò alla fine degli anni Novanta a vivere il tramonto dell’era Kohl, a gestire da presidente della Cdu lo scandalo dei fondi neri, a parare i colpi di coda risentiti del suo ex mentore e a subire l’ascesa inarrestabile di Angela Merkel, l’outsider che lui stesso aveva promosso al suo fianco come segretario generale del partito.
Cadute che sembravano ogni volta segnare la sua fine: colpi del destino, come nel caso dell’attentato, o esiti di battaglie politiche giocate sempre senza rete di protezione, come un funambolo in equilibrio precario su un filo retto da orgoglio, arroganza, lealtà, ingenuità, tenacia, presunzione. Tutti ingredienti che fecero di quest’uomo, pur considerato negli anni della crisi dell’euro un algido esecutore del dogma dell’austerity, uno dei pochi politici capace di guardare oltre lo spazio corto di una competizione elettorale.
E così come la partita sulla crisi greca sembrò in quella fase quasi un braccio di ferro esclusivo fra lui e Yannis Varoufakis, il “prof influencer” che Sipras gettò in pasto ai leoni prima di farsi addomesticare, gli altri momenti fondamentali della carriera politica di Schäuble furono segnati da altri confronti personali: con Helmut Kohl, con Angela Merkel. Incontri e scontri di personalità e di poteri, vissuti con passionalità da un politico di professione, di razza si diceva un tempo: un intellettuale ambizioso che ha fallito il salto al gradino più alto, la cancelleria.
Anno 2000. Lo scandalo dei fondi neri alla Cdu colpisce anche lui, perché gestisce malissimo l’accusa di aver ricevuto nel 1994 dal commerciante d’armi Karlheinz Schreiber 100 mila marchi di contributo per il partito, mai registrati. Chiamato a darne conto di fronte al Bundestag, si imbroglia con date e ricordi, appare reticente, dichiara il falso. “Come responsabile nel partito, mi sono dovuto occupare anche di questioni che non era bello ritrovare sulle prime pagine dei giornali”, aveva ammesso in seguito.
Schäuble non è mai stato estraneo alle vicende scottanti della Cdu, fin da quando dovette gestire le conseguenze dell’affaire Flick, uno scandalo di contributi non dichiarati che negli anni Ottanta colpì tutti i partiti tedeschi, esclusi i Verdi. “Qualche volta bisogna sporcarsi le mani”, diceva. Il concetto era che democrazia e politica abbiano dei costi, la convinzione (molto novecentesca) è che per il partito fosse anche possibile derogare alle regole. Faceva specie sentirlo da colui che fu ministro delle Finanze di un paese che in Europa pone sempre l’accento sul rispetto delle regole. “Fu un errore”, ebbe a dire con riferimento allo scandalo dei fondi neri del 2000, “sono esperienze che uno accumula nella vita, sapendo che resteranno per sempre nel suo curriculum”. Allora chiese scusa per il suo caso personale, ammise la propria parte di responsabilità, annunciò un nuovo congresso del partito e rinunciò a ricandidarsi alla presidenza.
Era l’aprile del 2000: alla guida della Cdu saliva Angela Merkel, Schäuble si ritirava in seconda fila. Non ha mai smesso di pensare che dietro le quinte delle indiscrezioni sul caso Schreiber, che a orologeria finivano sui giornali, agisse un rancoroso Helmut Kohl. I due, da allora, non si scambiarono più una parola. Proprio nel documentario di Ard Schäuble lanciò un ultima stoccata: Kohl non ha detto la verità sui fondi neri. Aveva sostenuto l’esistenza di un donatore segreto, di cui non voleva rivelare il nome per una questione d’onore. “Non c’era nessuno”, disse Schäuble, “i fondi neri esistevano da tempo”.
Diverso fu il legame con Angela Merkel. Non vi fu la complicità del rapporto con Kohl, ma distanza e rispetto reciproco. Lei lo aveva sorpassato nella corsa alla guida del partito, ma poi lo ripescò dall’oblio in cui rischiava di sparire. E lui fu capace di ritagliarsi un suo spazio in quel rapporto freddo con la prima donna alla guida di un governo tedesco. Quando Merkel ribaltò la sua politica sull’immigrazione, aprendo le porte a oltre un milione di rifugiati dal Medio Oriente, Schäuble le coprì le spalle, dando spessore a una giravolta politica: “È la vendetta della globalizzazione, l’immigrazione è una sfida a cui non possiamo sottrarci”, disse in vari interventi pubblici.
Prima di abbandonare la scena della politica attiva, Schäuble divenne presidente del Bundestag, ricoprendo con saggezza e autorevolezza un ruolo istituzionale super partes. Lo terminò fra il riconoscimento di tutti. Non era scontato. “Sono 43 anni più vecchio rispetto al ragazzo che nel 1972 si affacciava al Bundestag”, disse in un’intervista negli ultimi anni, “affronto fatiche che un tempo non avvertivo e la vita pubblica mi ha lasciato molte cicatrici. Sono un uomo leale ma non sono mai stato un conformista”.