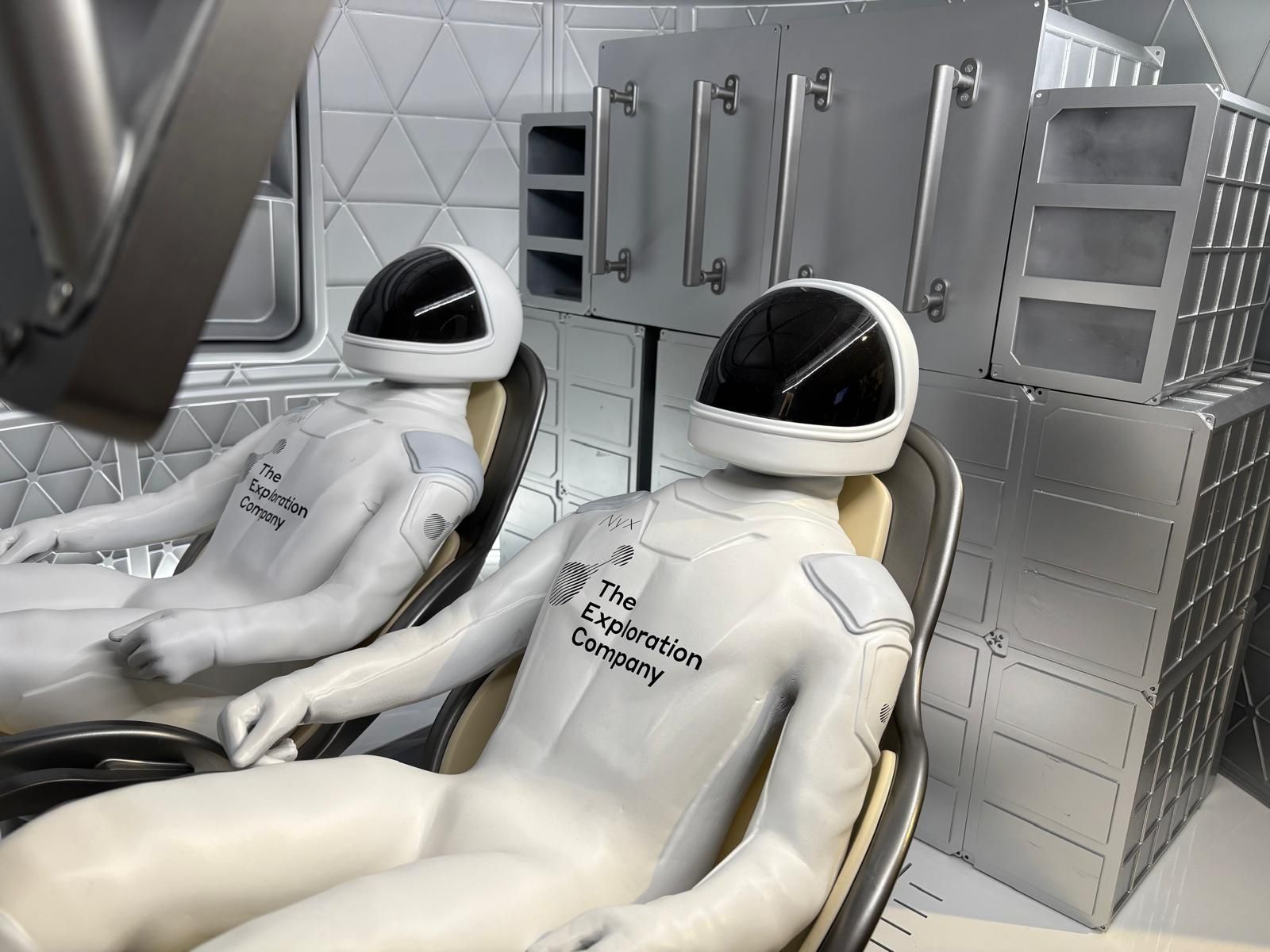Dieci ministri ai grillini e dieci ai loro nuovi alleati, dei quali nove al Pd e uno agli scissionisti di Leu, in un rapporto paritario che riporta al passato, quando al posto dei grillini erano i democristiani, nella parte più avanzata della loro collaborazione con socialisti e laici, a detenere la maggioranza relativa dei voti e dei seggi parlamentari. E si consideravano perciò l’ago della bilancia, come Luigi Di Maio dice del suo movimento per questa e persino per le “prossime legislature”, con un ottimismo della volontà, sospirerebbe la buonanima di Antonio Gramsci, ben superiore al pesssimismo della ragione.
Persino Massimiliano Cencelli, l’autore dello storico manuale col quale i democristiani dei tempi d’oro distribuivano il potere all’interno del loro partito e all’esterno, ha detto che il governo Conte 2 -per carità, non chiamatelo Conte bis perché, una volta tanto, ha ragione Marco Travaglio a protestare sul Fatto Quotidiano, trattandosi di tutt’altra maggioranza- ha rispettato proporzioni, rapporti di forza e quant’altro come si faceva una volta, quando la Repubblica era di edizione unica e originale. E si era affacciata solo alle finestre dei solitari e diversi Mario Segni e Marco Pannella la “seconda Repubblica” del sistema elettorale misto: per i due terzi maggioritario e per il rimanente terzo ancora proporzionale, quale scaturì poi dal referendum del 1993.
Appartiene al passato che curiosamente torna, almeno nelle apparenze, anche la disarticolazione, diciamo così, dei partiti della maggioranza, divisi in correnti, anime, aree, tendenze, spiriti e via discorrendo. Ne sa qualcosa il povero Nicola Zingaretti. Che, costretto dalle circostanze e dai tempi forse sbagliati della crisi scelti da Matteo Salvini, ha dovuto inseguire e persino scavalcare l’altro imprevedibile Matteo, Renzi, sulla strada dell’intesa a sorpresa con i grillini, rimangiarsi i propositi elettorali che lo accomunavano ai leghisti e infine portare al governo tutte le componenti del suo partito, perché nessuno poi gli potesse contestare parzialità, o nella speranza che nessuno prima o poi gliele contesti ugualmente. Ed è stato persino naturale che la deroga alla cosiddetta discontinuità, o rinnovamento, sia stata riservata nel Pd al ritorno al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo dell’ormai veterano, pur se giovanile, Dario Franceschini. Che all’interno del suo partito, forse non tanto per la forza dei numeri quanto per l’agilità con la quale sa muoversi, come si diceva una volta nella Dc di Enzo Scotti, chiamato Tarzan dal compianto Carlo Donat-Cattin, è un po’ l’ago della bilancia che Di Maio si considera, o considera il suo movimento, per l’intero sistema politico.
Di Maio però ha adesso un problema, tanto grande e temuto dalle sue parti che anche un uomo dall’apparente sistema nervoso di ferro come viene da qualche tempo considerato Giuseppe Conte ha dovuto in qualche modo cautelarsi strizzandogli l’occhio nella cerimonia di giuramento del nuovo governo al Quirinale. E sovrapponendo la mano all’altra del neo-ministro degli Esteri già stretta tempestivamente, con un calore unico fra tutti gli attori della cerimonia.
Eppure Di Maio, una volta messo in pista Conte per la conferma e fattolo politicamente ingoiare a Zingaretti, è stato quello che più ha creato poi difficoltà al presidente del Consiglio incaricato,, e forse è destinato a crearne anche adesso che è pienamente in carica ed entrambi hanno giurato nelle mani del capo dello Stato. L’ultimo ostacolo prima della chiusura formale della crisi, ritardata di quasi mezza giornata tra l’impazienza del presidente della Repubblica riferita dai giornali senza alcuna smentita o precisazione, Di Maio lo ha procurato a Conte, secondo le cronache neppure esse smentite, imponendogli la nomina di Riccardo Faccaro a sottosegretario alla Presidenza e segretario del Consiglio dei Ministri. Che è una postazione più importante dei Ministeri che pure si considerano di prima fascia, come quelli dell’Economia, dell’Interno, degli Esteri, della Difesa: tanto importante che Conte nel precedente governo dovette assegnarla all’uomo -Giancarlo Giorgetti- almeno allora di maggiore fiducia dell’alleato Matteo Salvini.
Per le mani, le orecchie, gli occhi e quant’altro del primo sottosegretario di Palazzo Chigi passano le pratiche, e relative decisioni, in entrata e in uscita dalla scrivania del presidente del Consiglio. Che proprio per questo, ritenendo di poter essere considerato, sia pure in modo “improprio”, come gli è capitato di dire, una persona del movimento delle 5 stelle, non a caso “elevato” dallo stesso Grillo nei giorni scorsi a un gradino sotto di lui, a sua volta sotto Dio direttamente, aveva pensato di poter nominare al posto di Fraccaro il segretario generale uscente di Palazzo Chigi, Roberto Chieppa.
Se proprio insiste e ci tiene, il presidente del Consiglio potrà nominare Chieppa sottosegretario lo stesso, imbottirlo di deleghe anche a scapito di Fraccaro già insediato, come è stato anticipato dai giornali mentre scrivo, ma la figura preminente accanto al capo del governo è e rimarrà lo stesso Fraccaro, generalmente catalogato, a torto o a ragione, come un uomo di raccordo vitale fra Di Maio e Davide Casaleggio. E’ come se Silvio Berlusconi nei suoi governi di centrodestra avesse dovuto rinunciare al suo fidato Gianni Letta, o ridimensionarne ruolo e deleghe.
Al di là dei nomi e delle persone, questa vicenda che ha accompagnato le ultimissime battute della crisi è indicativa dei problemi, chiamiamoli così, esistenti all’interno del movimento grillino, ben più complessi e meno trasparenti di quella certificazione notarile che ha assegnato nel referendum digitale della “piattaforma Rousseau” di Casaleggio sull’alleanza col Pd, dopo quella con la Lega, un 80 per cento “plebiscitario” ai sì, come ha detto Di Maio, e un 20 per cento ai no.
Di quell’80 per cento dei sì del virtuale congresso grillino svoltosi in poche ore è insondabile anche per il più accurato e imparziale osservatore, bisogna riconoscerlo, quanta parte sia riferibile a Di Maio e alla sua leadership, salvata con un altro referendum digitale dopo la scoppola delle elezioni europee del 26 maggio scorso, e quanta alle altre “anime” o sensibilità del movimento pentastellato, amch’esse tutte presenti adesso nel governo Conte 2. La indeterminatezza di questi equilibri, inevitabile nel tipo di organizzazione, o non organizzazione, che si è voluto dare il quasi partito che Di Maio ritiene di rappresentare, oltre che di comandare, è un oggettivo, innegabile ostacolo alla trasparenza che pure lo stesso Di Maio vanta pubblicamente e chiede perentoriamente alle altre formazioni politiche, negando di fatto la rappresentatività dei loro organi direttivi.
Anche questa è un’incognita con la quale dovrà fare i conti il nuovo governo, nato tra aperture e sollievi internazionali ma costretto a districarsi fra i problemi esterni e quelli interni ai partiti che lo compongono. E che non possono riposare con i coltelli sotto il cuscino.