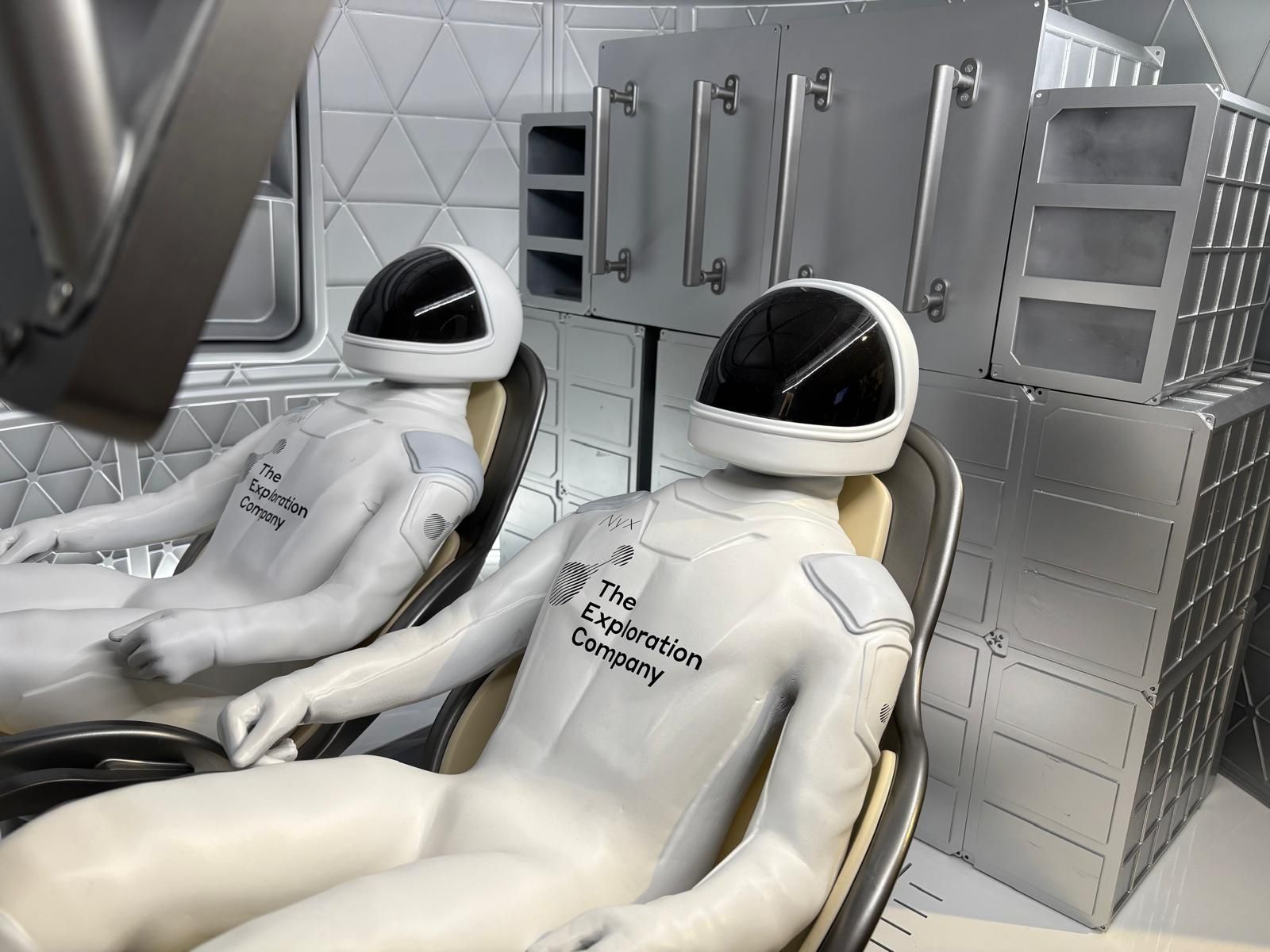C’è un vaccino contro il razzismo che non fa male, quando si inietta nelle vene dei bambini. Protegge dalla malattia del pregiudizio per tutta la vita. Il vaccino si rivela efficace se, fin dall’infanzia a scuola, nello sport, nel tempo libero e mai perduto, si ha a che fare con coetanei diversi per colore della pelle, lingua, nazionalità, religione delle loro famiglie. La convivenza da bambini è l’antidoto contro il virus.
Vedendo quanto il pregiudizio dilaghi in Europa sulle onde, letteralmente, delle immigrazioni, mi considero fortunato a essere nato e cresciuto fino a 13 anni in America latina, dove i problemi gravi sono altri, ma il razzismo non è di casa.
Tralascio i compagni di classe degli anni Sessanta poi diventati amici per sempre, alcuni di famiglia ebraica, altri con genitori “pardos”, ossia mulatti, altri ancora d’origine polacca. Nella mia scuola elementare e media di Montevideo, capitale dell’Uruguay, dove si parla spagnolo, nessuna differenza avrebbe mai potuto portare al pregiudizio. Perché tutti, in fondo, eravamo differenti, cioè unici. A cominciare dal sottoscritto, figlio di padre italiano.
Nel Peñarol, la mia squadra del cuore che ha vinto più coppe di tutte le squadre del mondo (tant’è che fu proclamata dalla federazione internazionale di calcio “campeón del siglo”, campione del Novecento), le maglie numero 9 e 11 appartenevano a due giocatori neri. Per di più il primo era ecuadoriano (Alberto Spencer) e l’altro peruviano (Juan Joya).
Come se non bastassero quei due calciatori, di cui, bambini, eravamo perdutamente innamorati per le gioie dei loro gol e delle movenze in campo da artisti del pallone, il mio idolo si chiamava Elías Ricardo Figueroa, difensore, magica maglietta numero 2 e inserito nelle liste Fifa tra i più grandi calciatori di sempre. Figueroa era ed è cileno.
Per chi cresce col mito di due neri e un quasi “pardo”, e tutti e tre “stranieri”, suona incomprensibile il dibattito surreale e ancora vivo se la fuoriclasse di pallavolo Paola Egonu, nata a Cittadella (Padova) da genitori nigeriani, abbia “tratti somatici” da italiana o no. Un dibattito che poi deflagra con facilità nelle polemiche sulla politica del governo per far fonte all’immigrazione. Ma il razzismo c’entra ben poco con il diritto/dovere per l’Italia e per l’Europa di regolare i flussi d’ingresso dal resto del mondo con rigore e compassione. E di farlo come meglio crede.
Non si confonda la pur discutibile strategia del centro per migranti in Albania con le discriminazioni o le xenofobie. Tanto più che, per impedirle, abbiamo buone leggi e magistrati sensibili nell’applicarle.
Tuttavia, non potrà mai essere una legge a convincerci della realtà dei fatti, ossia che Paola Egonu è come Sergio Mattarella, nonostante le diversità di pelle, età, ruolo, genere, perfino di dialetto conosciuto. Soltanto le nuove generazioni che fin dai banchi di scuola vivranno con naturalezza ogni diversità, e delle diversità faranno tesoro per le loro vite, rinunceranno a porsi domande cavernicole.
Intendiamoci, il pregiudizio non è certo “made in Italy” e viene da molto lontano. Fin dalla notte dei tempi l’“uomo nero” è stato evocato per incutere paura. La paura dell’ignoto.
Ma se con l’ignoto viviamo e giochiamo, se per l’ignoto tifiamo, se l’ignoto è il vicino della porta accanto, l’amico ritrovato o l’amore della vita, nessuno più si porrà l’interrogativo dei suoi tratti somatici, della sua fede, della sua nazionalità. L’“Apartheid”, che in Sudafrica fu la madre teoretica di tutti i razzismi, significa separatezza. Perciò è il suo opposto, è lo “stare insieme” che fa svanire d’incanto ogni paura, ogni pregiudizio, ogni “buh” delle curve contro i giocatori neri e avversari allo stadio. A proposito: mai mi è successo di fischiare contro i calciatori neri presenti anche nel Nacional, la squadra uruguaiana antagonista del Peñarol.
Di più. Ancora oggi il peñarolense Obdulio Varela, capitano della leggendaria Celeste che nel 1950 batté il Brasile a Maracanà, è da tutti ricordato e venerato come “el negro jefe”, il capo nero.
E nessuno s’è mai posto il problema di quali fossero le sembianze di quell’uruguaiano che è morto povero e solo, dopo aver regalato tanta felicità.
Pubblicato sul quotidiano Alto Adige
www.federicoguiglia.com