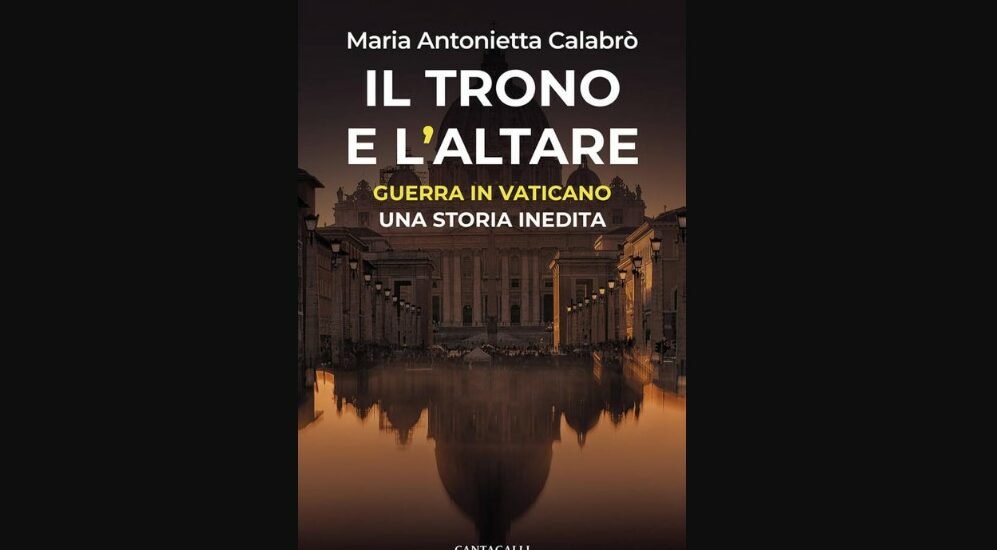La Chiesa cattolica americana ha convissuto per cinque anni con Donald Trump, di nuovo candidato alle elezioni del 2024.
I suoi vertici erano stati scelti pochi giorni dopo l’elezione del Presidente repubblicano che aveva sconfitto la candidata democratica Hillary Clinton. Il 16 novembre 2016, erano stati eletti il Presidente della Conferenza episcopale americana (USCCB), il cardinale di Galverston-Houston, Daniel Di Nardo 67 anni, che per tre anni era già stato Vicepresidente e il numero due, l’arcivescovo di Los Angeles, José Horacio Gómez, 65 anni. Di Nardo, figlio di un immigrato italiano dall’Abruzzo e Gómez, nato in Messico. Era la prima volta che un ispanico arrivava così in alto nelle gerarchie cattoliche in USA. Quindi entrambi conoscono per esperienza diretta quanto sia necessaria l’integrazione dei migranti in una nazione in cui lo stesso stemma presidenziale contiene il motto: “E pluribus unum”.
Sia Di Nardo che Gómez sono teologicamente “conservatori”.
Di Nardo è stato uno dei tredici cardinali che nel 2015 ha firmato una lettera al Papa per “contestare” i lavori del Sinodo sulla famiglia. È stato Benedetto XVI che nel 2010 ha nominato Gómez coadiutore e, l’anno successivo, arcivescovo di Los Angeles (molto più “a destra” del suo predecessore, Roger Mahony). Gómez proviene dalle fila dell’Opus Dei. Ma sull’immigrazione Gómez, è stato sulla stessa lunghezza d’onda di Papa Francesco. Lo ha ripetuto più volte, anche il 4 ottobre 2016 alla Radio Vaticana.
Nell’elezione di Trump il voto cattolico ha fatto la differenza. Circa 68 milioni negli USA, i cattolici costituiscono un quarto dell’elettorato e il tycoon ne ha conquistati il 52 per cento (contro il 45 per cento di Hillary Clinton), compresi i latinos della Florida che sono stati essenziali per la vittoria di “The Donald” – avvenuta nonostante Hillary Clinton avesse concluso la campagna elettorale insieme al Presidente uscente, Barack Obama, con la frase-mantra di Papa Francesco: “Costruiamo ponti e non muri”. Difficile dire se la Clinton avesse “abusato” di questo slogan. Oppure se fosse stata “autorizzata” (non si usa una frase del genere a poche ore dall’apertura dei seggi elettorali, senza chiedere il “permesso” a un così speciale copywriter). Il fatto in sé fu comunque clamoroso, e dopo la vittoria di Trump segnò un’indiretta sconfitta per la Santa Sede.
Naturalmente, il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, ebbe subito modo di assicurare al nuovo Presidente repubblicano le sue preghiere affinché “il Signore possa illuminarlo e aiutarlo nel suo servizio della sua Patria” e “nel servizio del benessere e della pace nel mondo”. Ma queste affermazioni sono state precedute da una fredda premessa protocollare che è stata il miglior indice del mood vaticano dopo l’elezione: “Prendiamo nota con rispetto della scelta espressa dal popolo americano”, aveva commentato laconico Parolin, a margine dell’inaugurazione del nuovo Anno Accademico dell’Università lateranense. Durante il suo intervento, Parolin ha ammesso che la diplomazia papale avrebbe dovuto “trovare nuove formule” nel nuovo contesto globale. Il Papa (che il giorno dopo l’elezione, durante l’udienza generale del mercoledì non aveva fatto nessun commento), alcuni mesi prima, in febbraio, ritornando da un viaggio in Messico, aveva dichiarato rispondendo ad una domanda sul tycoon: “Chi costruisce muri non è un cristiano”. Ed era tornato con un commento simile durante il weekend che aveva preceduto il voto presidenziale, in cui aveva ancora una volta messo in guardia dalla paura e dalla costruzione dei muri.
Nei mesi precedenti tre iniziative vaticane di gran peso erano sfuggite alla maggioranza degli osservatori, nella loro relazione all’imminente scelta del nuovo inquilino della Casa Bianca.
Innanzitutto, l’iniziativa del nunzio Christophe Pierre, di celebrare una messa al confine con il Messico il 23 ottobre 2016, cioè ad appena 15 giorni dal voto, proprio sul limite della cancellata di sicurezza che divide i due Paesi. La seconda è stata la scelta di Francesco di imporre la berretta cardinalizia all’arcivescovo di Indianapolis, Joseph Tobin, annunciata il 9 ottobre. Tobin il giorno dopo, sfidò il divieto del Governatore dell’Indiana Mike Pence (cioè di colui che correva come numero due di Trump alla carica di Vicepresidente degli Stati Uniti) di far stabilire nel suo Stato un gruppo di rifugiati siriani. Infine lunedì 7 novembre il Papa ha destinato Tobin a Newark, come una specie di alter ego (le due diocesi confinano, e Newark non era mai stata sede cardinalizia) del cardinale di New York, Timothy Dolan, considerato troppo conservatore.
Dopo l’elezione di Trump, Tobin ha twittato senza nessun riferimento al nuovo Presidente, citando San Paolo che “ci invita a pregare per i re e per tutti coloro che hanno posizioni di autorità perché possano condurre una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà ed onestà”.