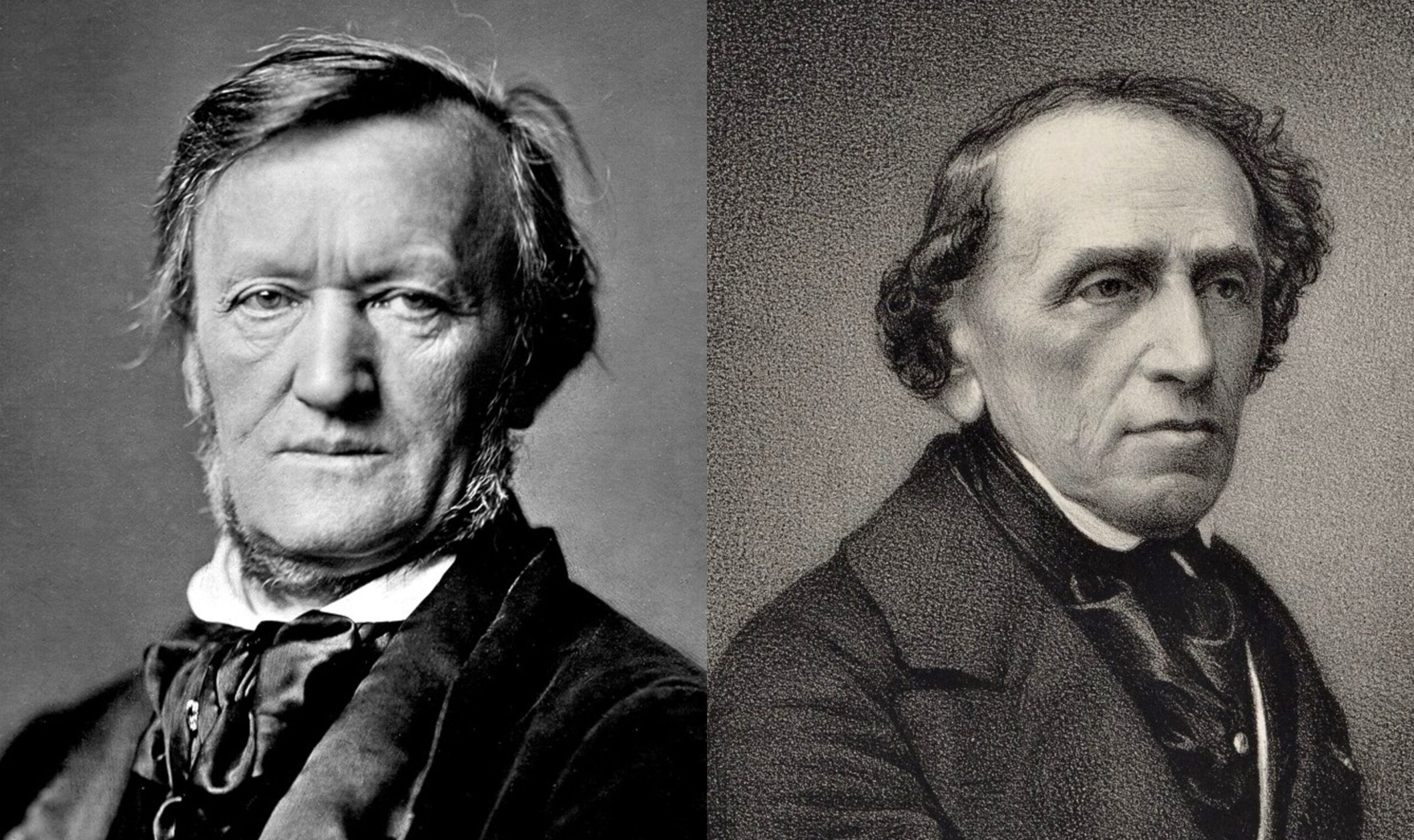Parla Sara, che era una bambina di famiglia ebrea a Salonicco durante la seconda guerra mondiale.
“Me lo ricordo come fosse oggi. Per i nostri amici cristiani era il giorno della festa della Panaghía, 15 agosto 1940, e mio padre, commerciante di stoffe all’ingrosso, entrò in casa come sempre, apparentemente calmo. ‘Sedetevi e state a sentirmi’, disse con aria però grave, ‘dobbiamo prendere una decisione perché i tempi sono brutti, per noi più che per gli altri. Gli italiani hanno silurato una nostra nave proprio davanti a Tinos, hai sentito la radio?’.
Ma quale radio? Mia madre la accendeva solo quando era l’ora delle canzonette francesi e italiane, per lei il bollettino delle notizie era da evitare. ‘Ma come sarebbe a dire che hanno silurato una nostra nave, ma non siamo un Paese neutrale?’, reagì.
‘Neutrale o non neutrale, la nave l’hanno silurata. Quelli hanno una sola idea in testa: dimostrare ad Hitler che non sono da meno della Germania e per questo ti giuro che prima o poi, anzi prima, invaderanno la Grecia. Un cliente che ha un negozio a Jannina mi ha detto che in quella città gira solo una voce: gli italiani stanno facendo manovre militari ed ammassando viveri in Albania. Ma non ho paura degli italiani, il fatto è che li conosco, la guerra non è cosa per loro, vedrete che i montanari li ricacceranno immediatamente indietro. Per questo poi verranno i tedeschi, e quelli arriveranno fino qui, altro che gli italiani. Per noi sarà la fine, altro che negozio, bella casa, lezioni di pianoforte per la bambina, feste con gli amici. Roza, ce ne dobbiamo andare. Il negozio lo affido a Aristidis, la casa la metto in vendita e se non riusciamo a venderla subito, pure quella la affido a Aristidis, prendo tutti i soldi dalla banca, vendo quello che non possiamo portarci con noi e ce ne andiamo’.
‘In Palestina, finalmente!’, aggiunse mia madre, intellettuale affascinata dal movimento sionista. ‘Scordatelo, noi in Palestina non ci andremo, neanche se me lo ordinasse Dio in persona, qui davanti a noi. Gli ebrei che sono andati lì non mi piacciono, non mi piacciono le loro idee, non mi piace il loro modo di vivere. Socialisti e comunisti sono, ecco che cosa sono. E poi quell’idea degli ebrei che si mettono a fare gli agricoltori, ma che stupidaggine è? Ma quando mai gli ebrei hanno fatto gli agricoltori? Ma mi vedi a me a spingere un aratro? A zappare? A seminare? A raccogliere? Ma per favore, ad ognuno il suo mestiere …’.
‘Beh, potresti continuare a vendere stoffe’. ‘A chi? A quelli là? Ma quelli non comprano stoffe, non comprano vestiti, nei kibbutzim non conoscono la proprietà privata, neppure dei vestiti, e a Tel Aviv ci sono già tanti che fanno il mio lavoro. Io voglio che mia figlia cresca in un ambiente normale, non dove c’è promiscuità fra i sessi, dove le donne vanno in giro con pantaloni attillati come quelli degli uomini, dove uno non è padrone neppure dei propri vestiti … e per giunta parlano tedesco. E poi in Palestina comandano gli inglesi, e degli inglesi non mi fido. Senza dire che prima o poi scoppia una guerra pure là, con gli arabi. E i kibbutzim non resistono neanche un giorno, e neppure resiste Tel Aviv. Ma ti rendi conto? Qualche centinaio di migliaia di ebrei contro centinaia di milioni di arabi, ma quante possibilità hanno? Io ho un piano serio invece’.
Siccome la discussione mi interessava, anzi mi piaceva, perché l’idea di lasciare Salonicco per andare per il mondo era uno dei miei sogni, e siccome mi sentivo abbastanza grande per poter dire la mia, la mia la dissi. ‘In America, papà, in America dobbiamo andare’. E chi si dimenticherà mai la faccia, anzi tutti i particolari delle espressioni della faccia di mio padre in quel momento! La reazione si poteva sintetizzare con un ma che figlia intelligente che ho. Ma lui disse solo che era una buona idea ma che oramai l’America aveva chiuso le porte agli emigranti, anche agli ebrei, ed anche agli ebrei benestanti come noi. E che dunque bisognava stare al suo piano”.
Non andammo in Palestina. Non andammo in America. L’Europa, da Ovest ad Est, non era cosa per noi. Mio padre diceva che neppure nei paesi neutrali avremmo finito col vivere una vita normale. C’era chi era finito in Australia e chi in Sudafrica, ma mio padre voleva restare il più possibile vicino al suo negozio: ‘Quando tutto questo disastro finirà, voglio tornare in negozio al più presto possibile, ricominciare a passare le giornate facendo conti e telefonate, sorvegliando i commessi e bevendo caffè giocando a tavli con il vicino. Se ce ne andiamo lontano, a Salonicco non ci torneremo più’.
L’attuazione del piano di mio padre ci portava a Tirana. Lì c’era una piccola comunità di ebrei albanesi a cui gli italiani non davano troppo fastidio. Saranno state un paio di centinaia di persone. Furono loro ad accoglierci. Mi accorsi che mio padre non era stato l’unico ad aver avuto l’idea di fuggire in Albania, perché in soli tre giorni incrociammo tantissimi altri ebrei che venivano da ogni parte di quel Terzo Reich allargato che era diventata l’Europa continentale. Da allora l’ho amato di più mio padre, ma soprattutto stimato di più. Aveva visto giusto. L’Albania era l’unico posto dove il numero di ebrei invece di diminuire aumentava, Palestina a parte. Un posto dove saremmo stati sicuri.
Ed infatti così fu. Ma non solo per merito di quel paio di centinaia di ebrei albanesi, ma grazie a tutti gli albanesi. Ci consideravano ospiti, e come ospiti, intoccabili. Ci diedero nuovi documenti. Ci diedero vestiti modesti, per non dare nell’occhio. Ci mandarono in un villaggio vicino Valona, non in città, dove invece c’erano la casa del fascio e la milizia. Dicevano che prima o poi forse sarebbero arrivati i tedeschi e che quindi bisognava prendere da subito tutte le precauzioni possibili. Nel villaggio mio padre prese possesso di una casa modesta, sempre per non dare nell’occhio. Pagava l’affitto puntualmente. Mia madre si annoiava. Io no, mi sembrava di stare in vacanza, per giunta in un posto in cui potevo stare con i vestiti sporchi e giocare con tutti gli altri bambini per strada. Altro che lezioni di piano e scuola, quella sì che era una bella vita.
Intanto io, più che bambina, ero diventata una ragazzina. Mia madre mi schiariva i capelli con l’infuso di camomilla, perché fossi meno riconoscibile. Con risultati grotteschi (come vedi la mia carnagione è irrimediabilmente olivastra). La porta di casa era sempre aperta, per permettere ai vicini di entrare in ogni momento e quasi sempre con qualche omaggio: uova, latte, formaggio. Una volta una capra intera. Mio padre voleva pagarla, ma non gli fu permesso di farlo. Mi ricordo l’odore del pane fatto in casa, quando qualcuno portava la farina: mai sentito dopo di allora un profumo come quello.
Caro Alessandro, ho la mia età ma un giorno voglio tornare in quel villaggio. Ho un debito di riconoscenza da saldare verso gli albanesi che ci nascosero e ci salvarono”.