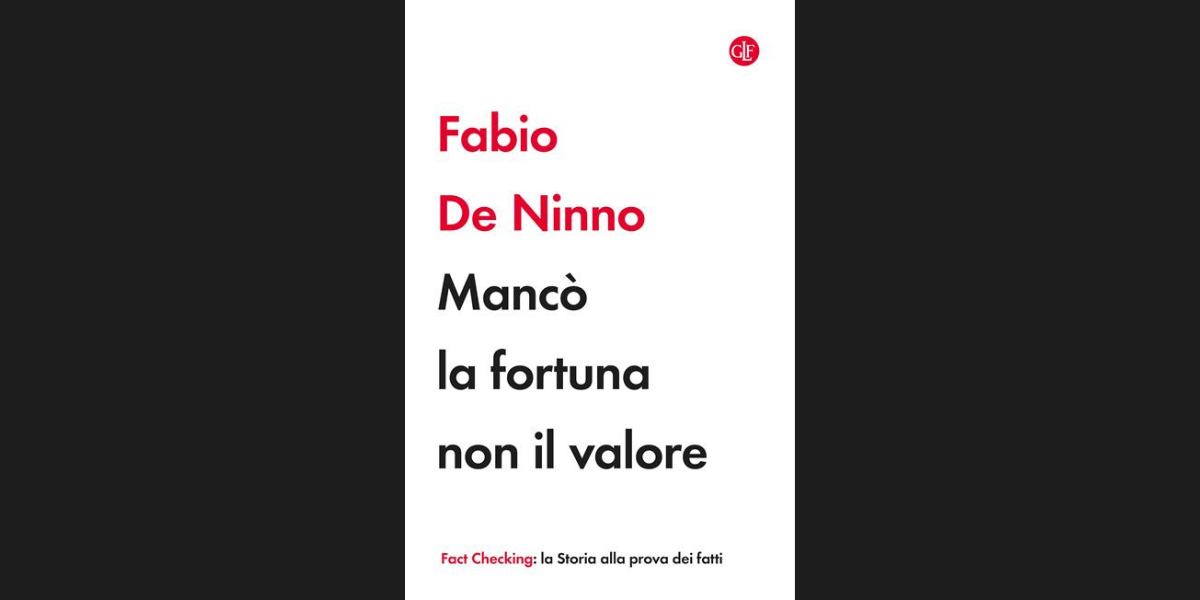Domenica 27 luglio 2025, nell’area di servizio di Lainate lungo l’autostrada A8, un cittadino francese di religione ebraica è stato aggredito fisicamente e verbalmente da un gruppo di persone per il solo fatto di indossare la kippah. La vittima, Elie, cinquantaduenne parigino in Italia per far visita alla figlia, era accompagnato dal figlio di sei anni. L’episodio ha avuto luogo in pieno giorno, in pubblico, ed è stato interamente documentato. Il movente non è in discussione: Elie è stato attaccato in quanto ebreo visibile.
Siamo dinanzi a una violazione grave e sistemica dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, europeo e internazionale. Il fatto che la vittima sia stata colpita nella sua identità, e davanti a un minore, rende l’episodio ancora più emblematico.
L’ANTISEMITISMO COME QUESTION GIURIDICA, NON SOLO MORALE
L’antisemitismo non è un’opinione, né un’espressione del dissenso: è una forma di violenza sistemica e simbolica che mina le basi stesse della democrazia costituzionale. Come ha ricordato la Corte EDU nel caso M’Bala M’Bala v. France (2015), esiste un limite intrinseco alla libertà di espressione, sancito dall’articolo 17 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: nessun diritto può essere invocato per distruggere i diritti altrui.
Questa visione è pienamente condivisa dal Rapporto delle Nazioni Unite A/HRC/37/49 (2018), presentato da Ahmed Shaheed, Relatore Speciale sulla libertà di religione o convinzione, secondo cui la libertà religiosa deve essere protetta non solo contro la coercizione istituzionale, ma anche contro la semantica dell’esclusione sociale e della marginalizzazione simbolica.
Nel paragrafo 81, il Relatore sottolinea che gli Stati hanno l’obbligo di garantire la libertà di religione o convinzione in modo imparziale, senza favoritismi religiosi né ostilità implicite, e riconosce che tale libertà include il diritto alla visibilità identitaria senza timore di ritorsioni o discriminazioni. La libertà religiosa — chiarisce il rapporto — non è solo un diritto individuale, ma anche una rivendicazione nei confronti dell’ordinamento stesso, che deve rinunciare al potere di decidere chi abbia titolo per credere, come e dove.
Al paragrafo 74, si richiama l’attenzione sulle “forme indirette” di discriminazione religiosa, che possono manifestarsi anche attraverso l’intolleranza nei confronti dei segni esteriori dell’identità religiosa, come gli abiti o i simboli. Quando una persona viene aggredita per la sola presenza di un segno religioso, ciò costituisce una violazione diretta e strutturale della libertà garantita.
Infine, il paragrafo 89 propone un modello che rifiuta tanto l’indifferenza quanto l’assimilazione: uno Stato laico deve adottare una postura di “respectful distancing” — un distacco rispettoso — che non consiste nel negare la religione nello spazio pubblico, ma nel proteggere attivamente la pluralità simbolica delle identità. È in questo quadro che l’antisemitismo, anche se mascherato da slogan politici, va riconosciuto come ciò che è: una forma intollerabile di violazione della libertà religiosa, dell’uguaglianza e della dignità.
LA DEFINIZIONE IHRA E IL PROBLEMA DELLA DISTINZIONE
In questo contesto si inserisce il dibattito — tuttora aperto — sulla cosiddetta IHRA Working Definition of Antisemitism, adottata nel 2016 dall’International Holocaust Remembrance Alliance. Questa definizione non è giuridicamente vincolante, ma è stata recepita da numerose istituzioni europee, tra cui la Commissione Ue, e funge da parametro operativo per il riconoscimento di episodi di antisemitismo.
Come ha evidenziato Emilie Wiedemann nel saggio Defining Antisemitism in the New Millennium, la definizione IHRA nasce da un’esigenza di monitoraggio e non da un intento censorio: si tratta di uno strumento per aiutare le autorità a distinguere tra legittima critica politica e antisemitismo mascherato. Il dolore generato dall’aggressione non è un semplice fatto, ma una fonte epistemica primaria, in cui il dolore diventa linguaggio, testimonianza e rivelazione. È il segnale che qualcosa — un gesto, una parola, una narrazione, una politica — ha colpito non solo un individuo, ma una memoria, una storia, un’identità collettiva.
«I veri colpevoli sono coloro che affidano incarichi di fiducia a degli Israeliti», scriveva Drumont nel 1894. Così comincia ogni antisemitismo: gli Ebrei sono non integrabili, non innocenti a prescindere. In quel non si annida tutta la retorica dell’esclusione. Ed è un non che ritorna, oggi, sotto altre forme. Quando un simbolo identitario diventa un bersaglio. Quando una parola — Palestina — viene piegata a insulto. Quando la sofferenza di un popolo serve da pretesto per colpire un altro. Quando si confonde il volto con lo Stato, l’identità con la politica, l’essere ebreo con il dover pagare.
Di nuovo, dunque, si ripete quel corto circuito semantico che la nostra Costituzione aveva promesso di disinnescare: la sovrapposizione tra la persona e la colpa, tra l’appartenenza e la responsabilità. È proprio questa la grammatica dell’antisemitismo: non ha bisogno di prove, perché ha già deciso il bersaglio indipendentemente da ogni responsabilità.
L’antisemitismo, in questa prospettiva, non è un monolite, ma un fenomeno dalle mille maschere. Si manifesta con l’aggressione fisica, con la propaganda politica, con le grida delle piazze, ma anche con le narrazioni più sofisticate. In questo senso, il discorso antisemita è subdolo, adattabile, proteiforme. Cambia linguaggio, ma non sostanza. Come un virus, si adatta all’organismo che lo ospita. Ed è proprio questa sua capacità di mutare che rende inutile, secondo Della Pergola, la distinzione tra “vecchio” e “nuovo” antisemitismo. Ogni forma è nuova quando nasce, e vecchia un attimo dopo. L’unica costante è la funzione: colpire l’ebreo, delegittimarlo, escluderlo.
PROPRIO PERCHÉ È EBREO: IL NODO IDENTITARIO
Elie non è stato colpito “nonostante” fosse ebreo. È stato colpito proprio perché è ebreo, e perché la sua identità era leggibile, pubblica, visibile. È qui che si compie la violenza semantica: quando una presenza culturale diventa un bersaglio. E questo ci impone di riconoscere che l’antisemitismo non è una patologia del passato, ma una questione giuridica viva, che richiede un’azione sistemica.
Nel pianto del figlio di Elie, tenuto da una sconosciuta mentre il padre veniva picchiato, c’è la memoria incarnata della Shoah, e al tempo stesso la fragilità delle tutele odierne. L’aggressione di Lainate dimostra che non basta la non discriminazione: serve una protezione attiva del diritto al godimento del proprio patrimonio culturale immateriale anche religioso, così come affermato dalla Convenzione di Faro sul patrimonio culturale, ratificata dall’Italia nel 2020.
Difendere Elie non significa solo difendere una vittima. Significa difendere il patto democratico tra visibilità e libertà. Significa dire, con chiarezza giuridica e politica, che nessuno deve essere colpito per ciò che è. E che la protezione dell’identità ebraica è oggi una cartina al tornasole della tenuta costituzionale dell’Italia.
La nostra Costituzione non è neutra: è schierata dalla parte di chi è reso vulnerabile dalla propria identità. E se oggi non abbiamo il coraggio di nominare l’antisemitismo dove c’è, allora abbiamo già abdicato a una parte della nostra legalità.
Questa aggressione, accaduta in un autogrill, con un padre a terra e un figlio che piange, non è un incidente. È un sintomo. E la democrazia — se è ancora tale — non può limitarsi a prenderne atto.
Noi non ci limitiamo a prenderne atto: siamo vicini alla comunità ebraica e molto decisi in ambito accademico e istituzionale a difendere la verità di un popolo rilanciando i suoi diritti, la sua storia, la nostra cultura.