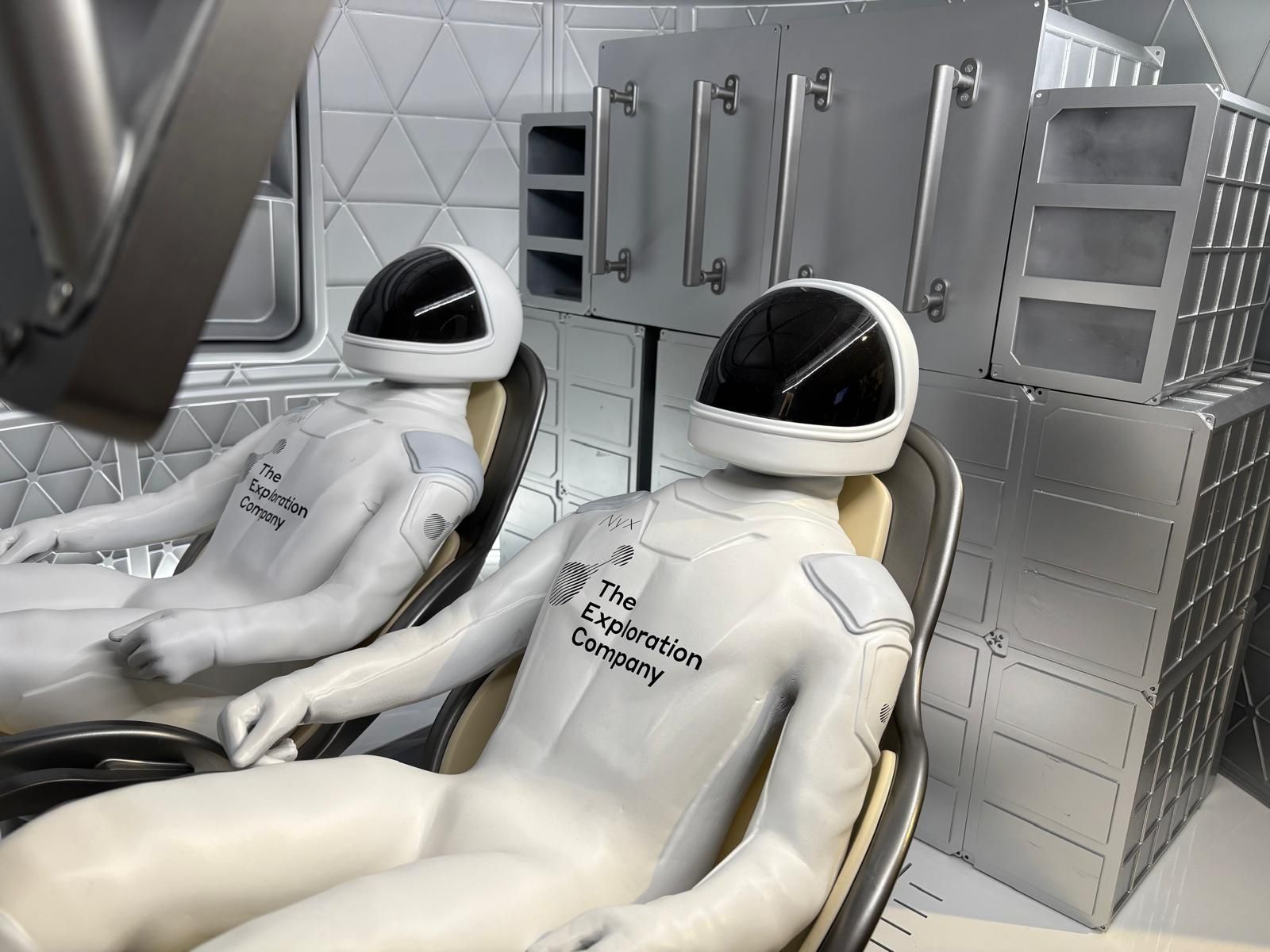Penso che stia arrivando il momento, se non è già arrivato, di riprendere col carissimo amico Gerardo Bianco un’idea dalla quale fummo tentati una quindicina d’anni fa, rinunciandovi alla fine perché, bene o male, per quanto pasticciato e zoppicante, sembrava avesse preso piede il bipartitismo della cosiddetta seconda Repubblica.
Acque e pesci, tutti provenienti della cosiddetta Prima Repubblica, si erano talmente mescolati che ci sembrò opportuno rimanere alla finestra e vedere come si sarebbe ulteriormente sviluppata l’avventura politica avviata nei tribunali, non importa se più a caso o apposta, per reazione beffarda alla caduta del Muro di Berlino, cioè del comunismo, perché i vincitori sul campo storico diventassero gli sconfitti e viceversa.
La nostra tentazione era di costituire un’associazione di “Amici della Prima Repubblica”, cioè di estimatori di una lunga parte della politica italiana contrassegnata dalla ricostruzione degasperiana e dall’allargamento, via via, delle alleanze democratiche: dal centrismo al centro-sinistra, col trattino, e dal centrosinistra senza trattino alla simbiosi delle due formule col cosiddetto pentapartito, comprensivo di liberali e socialisti precedentemente alternativi gli uni agli altri, superata la pausa o tregua -come si preferisce chiamarla- della cosiddetta “solidarietà nazionale”. Che fu imposta fra il 1976 e il 1978 alla Dc di Aldo Moro e al Pci di Enrico Berlinguer dalla perdita di autonomia dei socialisti di Francesco De Martino, timorosi di governare con lo scudo crociato senza l’appoggio dei comunisti, e dalle emergenze dell’economia e del terrorismo.
Nè io né il mio amico Gerardo potevamo immaginare, accantonando il progetto della nostra associazione, che la spinta a riprenderlo avrebbe potuto venirci da una forza politica allora neppure sul mercato elettorale. Mi riferisco naturalmente ai grillini, o pentastellati. Il cui arrivo sembrò almeno a me, ma credo anche a Gerardo, davvero la fine del nostro mondo politico.
Ebbene, arrivati non solo al Parlamento ma anche al governo con forbici, seghe, tenaglie, apriscatole e quant’altro per una rottamazione rispetto alla quale quella precedentemente tentata o perseguita da Matteo Renzi era stata poco più di una barzelletta, i grillini battono da qualche giorno -nel pandemonio politico prodotto anche dalla pandemia virale- strade, sentieri, sentierini della tanto lontana e disprezzata Prima Repubblica senza neppure rendersene conto, anzi continuando a dirne tutto il male possibile e immaginabile.
Poverini, non volevano neppure sentir parlare di statuti per il loro MoVimento -si scrive così- avendo paura di somigliare ai partiti e ne hanno adottati di equivoci e ambivalenti che non so neppure come li definiscano, ma possono essere modificati al computer da poche migliaia di persone presuntivamente militanti, gestite da una piatttaforma privata che viene ogni giorno e ogni ora sempre più contestata dai cosiddetti “portavoce”. Che pure debbono a quegli stessi computer e a quelle stesse mani le loro candidature e i loro approdi al Parlamento.
Ancòra, non volevano neppure sentir parlare di programmi su cui trattare la formazione dei governi, una volta fallito l’obiettivo di poterne fare uno tutto loro, autosufficiente, preferendo stendere attorno a tavoli più o meno larghi veri e propri “contratti”, peraltro esenti dalla presenza di un notaio, bastando e avanzando l’avvocato civilista promosso sul campo da potenziale ministro dell’ennesima riforma burocratica a presidente del Consiglio, e ora discettano con Renzi, Zingaretti ed altri di un “programma di fine legislatura”. Che li possa mettere meglio al riparo dal rischio di elezioni anticipate, da cui uscirebbero -nel migliore dei casi- con un terzo dei voti raccolti fortunosamente nel 2018.
Ho letto da qualche parte che il ministro più alto in grado di cui dispongono i grillini, che non è il guardasigilli e capo delegazione al governo Alfonso Bonafede ma il titolare della Farnesina Luigi Di Maio, non si accontenta neppure di un programma, forse troppo generico e indeterminato per i tempi che corrono, ma vorrebbe un “cronoprogramma”. Alla cui gestione, controllando la puntualità anche dei minuti e dei secondi, potrebbe essere preposto un apposito ministro.
Così avvenne del resto ai tempi della cosiddetta Seconda e anch’essa odiata Repubblica: prima con Giuseppe Pisanu e poi con Claudio Scajola, entrambi forzisti, consolati da Silvio Berlusconi con l’incarico di vigilare sull’attuazione del programma, appunto, dopo altre esperienze più impegnative ma, diciamo così, accidentate, fra le quali l’Interno. Dove al povero Scajola, prima ancora della vicenda della casa acquistata a Roma con suggestiva vista sul Colosseo e forte sconto a sua insaputa, era capitato di sottovalutare, diciamo così, le pur fondate paure del giuslavorista bolognese Marco Biagi di essere ucciso da eredi o imitatori delle già sconfitte brigate rosse. Il che purtroppo avvenne sotto casa del professore il 19 marzo 2002 nel giorno di San Giuseppe, patrono dei lavoratori.
Fu addirittura attribuita al ministro Scajola un aggettivo –“rompicoglioni”- nei riguardi del povero Biagi che francamente non ho mai creduto ch’egli avesse pronunciato, parlando forse di altri che gli avevano rappresentato male la situazione di pericolo in cui il povero Biagi, consulente del ministro leghista del Lavoro Roberto Maroni e del sottosegretario Maurizio Sacconi, di provenienza socialista, si trovava dopo avere ricevuto telefonate ed altri segni di minacce.
Oltre al programma o cronoprogramma dei bei tempi della Prima Repubblica, quando i programmi spesso venivano dileggiati come libri dei sogni dai critici di turno, compresi autorevoli esponenti della maggioranza come la buonanima di Amintore Fanfani in polemica con Moro, l’altro “cavallo di razza” della scuderia democristiana decantata da Carlo Donat-Cattin, sta tornando nel linguaggio politico di questa presunta Terza Repubblica anche il termine “verifica”, sia pure tra le resistenze o addirittura le proteste persino del presidente del Consiglio. Che mostra spesso di volerla evitare, per quanto sollecitata dal segretario del Pd Zingaretti, dal vice Andrea Orlando e dall’ex presidente del Consiglio Renzi, ora semplice senatore di Scandicci e leader della vivace ma elettoralmente modesta Italia Viva, appena misuratasi nelle urne regionali e comunali di settembre.
Sono da capire le resistenze di Conte alla verifica, pur alla fine promessa di fronte alle insistenze del Pd ma prudentemente posticipata ai cosiddetti Stati Generali di chiarimento dei grillini, già fissati per il 7 novembre e curiosamente rinviati di una settimana subito dopo il sì evidentemente inatteso del presidente del Consiglio a Zingaretti e amici. E non sarà un rinvio risolutivo ai fini del chiarimento all’interno del laceratissimo MoVimento 5 Stelle, in crisi di identità almeno dalla scoppola rimediata nelle elezioni europee di fine maggio dell’anno scorso. E’ stato già precisato che agli Stati Generali da remoto, e non più fisici come previsto prima della riesplosione della pandemia, dovranno seguire non una ma una serie di consultazioni digitali sulle posizioni emerse dal confronto del primo giro.
Dicevo della comprensione che merita la diffidenza di Conte. Pur nuovo, o relativamente nuovo alla politica, e di età tale da avere personalmente vissuto con i calzoni corti, o quasi, i tempi della Prima Repubblica, egli deve avere appreso da qualcuno di maggiore esperienza che ai tempi di Moro, di Fanfani, di Mariano Rumor, di Giulio Andreotti ma ancor prima anche ai tempi di Alcide De Gasperi e Attilio Piccioni, le verifiche non erano passeggiate o passatempi. I loro percorsi erano o diventavano spesso tanto accidentati da sfociare in crisi vere e proprie di governo.
Le crisi, come soleva dire Flaminio Piccoli, un altro democristiano che se ne intendeva, avevano ciascuna una vita e caratteristica ma in comune una cosa: si sapeva come cominciavano, mai o quasi mai come sarebbero finite, con o senza lo zampino che poteva metterci il Quirinale. Che era imprevedibile già ai tempi di Luigi Einaudi, spintosi nell’estate del 1953 a spiazzare la Dc, divisa nella lotta per la successione ad Alcide De Gasperi, con la formazione di un governo di Giuseppe Pella subito degradato dai vertici del partito a “governo amico”. Esso durò non a caso solo cinque mesi, per quanto intensissimi di fatti ed emozioni: a cominciare dallo schieramento delle truppe sul fronte orientale per accelerare la restituzione di Trieste all’Italia dopo la gestione internazionale seguita alla seconda guerra mondiale. Pella ne uscì con una popolarità per niente intaccata dalle proteste di una sinistra comunista in qualche modo ammiccante con Tito e le sue aspirazioni annessionistiche.
Quanto o ancora più ostico del termine “verifica” è per Conte e per i grillini, fra i quali tuttavia si colgono qua e là segni di interesse, il termine “rimpasto”, anch’esso da Prima Repubblica ma affacciatosi ripetutamente al dibattito politico negli ultimi tempi, pure stavolta per iniziativa soprattutto del Pd. Dove sono notoriamente confluiti non a caso i resti o gli eredi dei due maggiori partiti della Prima Repubblica, sempre al maiuscolo per favore.
Infastidito più del solito dalle voci, allusioni e sollecitazioni esplicite per un rimaneggiamento della compagine ministeriale, spostando ministri da un dicastero all’altro o sostituendone alcuni con altri di prima nomina, o di ritorno, allo scopo di rafforzare e ricalibrare la struttura governativa e usare al meglio le varie competenze di fronte alle nuove necessità imposte dall’emergenza virale, una volta Conte si è spinto, forse un po’ troppo imprudentemente, a dire che nessun partito della coalizione gli aveva chiesto un rimpasto. Anzi, si spinse ancora più avanti attribuendo l’operazione all’”agenda” non sua ma “dei giornalisti” inclini più ai retroscena che alle scene, più alla fantasia che alla realtà, più alle manovre che alle notizie, e incapaci di vivere e scrivere serenamente astenendosi a lungo dalla pratica del totoministri. Che notoriamente fomenta anziché sopire le ambizioni degli insoddisfatti di turno.
Certo, sarà difficile che si ripeta in questa Terza Repubblica il miracolo, o la stranezza, del rimpasto del 1977 attuato dall’allora presidente del Consiglio Andreotti dimissionando l’amico ministro della Difesa Vito Lattanzio, che si era fatto scappare una notte dall’ospedale militare del Celio, nascosto addirittura in una valigia, il generale nazista Herbert Kappler, ma dandogli in cambio non uno bensì -allora- due Ministeri: Trasporti e Marina Mercantile.
Eppure, a questo rimpasto edizione 2020, o 2021, viste anche le risse esplose con le ultime misure antivirali, ho la sensazione modestissima, da vecchio cronista politico come mi sento, senz’altri fronzoli o gradi capitatimi addosso in circa 60 anni di mestiere, che si arriverà, come alla verifica e a tutte le altre diavolerie quali erano considerate sino a qualche tempo fa quelle della Prima Repubblica. Vi si arriverà specie se gli interessati vorranno veramente evitare il rischio più grande di tutti che rimane una crisi di governo vera e propria, improvvisa e devastante come un temporale.
Serpeggia fra cronache e retroscena anche il ritorno di un’altra immagine o imprecazione degli anni della Prima Repubblica: quella del “destino cinico e baro” lamentato nel 1953 dal leader socialdemocratico Giuseppe Saragat per commentare il risultato di un passaggio elettorale avaro per il suo partito, da lui coraggiosamente e atlanticamente fondato nel 1947 a Palazzo Barberini uscendo da quello di Pietro Nenni. Che andava legandosi mani e piedi al Pci di Palmiro Togliatti nella vana speranza di vincere col “fronte popolare”, arricchito dell’immagine addirittura del compianto e incolpevole Giuseppe Garibaldi, le elezioni politiche dell’anno dopo.
Ha appena rispolverato le parole del destino cinico e baro Augusto Minzolini sul Giornale della famiglia Berlusconi per commentare, fra l’altro, il calo in corso del gradimento di Giuseppe Conte nei sondaggi. Ma, a rifletterci bene o meglio, potrebbero lamentarsi del destino beffardo anche i grillini, con l’emorragia di voti in corso da quasi un anno e mezzo, pur se rallentato ultimamente secondo i calcoli del presidente pentastellato della Camera Roberto Fico, i leghisti di Matteo Salvini, scesi di una decina di punti rispetto al boom di fine maggio del 2019, e di Forza Italia del Cavaliere, ormai ridotta a una sola cifra e decimali dalle vette del 1994.
Ciò che mi preoccupa, o inquieta, ben oltre quindi la curiosità di un cronista, è il fatto che si torna ai termini, alle parole e persino ai tempi e forse anche alla legge elettorale proporzionale della Prima Repubblica – vi prego sempre, con le maiuscole- senza averne più i partiti, di massa e non, e gli uomini. E’ un bel guaio, senza offesa, almeno in parte, per quanti ne hanno preso il posto.