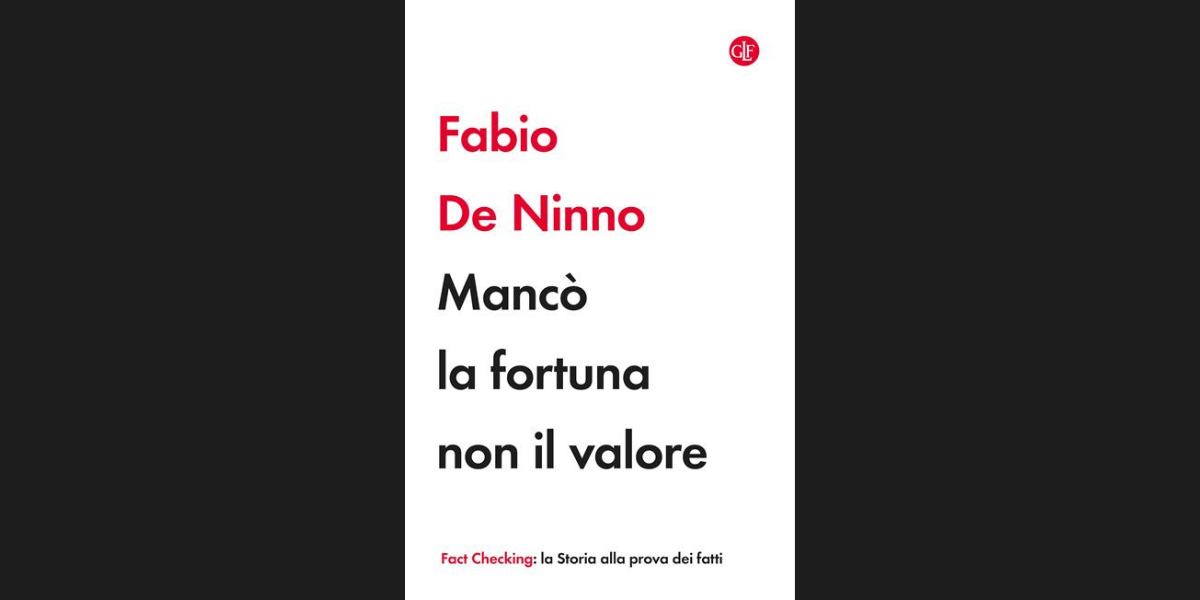A fine gennaio il Senato ha approvato, in prima lettura, la riforma dell’autonomia differenziata. Il testo, passato con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 30 astenuti dovrà essere votato dalla Camera. Se approvato (il governo si augura entro il prossimo giugno, prima delle elezioni europee) la riforma andrà a completare il percorso di devoluzione delle competenze legislative verso le regioni, già iniziato con la riforma del Titolo V del 2001, approvata con una maggioranza di centrosinistra e poi confermata da referendum (33,9% di votanti, 64% di favorevoli e 36% di contrari).
Tutto liscio? Non proprio. Sono diverse le voci discordanti circa l’introduzione della nuova riforma. Le preoccupazioni riguardano soprattutto i rischi legati all’unità nazionale e all’uniformità delle prestazioni garantite su tutto il territorio nazionale.
Start Magazine ha sentito Gianfranco Viesti, docente di Economia applicata presso il dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari, che nel libro “Contro la secessione dei ricchi. Autonomie regionali e unità nazionale” (ed. Laterza) ha passato in rassegna dubbi e problematiche relative al regionalismo italiano.
Prof, lei ha intitolato il suo libro “Contro la secessione dei ricchi”. Perché parla di secessione?
Certo, è spiegato nella prima pagina del libro. Le specifiche richieste che sono state avanzate dalla Lombardia, dal Veneto e, in larga misura, anche dall’Emilia Romagna, hanno due caratteristiche. La prima è portare talmente tanti poteri e competenze a livello regionale da determinare vere e proprie regioni-Stato che non esistono in nessuna parte del mondo. Quindi è un processo, se non formalmente, sostanzialmente secessionista, perché farebbe nascere con il tempo in Italia delle regioni largamente indipendenti nella determinazione di quasi tutte le principali politiche pubbliche. Inoltre, essendo queste le tre regioni più forti del paese è una secessione dei ricchi.
E la seconda caratteristica?
La seconda caratteristica risiede nel fatto che da sempre nelle richieste di Lombardia e Veneto, in maniera più esplicita, c’è l’idea che dato che i loro cittadini pagano più tasse, devono avere più servizi. Quindi questo rompe l’unità sostanziale della Repubblica perché tratta gli italiani in maniera diversa, a seconda del luogo in cui vivono. Quindi è la secessione dei ricchi perché è a vantaggio dei cittadini che vivono nelle regioni più ricche
Quindi l’aumento dei poteri delle regioni, perseguito dai fautori dell’autonomia differenziata, andrebbe a detrimento dell’unità nazionale?
Diciamo così, si parla tanto dei Lep, che sono dettagli, e non si parla mai dell’aspetto principale, cioè delle richieste da parte delle regioni. Le richieste da parte delle regioni sono, a mio avviso, totalmente inaccettabili.
Perché sono inaccettabili?
Perché le regioni hanno chiesto, sostanzialmente, tutte le competenze teoricamente previste dalla Costituzione, quindi scuola, sanità, infrastrutture, energia, ambiente, cultura e via discorrendo. La concessione di questi poteri alle prime regioni che li chiedono, e poi anche alle altre, creerebbe un paese Arlecchino nel quale il governo nazionale non si sa più in cosa ha competenza e ciascuna regione organizza le infrastrutture o la sanità come meglio crede.
Oltre ad accrescere le diverse velocità tra le regioni?
Il trasferimento di questi enormi poteri alle regioni secondo me riduce la velocità di crescita dell’Italia, perché un trasferimento di questo genere è assolutamente inefficiente: sono materie che sarebbe molto più opportuno che fossero gestite a livello nazionale. Non solo, un passaggio di competenze così esteso a regioni così grandi, e poi via via tutte le altre, ridurrebbe enormemente la dimensione del bilancio nazionale. Quindi il ministro dell’Economia avrebbe problemi sia a gestire il debito pubblico sia a disegnare le politiche che normalmente uno Stato nazionale fa. Quindi il punto di fondo decisivo è che l’autonomia differenziata non è un problema dei meridionali, ma è un problema degli italiani.
Sono diversi i settori in cui i Lep non sono stati definiti, dai servizi sociali al trasporto locale, e questo prescinde dall’introduzione della riforma dell’autonomia differenziata. Perché viviamo questo ritardo?
I settori in cui mancano sono l’assoluta maggioranza. E non sono stati definiti per un chiaro ritardo, un disinteresse della politica. Sono 23 anni che la Costituzione prevede la loro definizione, il loro raggiungimento, ma si è fatto poco e niente. Questo dipende, a mio avviso, da una grave sottovalutazione politica del tema dell’uguaglianza tra i cittadini nel nostro paese, perché le condizioni dei luoghi in cui si vive sono una determinante importantissima delle disparità che subiscono i cittadini nella loro vita normale.
Quali sono gli ambiti nei quali c’è un deficit maggiore nella determinazione dei Lep?
Nella determinazione il deficit è quasi in tutti, sono molto pochi quelli in cui sono stati operativamente definiti e soprattutto collegati al finanziamento. Il caso più rilevante degli ultimi tempi è quello degli asili nido, per i quali non solo è stato stabilito un Lep comunale ma sono state stanziate le risorse per raggiungerlo nel 2027. Il caso della sanità è molto interessante perché esistono i cosiddetti Lea (Livelli essenziali di assistenza) che sono sostanzialmente dei Lep, ma sono totalmente scollegati dai meccanismi finanziari, perciò chi non li raggiunge si arrangia, non ha risorse aggiuntive per poterli raggiungere.
Perché i Lep sono centrali nella riforma dell’autonomia differenziata?
Perché servono a tentare di convincere i cittadini del Sud che l’autonomia differenziata non è contro di loro, sono una grande operazione di comunicazione operata dal governo per provare a sostenere la tesi che l’autonomia differenziata è come una grande magia, che fa bene a tutti e migliora le condizioni al Nord e Sud. Il che è impossibile. I Lep sono Importanti per l’aspetto di confronto politico e di comunicazione; infatti, si parla solo dei Lep che sono il pezzo dell’autonomia differenziata relativamente meno importante. Perché la legge prevede chiaramente che saranno esclusivamente definiti, e chissà come e per quali ambiti, e non ci sono le risorse per finanziarli. Dunque, è un’operazione di comunicazione.
Tra tutti questi aspetti che lei ha elencato quali sono quelli che la preoccupano di più?
Mi preoccupa ciò che è già successo, cioè che il Parlamento si sta spogliando del suo potere. Nel senso che questa legge formalmente non serve a niente, perché le intese fra lo Stato e le regioni possono essere tranquillamente sottoscritte senza questa legge. Allora perché è stata fatta la legge? Per portare tutti i poteri in materia alla Presidenza del Consiglio e impedire al Parlamento di entrare nel merito delle richieste, e quindi di fare quello che sarebbe assolutamente indispensabile fare cioè una discussione parlamentare punto per punto, richiesta per richiesta, per capirne di più. Questo mi preoccupa moltissimo perché la materia è diventata esclusivamente questione di scambio politico interno della maggioranza e non questione di assetti di governo del Paese.