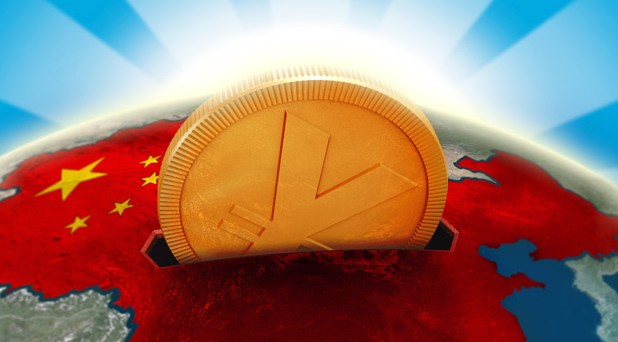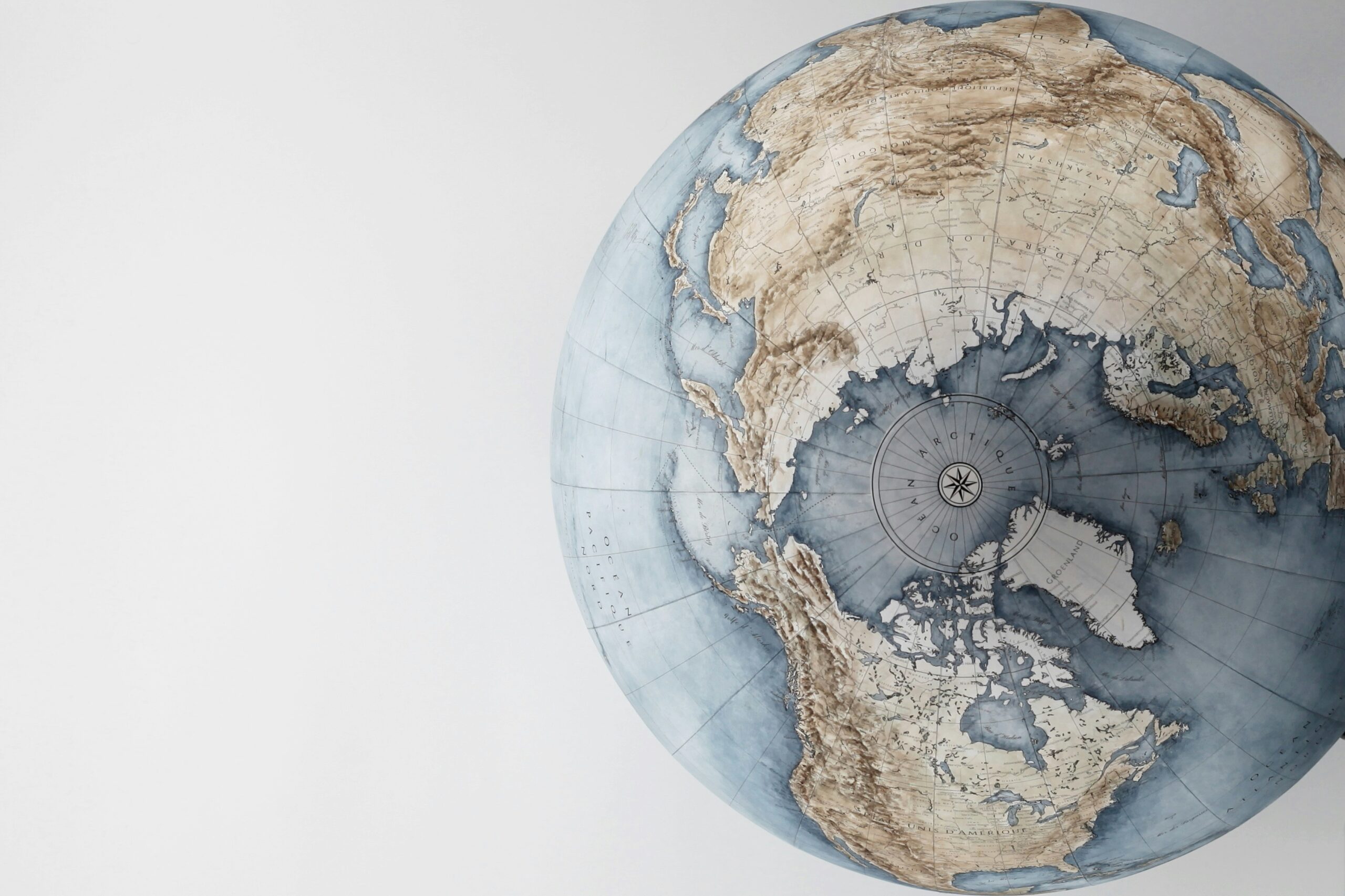Anche la Cina sembra orientarsi verso l’uso della combinazione: bastone-carota.
Il 19 settembre scorso il ministero del Commercio Cinese (MOFCOM) ha emesso un’ordinanza relativa ad un elenco di entità da ritenersi inaffidabili “The Unreliable Entity List” (UEL). In base alla quale la Cina adotterà misure in risposta alle seguenti azioni, intraprese da un’entità straniera in attività economiche e commerciali internazionali (ed a quelle connesse):
- mettere in pericolo la sovranità nazionale, la sicurezza o gli interessi di sviluppo dello stato cinese;
- sospendere normali transazioni in corso con un’impresa, altra organizzazione o individuo cinese, ovvero applicare misure discriminatorie nei confronti di un’impresa, altra organizzazione o individuo cinese, in violazione di “normal market transaction principles”, e con la conseguenza di gravi danni ai legittimi diritti e interessi di un’ impresa, od altra organizzazione o individuo cinese.
In tali disposizioni, il termine “entità estera” si riferisce genericamente a un’impresa, altra organizzazione o individuo di un paese straniero.
L’articolo 6 di tale ordinanza dispone che l’apposito comitato, richiesto di indagare sulle azioni di un’entità straniera, una volta compiuta l’indagine si confronti in possibile contraddittorio con questa ultima, che dovrà difendersi e giustificarsi. Con il risultato di sospendere o chiudere l’indagine, ma anche di riaprirla se i fatti su cui si era basata la decisione di sospensione risultassero sostanzialmente cambiati. Ai fini di tale inclusione è previsto che l’apposito comitato debba valutare: 1) il grado di pericolo causato alla sovranità nazionale, alla sicurezza o agli interessi per lo sviluppo della nazione; 2) l’entità del danno ai diritti e agli interessi legittimi di imprese, o di altre organizzazioni o persone fisiche cinesi.
All’annuncio dell’inclusione nella UEL dell’entità estera potrà essere fatta seguire segnalazione pubblica dei rischi connessi al condurre transazioni con essa. Di seguito il dettaglio delle misure restrittive e sanzionatorie conseguenti all’inserimento: a) limitare o vietare all’entità straniera di impegnarsi in attività di importazione o esportazione legate alla Cina; b) limitare o vietare all’entità estera di investire in Cina; c) limitare o vietare l’ingresso in Cina al personale o ai mezzi di trasporto della società estera; d) limitare o revocare il permesso di lavoro del personale interessato, il loro stato di soggiorno o di residenza in Cina; e) imporre un’ammenda di importo congruo con la gravità dei capi di imputazione; f) altre misure che si rendessero necessarie.
Stante la novità di tali norme, non risulta che ne sia già stata fatta applicazione. Ma è decisamente opportuno monitorarne gli sviluppi, dato il potenziale ritorsivo ancora incognito che potrebbe interessare in particolare multinazionali o corporations operanti anche in paesi diversi dalla Cina, con i quali Pechino intrattiene da tempo importanti relazioni economico-finanziarie.
Vi è comunque da considerare che Pechino aveva annunciato per la prima volta l’intenzione di istituire una lista di Unreliable Entities già nel maggio del 2019, al culmine della ben nota controversia commerciale. Per tali motivi essa appare ora come una risposta diretta alle crescenti tensioni nelle relazioni con Washington, ancorché mascherata dalla genericità definitoria dei soggetti esteri imputabili. E in tal modo anche interpretabile come la reazione all’intensificarsi dei tentativi di alleanza anti-Cina condotti dalla diplomazia statunitense. Si considerino al riguardo l’impatto geopolitico delle manifestazioni pro-autonomia di Hong Kong, il dibattito sui diritti umani nello Xinjiang, gli ordini presidenziali concernenti i ban tecnologici (5G, TikTok e altri).
La minaccia di ritorsioni cinesi era già rilevabile nel recente passato, e riferita – ad esempio – alle linee aeree che segnalavano la destinazione di Taipei come relativa ad un paese diverso dalla Cina, o ad aziende della industria della difesa per il loro export verso Taiwan.
Ma la minaccia della lista UEL è più pesante, non solo per il suo peculiare carattere di extraterritorialità, ma soprattutto per la vaghezza contenutistica dei potenziali capi di imputazione. Sarebbe infatti molto utile sapere sin d’ora se il comitato di valutazione assimili a violazione della sovranità statale circostanze quali il rispetto delle sanzioni statunitensi (ad esempio, la sospensione di un contratto con una controparte cinese colpita da sanzione Usa), ovvero opposizioni/ controlli su esportazioni cinesi passibili dell’accusa di dumping, ecc. Tanto da rendere doveroso, più che opportuno, seguire da vicino come Pechino svolgerà le indagini e chi e per quali motivi verrà inserito nella UEL.
Sul piano dell’immediatezza delle reazioni a valenza geopolitica, si dovrebbero, però, interpretare la lista UEL – e la vaghezza terminologica della relativa ordinanza – come uno strumento mirato a non essere utilizzato in questo ultimo scorcio di tempo prima delle elezioni presidenziali Usa, perché sortirebbe effetti pro-Trump. Mentre potrebbero essere considerate oggetto di negoziazione geopolitica e geoeconomica la loro flessibilità attuativa (si consideri la fase 1 della guerra commerciale ed economica ancora non conclusa), nell’ipotesi in cui la Casa Bianca venisse occupata da un diverso presidente.
Ma, a tanto zelo a difesa degli interessi nazionali, fa da contraltare quello della tutela delle esigenze degli investitori esteri, in relazione ai quali la Cina ha aggiornato negli ultimi anni la relative leggi. Come noto, il 15 marzo 2019 il Congresso nazionale del popolo aveva adottato la nuova legge sugli investimenti esteri (Foreign Investment Law – FIL), entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Innovativa per molti aspetti, e che stabilisce, tra l’altro:
- che gli investitori esteri saranno trattati non meno favorevolmente degli investitori nazionali nella fase di accesso agli investimenti tranne, che nelle aree specificate nella apposita (Market Access Negative List), “lista di accesso negato” al mercato cinese; (art 4)
- che è garantito il diritto delle imprese a capitale estero di presentare offerte per progetti di appalti pubblici; (art 16)
- che le società estere possono emettere azioni, obbligazioni o altri strumenti per finanziare le loro operazioni; (art 17)
- che è vietato a qualsiasi agenzia amministrativa, o al suo personale, di forzare il trasferimento tecnologico da parte di società straniere che operano in Cina. (art 22)
All’articolo 26 tale legge sanciva inoltre l’operatività di meccanismi di reclamo per gli investitori esteri, senza chiarirne però il funzionamento. Carenza cui ha pienamente sopperito il citato ministero del commercio (MOFCOM) il 25 agosto scorso, modificando ed ampliando le misure sulla gestione dei reclami delle società (FIE), quelle costituite in base alle legge vigenti in Cina ed entro il territorio della Repubblica Popolare Cinese, il cui capitale sociale è interamente o parzialmente straniero.
Le misure sui reclami in tal modo riviste – ed entrate in vigore il 1 ° ottobre 2020 – mirano a consentire una migliore e più amplia gestione dei reclami da parte degli investitori esteri in Cina per azioni amministrative inerenti la violazione di loro diritti od interessi legittimi. Ora anche le Camere di commercio possono effettuare segnalazioni alle agenzie di gestione dei reclami, riguardanti il complesso ambientale nel quale viene realizzato l’investimento.
Con tali linee-guida ministeriali sono state inoltre previste regole chiare su come un reclamo debba essere presentato, accettato e seguito, ed i limiti di tempo e le modalità per un riesame amministrativo su qualsiasi decisione. Le agenzie che trattano i reclami sono inoltre tenute ad adottare misure efficaci per proteggere i segreti commerciali dei denuncianti, le informazioni commerciali riservate e la privacy personale. Mentre qualsiasi persona fisica o giuridica dovrà astenersi da ritorsioni contro coloro che abbiano presentato le lamentele.