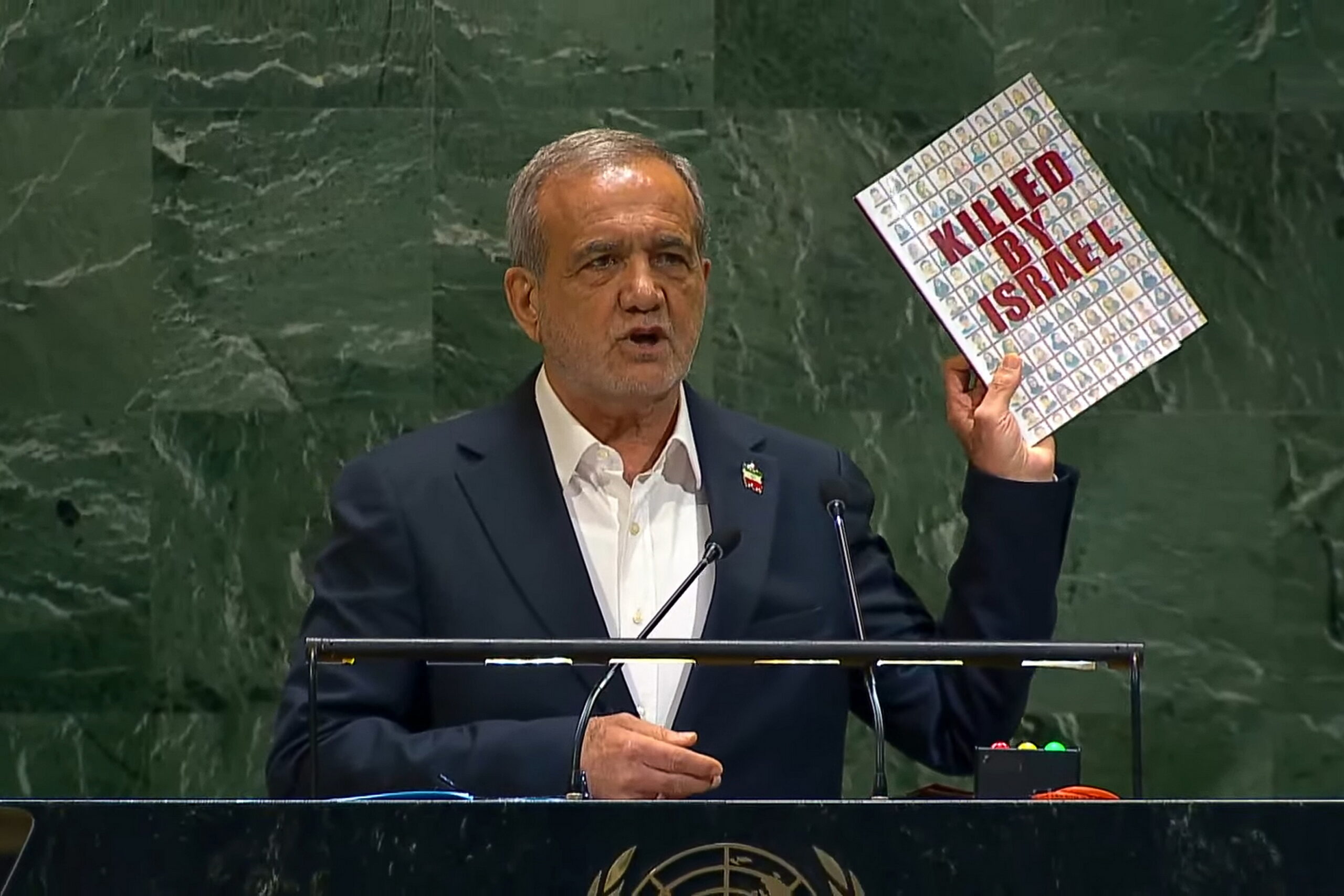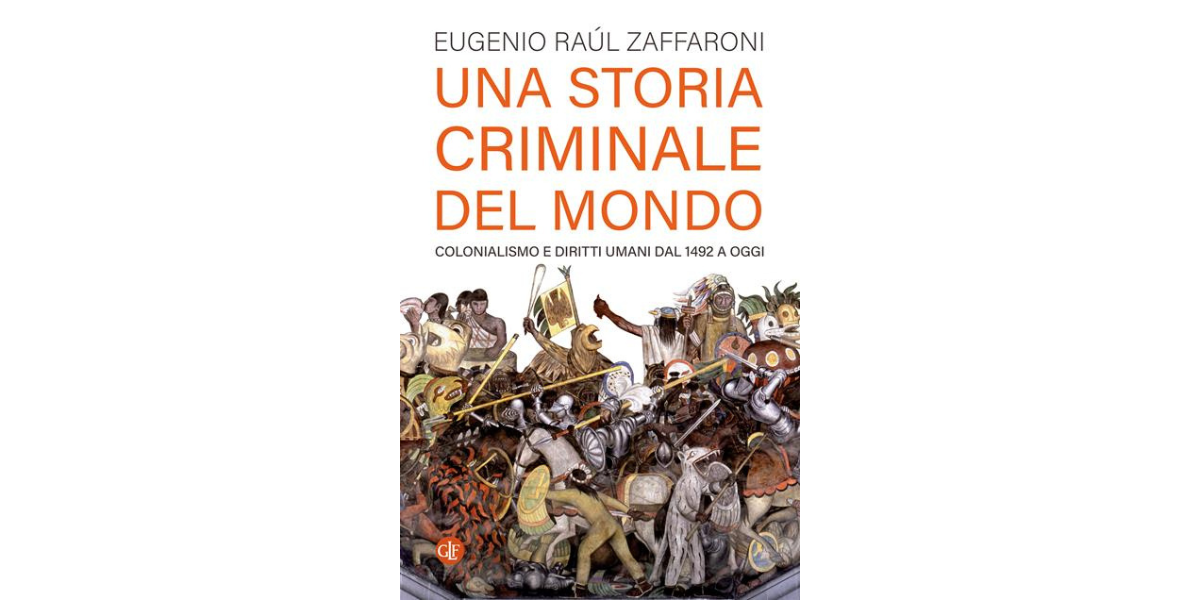Il Mediterraneo dei tedeschi dell’est era una lunga e stretta lingua d’acqua, piatta e tiepida, sprofondata nel mezzo del bassopiano pannonico. Il profumo intenso delle spighe di grano inebriava di odori meridionali, le forme rotonde dei “langos” fritti richiamavano l’illusione della pizza napoletana e l’aria dolce e rilassata cullava vacanze esotiche ai tempi del socialismo reale. Il lago Balaton era il Mezzogiorno dei tedeschi dell’est, uno spicchio di Italia trapiantato trecento chilometri più a oriente, in Ungheria, dove l’esperimento del socialismo alla paprika prometteva estati piccanti, impensabili dalle parti di Lipsia o Rostock.
Era la riviera degli Ossis, l’agognata meta delle vacanze dell’est. Tra luglio e agosto, una lunga colonna di Trabant si metteva in cammino verso sud, lungo quella che veniva chiamata la strada del sole, la Sonnenstrasse, un nome non ufficiale che evocava la nuova autostrada nord-sud da poco costruita in Italia. Da Stralsund o Berlino Est, da Dresda o Erfurt, le piccole ma resistenti auto fabbricate a Zwickau sfrecciava verso i campeggi pannonici, quasi sempre con una tappa intermedia a Praga, come testimoniano centinaia di foto e filmini d’epoca.
Per i cittadini della Ddr di Ulbricht e Honecker l’Ungheria era l’unico meridione possibile. Il revisionismo cocciuto di Tito aveva reso politicamente scorrette le vacanze sulle coste dalmate e istriane della Jugoslavia, là dove c’era il mare vero, quello salato, e alla stessa latitudine dell’Italia, appena sull’altra sponda dell’Adriatico. Più prudente quindi fermarsi un po’ più a nord, sulle sponde di questo specchio d’acqua dolce verticale, chiamato in patria il mare ungherese.
Nel tempo diventò anche il luogo d’incontro di un popolo che era stato diviso da muri e cortine di ferro. I tedeschi dell’ovest erano in realtà liberi di incamminarsi verso destinazioni più allettanti. E infatti dalla fine degli anni Cinquanta, a bordo delle prime Volskwagen targate miracolo economico, iniziarono a sciamare lungo l’Adriatico italiano, da Lignano a Grado e più giù fino a Rimini, la riviera delle bionde, la Teutonengrill, file senza interruzioni di sdraio su cui i tedeschi si arrostivano al solleone. I più sofisticati raggiungevano i luoghi mondani della Costa Azzurra o dell’Atlantico francese.
Ma chi aveva lasciato amici e parenti dall’altra parte della cortina di ferro non aveva altra scelta che ripiegare sul Balaton. È stato il buen retiro delle due Germanie ai tempi della Guerra fredda, il punto d’incontro di famiglie cui la storia aveva spezzato legami e affetti, abitudini e quotidianità. Divisi in patria, riuniti all’estero, seppur per il tempo breve di una vacanza estiva. E con la Stasi alle calcagna, in servizio effettivo permanente anche in trasferta.
Oggi che il turismo dei voli low-cost rende accessibili a tanti mète esotiche per davvero, il Balaton appassisce nella sua atmosfera malinconica. Percorri la moderna E71 che lo collega in poco più di un’ora a Budapest, un’infrastruttura che trent’anni fa prometteva un radioso futuro turistico al tempo del capitalismo, e scopri che le auto passano oltre, senza più fermarsi sui bordi del lago. Mezza Europa dell’est utilizza questa autostrada per arrivare più in fretta a Spalato e Makarska, in Croazia, o sulle spiagge del Montenegro e d’Albania, le nuove mecche della vacanza di tendenza: è lì che spiaggiano polacchi e cechi, baltici e slovacchi.
Il Balaton è diventato démodé, un catalogo di viaggi vintage che ingiallisce col passare del tempo. Gli alberghi alveare tirati su ai tempi delle vacche grasse, che qui sorprendentemente coincidono con i tempi del socialismo, si sono desolatamente svuotati.
Eppure, fino a trent’anni fa, i turisti arrivavano a decine di migliaia, come stormi di uccelli migratori alla ricerca del caldo, del sole e degli affetti perduti. I tedeschi soprattutto, da Dresda e da Monaco, da est e da ovest, ma anche i cecoslovacchi e gli italiani, i polacchi e gli olandesi. Curiosi di ritrovarsi al riparo di una terra che, oltre al languore estivo, offriva la sensazione di una relativa libertà.
Gente tosta, gli ungheresi, orgogliosa e testarda, che si era guadagnata i galloni di popolo ribelle nella rivoluzione del 1956: i carri armati sovietici avevano ristabilito l’ordine ma qualcosa di quello spirito insubordinato si rifletteva ancora nel carattere degli uomini e nella gradazione del vino rosso. Per chi era abituato al cupo grigiore di Berlino Est e poteva sfuggire alle vacanze di rito nelle colonie del Brandeburgo o del freddo Baltico, il richiamo dei caffè all’aperto, delle nenie dei violini gitani, dei sapori forti della paprika o delle frescure delle angurie rosse appariva irresistibile. Una scorta di buon umore e sorrisi da consumare lentamente nel letargo invernale della Ddr. E poi gli incontri con i fratelli separati dell’ovest, alla luce del sole, senza troppi timori di sguardi sospettosi o punizioni.
(1.continua)