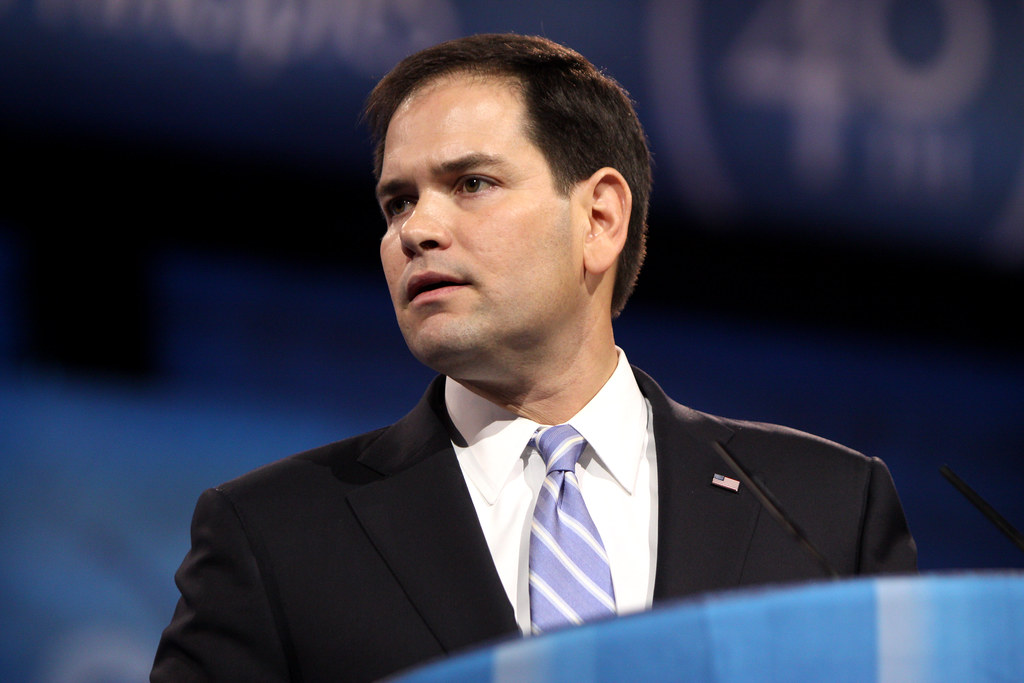Caro direttore,
ci sono molti modi per definire l’intervento di Donald Trump del 23 settembre scorso al Palazzo delle Nazioni Unite. Se si decide restare aderenti all’orientamento del mainstream occidentale, e magari di indulgere in una più o meno giustificata “Trumpofobia”, ci si può sbizzarrire, definendolo: uno sproloquio che non finiva mai, una caricaturale apologia del suo governo e del suo Paese che starebbe attraversando, ora che c’è lui alla Casa Bianca, una golden age, una scriteriata e oltraggiosa descrizione dell’Europa e della sua élite che starebbe conducendo alla rovina i popoli del Vecchio Continente, un linguaggio da balera poco consono sia al suo ruolo di presidente del Paese più ricco e potente del mondo, culla della democrazia, sia al livello del suo pubblico (nella specifica occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i principali leader politici mondiali accompagnati dalla crème de la crème della diplomazia) e, infine, l’accusa capitale, dacché lì sono in gioco gli ingenti capitali che i contribuenti dei paesi occidentali elargiscono all’universo green: il “negazionismo climatico”. Oppure, si potrebbe cercare di capire e spiegare moventi e finalità di un atto oggettivamente politico che – qualunque cosa se ne pensi – non potrà restare senza conseguenze.
Quello che mi è sembrata un po’ singolare è il commento vergato a caldo e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispi. Anzitutto ne trascrivo due passaggi e poi cercherò di spiegare, direttore, perché, sia per la sede – il più importante think tank di geopolitica italiano e uno dei primi a livello mondiale – sia per la firma, quella dell’autorevole professor Mario Del Pero, ordinario alla grande école parigina di Sciences-Po, mi è parso singolare. “Un discorso, quello di Donald Trump all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggettivamente imbarazzante, nei toni e nei contenuti”. Così esordisce il professor Del Pero. E prosegue: “Oggi, ulteriormente radicalizzato, (Trump, ndr) attacca l’Onu in modo ancor più aspro e diretto. Un attacco, questo, funzionale a una narrazione neo-imperiale”.
Capisco che concentrare un giudizio su temi di questa portata in sette righe sia una sfida, soprattutto per un accademico, ma forse sarebbe preferibile lasciare questo genere di sfide ai giornalisti, che per mestiere “spiegano agli altri le cose che non hanno capito” (come Indro Montanelli scrisse di sé, non senza civetteria, sulla propria immaginata lapide). Quando le cose si conoscono e si capiscono – e questo è sicuramente il caso del professor Del Pero – meglio sarebbe astenersi. Provo a spiegarmi, direttore. “Imbarazzante”? Per chi? Di certo non per l’autore del discorso, sicuramente immune da queste “debolezze”. Ancora meno per la frazione progressista dell’Assemblea che manifesta quotidianamente, sui maggiori media del mondo avversione, disprezzo e scherno nei confronti dell’attuale presidente degli Stati Uniti d’America (Potus, con l’orrenda sigla dettata dalla mania americana per gli acronimi) e che non può certo aspettarsi carinerie da un personaggio, già di suo, poco incline alle buone maniere. “Ulteriormente radicalizzato”? Ma da chi, essendo chiaramente Trump il “radicalizzatore” o “radicalizzante” in capo? Quanto alla “narrazione neo-imperiale” avrei bisogno a mia volta di molto più spazio per affrontare questo aspetto. Dico solo che a mio umile parere è improprio parlare di “narrazione” nel caso di Trump che – magari confondendo l’interesse della patria col proprio, com’è d’uso nei regimi imperiali – sta imponendo anzitutto alle strutture della amministrazione Usa ma anche al resto del mondo un modus operandi che ritiene più coerente con il peso del potere degli Stati uniti nell’arena mondiale. E sarei disposto a scommettere che, se funzionerà ancora l’alternanza e fra tre anni torneranno al potere i democratici, si guarderanno dal fare marcia indietro su questo aspetto della presidenza Trump, a vantaggio di un “multilateralismo” che era la faccia benevola della “fine della storia” prodotta dalla dissoluzione dell’Unione sovietica.
Ma voglio essere sincero fino in fondo, direttore. Quel che mi ha un po’ disturbato del commento, così “giornalistico”, del professor Del Pero, è il fatto di leggerlo sotto l’insegna di Ispi, un’istituzione alla quale sono legato da un sentimento che rasenta l’affetto. Mio padre, classe ’99, a vent’anni si era trapiantato da Atene a Milano, dove aveva costruito la sua professione di commerciante e aveva messo su famiglia. Il 28 ottobre 1940 era diventato improvvisamente cittadino di un paese nemico, come tale acutamente interessato a restare informato sullo svolgimento del conflitto, ciò che – come vediamo ancora oggi – è virtualmente impossibile quando anche gli organi d’informazione subiscono una sorta di chiamata alle armi. Mi raccontava mio padre che, per informarsi, aveva scelto di leggere regolarmente un settimanale, Relazioni Internazionali, pubblicato dall’Istituto di Studi Politici Internazionali fondato negli anni Trenta da Alberto Pirelli, Ispi appunto.
Negli anni del dopoguerra, della pace “garantita” anche dalla Guerra Fredda, dell’ingresso a vele spiegate, anche del nostro Paese, nella civiltà dei consumi, Ispi era declinato fino a rischiare l’estinzione finché, pochi decenni fa, accadde che l’Università Bocconi, sotto la gestione economica di Giovanni Pavese, decidesse di investire in una istituzione ancora rispettata benché entrata nel cono d’ombra, e di affidare a un giovane docente, Paolo Magri, la missione quasi impossibile del rilancio, con pochissimi mezzi ma una sede e una tradizione prestigiosa e pochi ricercatori e studiosi qualificati e appassionati. Magri riuscì, rivelando anche insospettate doti “imprenditoriali”, nell’impresa fino a riportare Ispi nel gruppo ristretto dei grandi think tank del livello, per intenderci, di Chatham House. Ma si sa che quando un’impresa assume una dimensione economica significativa deve funzionare come il ciclista, pedalare oppure cadere per terra. Quindi assoggettarsi alla dura legge della “visibilità”, del continuo allargamento della rete, insomma della crescita. Ciò che significa sempre, in una certa misura, “omologarsi”. Rincorrere l’attualità invece di limitarsi a distillarne il significato. Intervenire sempre e comunque “in tempo reale”. Adeguare il proprio linguaggio ai tic del momento. E così via. Tutto molto ragionevole e comprensibile, forse inevitabile.
Ma rimane un vuoto.