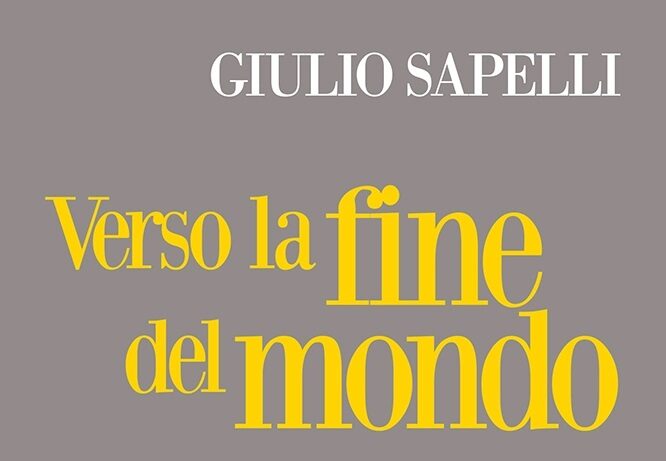Il saggio che Giulio Sapelli mi chiede di introdurre non si propone un’analisi lineare dell’argomento un po’ apocalittico che si vuole affrontare (si va o no verso la fine del mondo?) bensì regala un viaggio tra idee, suggerimenti, incisive e rapide descrizioni storiche che accompagnano il tema centrale del libro.
Come ho già detto in tante altre occasioni, quelle che il mio storico preferito attraversa non sono mai acque calme e ferme sulle quali navigare tranquillamente, quanto piuttosto un fiume impetuoso da setacciare con continuità, imbarcati su un quasi rimbaudiano bateau ivre, pronti a raccogliere lungo il percorso decine di pepite preziose: chi altro, a parte l’autore di questo viaggio «alla fine del mondo» di cui scriviamo, vi potrebbe offrire una «pepita» come il paragone che apre il libro, centrato sull’analogia tra l’Anabasi di Senofonte e la politica del Dipartimento di Stato americano? Dove potreste leggere un’analisi, impreziosita da una meravigliosa digressione sul porto di Haifa, del progetto di collegamento indiani-sauditi-israeliani ed europei (la cosiddetta via del cotone) che scatena la reazione iranian-cinese via Hamas per bloccarlo?
In tempi nei quali eurofanatici ed euroscettici abbondano di retorica ma scarseggiano nell’analisi, una descrizione rapida e sintetica dell’Europa che ci hanno consegnato Alexandre Kojève e Jean Monnet. I deliri tardo-imperialistici di Vladimir Putin, richiamandone le radici nella stagione di Caterina la Grande. Una insight sul dibattito giapponese tra maggior integrazione con l’iniziativa american-indopacifica e ripresa di autonomia di Tokyo. Il mondo dal punto di vista dell’Australia e della Nuova Zelanda. Le parole del ministro degli Esteri indiano sul ruolo del proprio Paese. Un invito a leggere «Il grande capolavoro di Étienne Balazs (La burocrazia celeste, Le due rose editore, Milano 2021)» per capire come funzioni l’Unione Europea. Le istituzioni sovranazionali e «l’erompere delle ‘Autorità Indipendenti’ così come Alberto Predieri (A. Predieri, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, Passigli, Firenze 1997) definì l’alba del tristo tempo in cui oggi viviamo». Il ruolo che hanno i quadri che escono dalla Federazione giovanile comunista cinese. La strage di Monaco del 1972 per capire quella di Hamas del 7 ottobre, paragonata poi, per i suoi possibili effetti, all’attentato all’arciduca erede al trono d’Austria-Ungheria Francesco Ferdinando a Sarajevo. Un grande finale centrato sulla moralità necessaria nell’analisi storico-politica e sul taglio tragico che un serio esame delle vicende attuali non può non avere.
Una lezione impreziosita da lunghe citazioni, tra gli altri, di Friedrich Meinecke, Blaise Pascal, Michel de Montaigne ed Ernesto De Martino. Queste sono solo alcune delle pepite che potrete raccogliere nel libro che mi è stato chiesto di introdurre. Ed è appunto con questo spirito da setacciatori d’oro non scoperto che vi dovete approcciare alla lettura del testo.
Verso la fine del mondo ha anche una trama che lega una pepita all’altra. Innanzitutto si considera che il mondo dei nostri giorni non può essere letto come un ritorno agli anni Venti e Trenta, con annesse argomentazioni su fascismi e deriva burocratica dell’Unione Sovietica. La fase della storia che stiamo vivendo è di fatto analoga a quella di fine Ottocento-inizi Novecento. Si agitano spiriti scatenati come ai tempi della Belle époque: da una parte nichilistici (non esiste la verità, non servono i valori morali), dall’altra positivistici (non serve la politica, non aiutano le riflessioni morali, bastano le competenze, basta la scienza, bastano i tecnici).
Circa centoventi anni fa la globalizzazione negli scambi commerciali raggiunse livelli analoghi agli attuali. In quel periodo la crisi dell’Impero ottomano preparò la crisi dell’Impero asburgico e di quello russo: con alcune simmetrie non distanti da realtà che caratterizzano i nostri giorni. L’Impero britannico considerò consolidata la sua egemonia sul mondo, e per un lungo periodo fu in differente alla crescita della nuova potenza prussiano-tedesca. Parte considerevole delle classi dirigenti di allora, pur accettando il sistema democratico (a lungo fondato peraltro su una base sociale assai ristretta), guardava con fastidio al crescere di movimenti popolari autonomi di orientamento socialista e laburista ma anche, in certi casi, in Italia e in parte in Francia, cattolici. Il proponimento dei più avvertiti uomini liberali di allargare le basi dello Stato veniva guardato con sospetto. I «populisti» di allora, i neri di Luigi Sturzo e i rossi di Filippo Turati, erano malvisti persino da giornalisti di qualità, peraltro perfetti interpreti degli orientamenti della borghesia industriale del Nord, come Luigi Albertini. In quel contesto, supponenza e astrattezza condite da volontà di potenza non imbrigliata dalla ragione fecero la loro prima vittima: la diplomazia.
La fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento furono caratterizzati dall’esaurirsi dei compromessi diplomatici, politicamente regolatori delle potenze europee, apprestati dal Congresso di Vienna. Un’intesa che consentì all’Europa quello che Karl Polanyi ha definito il secolo della pace (dal 1815 appunto al 1915). Alla guerra si arrivò da sonnambuli, considerandola al massimo un piccolo incidente, che re e imperatori, tutti cugini tra loro, avrebbero sbrigato rapidamente, magari disciplinando anche un po’ ceti popolari con troppe pretese.
Invece il macello del 1914-1918 (anche per quel tocco di follia militaristica tipica degli Juncker prussiani) provocò una catastrofe nel vecchio continente tale da segnare poi più o meno tutto il XX secolo: così la radicalizzazione di ampi settori dei ceti popolari, così lo sbandamento della migliore cultura scossa dalle stragi, così l’affermarsi di un socialismo militarizzato in una nazione centrale per gli equilibri europei come la Russia, così il decollo di tendenze controrivoluzionarie che alimentarono soluzioni autoritarie. Questa è la miscela nata nelle trincee di Francia, Italia, Germania, Russia, Polonia e così via, poi perfezionata dallo stolto revanscismo francese combinato con il fatale, svagato idealismo di un Thomas Woodrow Wilson alla ricerca di una pace perpetua «kantiana», e invece incubatore, con i suoi micronazionalismi, dei fattori decisivi per trasformare una delle ricorrenti crisi economiche del capitalismo nella catastrofe del 1929 con i suoi tragici esiti: innanzitutto il demoniaco regime hitleriano e poi l’altro macello del 1939-1945.
Solo un altro realistico accordo tra Stati, siglato nella Conferenza di Yalta, fece sì che la cosiddetta guerra civile europea si «raffreddasse» e consentisse lo straordinario sviluppo delle economie occidentali, e quello assai diverso delle nazioni incluse nell’impero sovietico.
A tutta questa vicenda il nostro autore fa riferimenti sottolineando quanto sia stata preziosa la funzione della diplomazia nel dopo-1945, e parallelamente esiziale la sua attuale crisi. Indicando poi anche le tendenze immediatamente successive alla guerra fredda, che da quell’epoca proseguono fino ai nostri giorni.
C’è innanzitutto la scommessa che fa Mosca sulla possibile cosiddetta finlandizzazione dell’Europa. Una scommessa incoraggiata dalla crisi di egemonia americana dopo la sconfitta nel Vietnam, le dimissioni di Richard Nixon e, più tardi, l’umiliazione di Jimmy Carter in Iran. La crescente egemonia sovietica in Africa, le aperture dell’Ost politik di Willy Brandt e del Vaticano, il colpo di Stato portoghese compiuto da militari filocomunisti, il dominio sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb, la superiorità militare dei missili sovietici SS20, fanno ritenere al Cremlino che una sorta di finlandizzazione del vecchio continente sia a portata di mano. Decisiva a bocciare questa prospettiva fu, in quel contesto, principalmente l’opposizione del nuovo cancelliere tedesco, il socialdemocratico Helmut Schmidt.
Ma sul quadro internazionale, poi, a dare scacco ai sovietici operarono due specifi che variabili. La prima fu quella cinese: alla fine degli anni Sessanta il delinearsi della sconfitta, più politica che militare, degli Stati Uniti in Vietnam spinse Pechino, invece che ad alimentare le rivoluzioni socialiste in Asia – come temeva il Dipartimento di Stato americano che considerava la perdita di Saigon come il primo passo per un’avanzata dei comunisti in Malesia –, a ricostruire i rapporti con Washington contro una Mosca con cui vi erano appena state abbastanza serie scaramucce in Siberia, lungo l’Ussuri. Questa svolta provocò la morte di un altro dirigente di primo piano del Partito comunista cinese: dopo aver liquidato l’ex presidente della Repubblica Liu Shaoqi (troppo filosovietico), Mao Tse Tung fece abbattere l’aereo del suo «numero due» in fuga verso la Siberia, Lin Piao, perché propugnatore dell’alleanza con i vietnamiti e di un rilancio della rivoluzione socialista in Asia.
La geografia prevalse sull’ideologia: la Cina popolare poteva permettersi una mezza nazione dai rapporti tradizionalmente difficili con i cinesi, filosovietica come la Corea del Nord, ma non anche un Vietnam riunificato. Con una società ancora sconvolta dalla Rivoluzione culturale, gli effetti immediati sull’Unione Sovietica della mossa di Pechino, però, non furono particolarmente sensibili: anche se liberare gli Stati Uniti dalla preoccupazione per le mosse cinesi comportò un danno strategico per il Cremlino.
L’altra variante più direttamente devastante per i sovietici fu la messa in movimento del fondamentalismo islamico. Al contrario di quei Paesi con una religione sostanzialmente nazionale (dal Giappone all’India non musulmana, alla religione atea del confucianesimo), l’Islam ha una religione universalistica la cui spinta a unificare i fedeli sotto un califfato (l’ultimo fu quello a guida turca che finisce nel 1923) ha radici molto forti che solo il paziente lavoro britannico di invenzione e costruzione di nazioni e Stati a popolazione musulmana riuscì a depotenziare in una prima fase la ripresa di iniziativa di certi Stati islamici ha avuto una base essenzialmente laica: così con l’Egitto a Suez, così con l’Algeria, così con l’egemonia del Baath in Siria e Iraq, così con la mobilitazione di al Fatah. Sono la guerra dei Sei giorni contro Israele e il successivo crollo del prezzo del petrolio con risposta dell’Opec guidata dall’Arabia Saudita che costruiscono un ponte tra l’Islam laico e quello religioso.
Poi arriva la svolta fondamentalista dell’Iran di Ruhollah Khomeini, che spaventa il potere sovietico per le ripercussioni che può avere in Asia centrale e lo spinge a invadere l’Afghanistan. È questo movimento della storia che alla fi ne piega l’Unione dei Soviet sia finanziariamente sia (e forse ancora più profondamente) ideologicamente, creando una crisi di egemonia del potere in una popolazione (e in classi dirigenti) convinta che il Pcus interpretasse lo spirito dei tempi e fosse dunque invincibile.
Questo è il percorso che ci porta ai giorni nostri. Un percorso caratterizzato, nella sua fase iniziale, da Stati Uniti che considerano superato ogni problema di leadership globale grazie alla fi nanza, a un ruolo non più militare ma da polizia planetaria, a istituzioni sovranazionali che sostituiscono la politica e a una Mosca che vede accompagnare la liquidazione del suo impero non da uno sforzo politico per integrare la società russa in quella europea, ma da una spoliazione, dal taglio sostanzialmente colonialistico, delle sue risorse.
E intanto le tre tendenze di cui si è prima scritto (finlandizzazione dell’Europa, nuova Cina e fondamentalismo islamico), che hanno accompagnato la crisi e la liquidazione dell’Unione Sovietica, continuano a operare anche dopo la fi ne della guerra fredda. Pesa l’entrata, grazie a Deng Xiaoping, della Cina nella storia del mondo. Pechino assume, per una prima fase, un comportamento riformista in politica interna e non egemonistico in quella internazionale, diventando man mano con Bill Clinton un partner considerato affidabile dagli Stati Uniti, nonostante l’effetto deflattivo che la sua entrata nel Wto produce rapidamente. Tra il 2008 e il 2011 però con Xi Jinping si cambia la direzione della politica: all’interno si accentuano il regime poliziesco e la direzione monocratica invece che collegiale, in campo internazionale si sceglie una via apertamente egemonistica che nei fatti sfida gli Stati Uniti.
Sapelli ci dà molti elementi per comprendere la nuova linea di Pechino, in parte notevole determinata dalla crisi finanziaria del 2008 e da quella da debito statale degli anni successivi. Pur avendo aiutato a sviluppare un vastissimo ceto medio, il potere cinese, al contrario di quello «urbano» sovietico, ha sempre avuto una base prioritariamente contadina, sistematicamente organizzata dall’Esercito popolare cinese, attore politico più o meno alla pari con il «partito». E le crisi che colpiscono la base sociale del potere cinese determinano sempre modificazioni radicali dei comportamenti politici di Pechino, mutamenti abbastanza governabili grazie alla natura autoritaria/militarizzata del sistema politico di quella enorme nazione.
Però il principale fattore di destabilizzazione della leadership unilaterale degli Stati Uniti è stato dopo il 1989-1991 (caduta del Muro di Berlino, scioglimento dell’Urss) ancora quello provocato dai movimenti interni al mondo islamico, che pesano sia direttamente in Europa (la Bosnia, la Cecenia, la Turchia) sia grazie alla questione dello strategico approvvigionamento di risorse energetiche. La fase storica post-guerra fredda inizia con i pasticci dell’amministrazione americana che sembra dare via libera a Baghdad nell’invasione del Kuwait, quasi come ricompensa del ruolo che l’Iraq ha avuto negli anni Ottanta nel contenere l’Iran. Per correggere il primo pasticcio si arriva così all’ugualmente pasticciata guerra del Golfo, che contiene Saddam Hussein ma senza costruire un vero nuovo equilibrio: l’esito di tutti questi «pasticci» non governati da Bill Clinton è l’11 settembre del 2001.
In questa tragica vicenda con migliaia di morti sul suolo americano, il dato più interessante è quello che riguarda la composizione dei commando che spargono terrore negli Stati Uniti: dei diciannove dirottatori, ben quindici sono sauditi. Il che, al di là di teorie complottistiche come sempre relativamente esagerate, testimonia come Riad, tradizionalmente molto concentrata sulle questioni della sua sicurezza interna, si sia quantomeno distratta. Dopo la guerra in Afghanistan, quella condotta dal l’amministra zio ne Bush jr. in Iraq, pur tra mille errori – nella propaganda, nelle improbabili speranze di esportare una democrazia all’occidentale in una nazione come quella irachena, nelle trascuratezze nell’affrontare la questione iraniana, nel poco sostegno al più geniale comandante in campo, cioè David Petraeus –, fu tesa a liquidare Saddam Hussein come garanzia a un’Arabia Saudita innervosita da una guerra sui due fronti: Baghdad e Teheran.
Come racconta Alan Greenspan in The age of turbulence, affrontare la seconda guerra nel Golfo senza correre i rischi politici incontrati in Vietnam richiese una politica finanziaria azzardata e preparò quindi la crisi del 2008, con le successive elezioni presidenziali vinte da un Barack Obama, così importante sul piano interno per l’integrazione della società americana, così deleterio internazionalmente, con un mix di predicazione idealistica à la Wilson e di concreto disimpegno politico (leading from behind, guidare da dietro, fu lo slogan che accompagnava la sua politica globale). I guasti peggiori furono quelli combinati in Medio Oriente, con una scelta di appeasement con il principale destabilizzatore di quell’area, cioè Teheran, con una delega a Recep Erdogan per la «democratizzazione» di Libia ed Egitto, rilanciando così di fatto i Fratelli musulmani organicamente legati all’erdoganiano Partito della Giustizia e dello Sviluppo e matrice della formazione di Hamas in Palestina.
L’elezione di Donald Trump non rimediò a molti dei guasti obamiani finché non arrivò al Dipartimento di Stato Mike Pompeo che, tra i Patti di Abramo e l’eliminazione del generale iraniano Qasem Soleimani, compì atti che consolidarono la stabilizzazione del cuore del Medio Oriente: atti che poi non ebbero un’adeguata, necessaria implementazione da parte dell’amministrazione di Joe Biden.
Di questo tratta diffusamente Sapelli, e a tale questione si riferiscono alcune delle citazioni di Verso la fine del mondo poste all’inizio di questa prefazione. Alla fine del libro di Sapelli si indica il centro dell’attuale destabilizzazione nell’area che dal Centro Asia passa all’Iran, alla Mezzaluna fertile per finire con il Nord Africa, cioè l’area di maggior insediamento islamico, e che implica conseguenze dirette su Turchia, Crimea, Caucaso, cioè sull’altro polo, insieme a Israele, delle guerre in corso.
Al fondo di vicende che ancora stiamo vivendo c’è la crisi della leadership americana (e qui rileggetevi la citazione iniziale sull’Anabasi). Ma a questa crisi statunitense si aggiunge quella europea. E qui vale la pena di esaminare la terza tendenza che dall’epoca della guerra fredda prosegue nei giorni nostri: quella della cosiddetta «finlandizzazione dell’Europa», che consiste innanzitutto nell’annacquamento della partnership con gli Stati Uniti e nella rinuncia a un vero ruolo politico del vecchio continente. Lasciando da parte la questione della concezione tecnocratica invece che costituzionale dell’integrazione europea su cui l’autore scrive ampiamente, vale la pena di concentrarsi sul passaggio che dal 2003 con Gerhard Schröder e Jacques Chirac arriva fino al 2021 di Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Come ha ricordato recentemente Mario Draghi, questo periodo è caratterizzato da uno sviluppo innanzitutto tedesco, basato sull’energia fornita dalla Russia e sull’export verso la Cina, mentre la Francia cerca di ottenere in cambio (vedi liquidazione di Mu’ammar Gheddafi ) la supremazia in Africa. Non c’è, nell’iniziativa francotedesca, alcuna visione strategica, non si sistemano i rapporti con Mosca, non si concepisce un piano per stabilizzare l’Africa, non si aiutano gli Stati Uniti a stabilizzare (e razionalizzare) la loro politica estera, non c’è alcuna visione strategica di che cosa comportano i rapporti con Pechino: Parigi e Berlino arrivano nel cuore della guerra irachena a impegnarsi nell’Onu per isolare Washington, provocando il ritrarsi di Mosca e un via libera alla Turchia di Erdogan, scelte di cui raccoglieremo i frutti qualche decennio dopo. Tutto ciò fino a che la guerra in Ucraina presenta il conto di tutta questa miopia politica.
Questo è quel che è successo, come se ne uscirà? Sapelli, con il suo taglio da studioso dallo sguardo profondo, giustamente trascura la superficiale cronaca politica più attuale. Però anche a quella bisogna rivolgersi se si vuole capire se vi sono chance di ripresa di un’iniziativa occidentale, o se dal possibile destino tragico intravisto dall’autore ci sia modo di uscire.