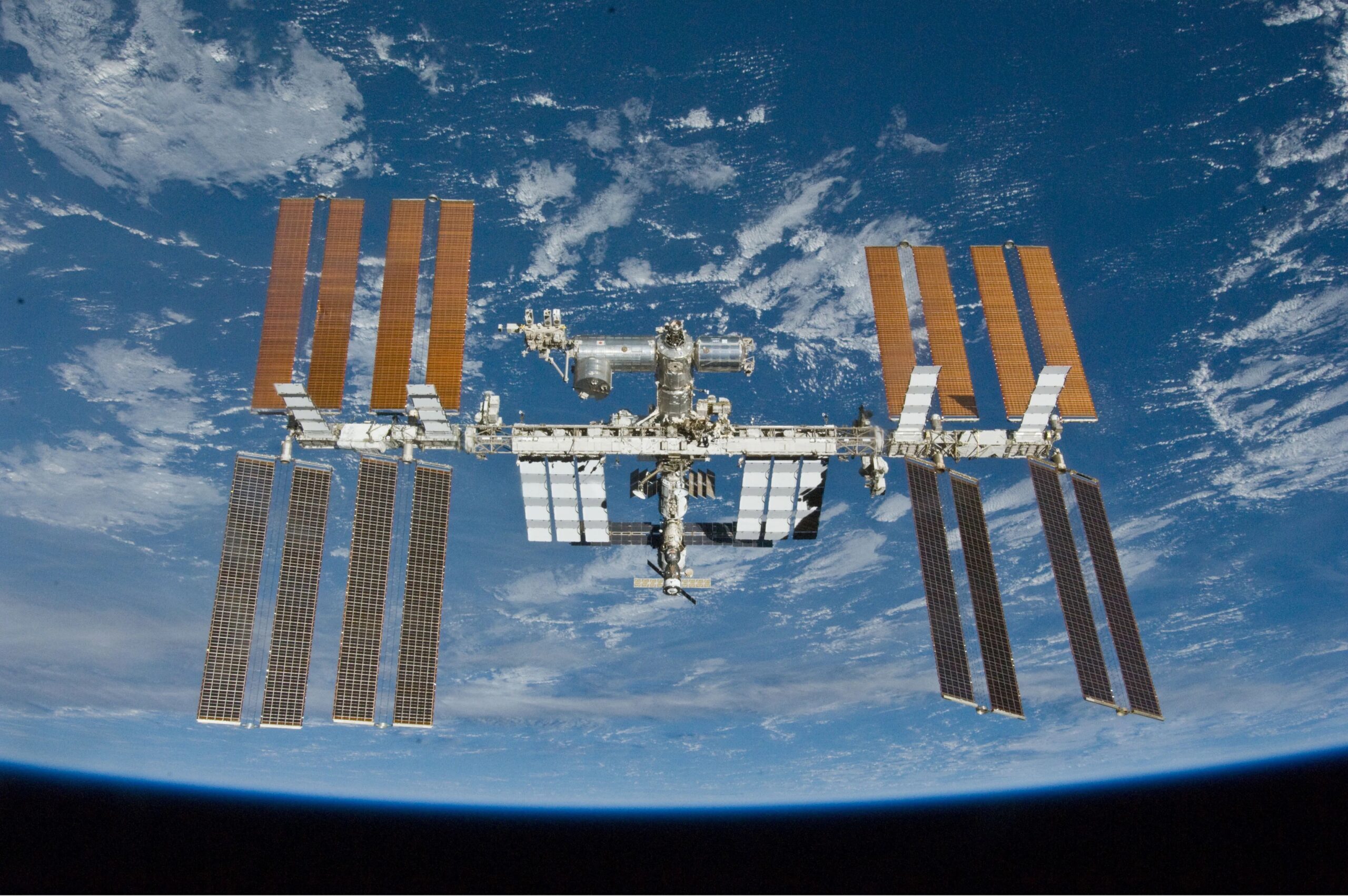La tempesta commerciale temuta si è trasformata in una perturbazione forse meno devastante, ma il cielo economico rimane plumbeo. È il clima che si respira questa mattina in Germania all’indomani del compromesso Ue-Usa sui dazi: un’aria uggiosa, in sintonia con l’umido grigiore di questa fine luglio berlinese. Per restare alla metafora meteorologica e utilizzare le parole del presidente dell’Associazione dell’industria chimica tedesca (VCI) Wolfgang Große Entrup riprese dall’Handelsblatt: “Chi si aspetta un uragano, è grato per un temporale.”
L’intesa siglata tra Washington e Bruxelles sulla controversia doganale ha evitato il peggio, stabilendo un’aliquota uniforme del 15% sulle importazioni europee negli Stati Uniti, contro il paventato 30%. Tuttavia, la Germania – ancora oggi locomotiva economica del Vecchio Continente, nonostante tre anni di crisi – accoglie questo compromesso con sentimenti contrastanti, oscillando tra il sollievo per aver scongiurato una guerra commerciale totale e l’inquietudine per un accordo che comunque penalizzerà la sua economia orientata all’export.
Il negoziato concluso a Turnberry tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente statunitense Donald Trump ha delineato i contorni di una soluzione che presenta luci e ombre. Mentre alcuni settori strategici – dall’aeronautica ai semiconduttori, passando per specifici comparti chimici e farmaceutici – beneficeranno dell’eliminazione totale dei dazi, l’industria automobilistica europea potrà contare su una significativa riduzione delle tariffe dal precedente 27,5% al nuovo 15%. Tuttavia, acciaio e alluminio continueranno a subire pesanti gravami doganali, mantenendo una struttura punitiva che secondo gli analisti colpisce settori cruciali dell’economia tedesca.
IMPATTO ECONOMICO QUANTIFICATO
Le proiezioni elaborate dall’Istituto per l’economia mondiale di Kiel (Institut für Weltwirtschaft, IfW), e pubblicate in esclusiva questa mattina dall’Handelsblatt, delineano uno scenario preoccupante per la Germania. L’applicazione della nuova struttura tariffaria comporterà una contrazione del Prodotto interno lordo tedesco dello 0,15% nel corso dei prossimi dodici mesi, equivalente a una perdita economica di circa 6,5 miliardi di euro. Per l’intera Unione europea, la riduzione stimata si attesta allo 0,1% del Pil complessivo. Questi calcoli, pur soggetti a margini di incertezza, evidenziano come l’accordo, seppur preferibile alle alternative più drastiche, comporti comunque un prezzo significativo per le economie europee.
L’analisi comparativa rivela la portata del compromesso raggiunto: senza l’intesa, mantenendo i precedenti dazi automobilistici al 27,5%, l’economia tedesca avrebbe registrato una contrazione dello 0,51%. Paradossalmente – aggiungono i ricercatori di Kiel – l’imposizione della minacciata aliquota generale del 30% avrebbe prodotto una perdita limitata allo 0,62%, dimostrando come la specificità settoriale dei gravami possa risultare altrettanto dannosa di una penalizzazione generalizzata.
REAZIONI POLITICHE E ISTITUZIONALI
Il governo tedesco ha accolto l’accordo con moderata soddisfazione, sottolineando attraverso un portavoce come l’intesa abbia permesso di evitare un conflitto commerciale dalle conseguenze catastrofiche per un’economia fortemente dipendente dalle esportazioni. Friedrich Merz ha evidenziato l’importanza fondamentale della riduzione dei dazi automobilistici, riconoscendo nell’unità negoziale europea un fattore determinante per il raggiungimento del compromesso.
L’atteggiamento delle istituzioni riflette una consapevolezza della complessità geopolitica sottostante: l’Europa non può permettersi un conflitto con Trump anche per considerazioni di sicurezza, data la dipendenza dal sostegno militare americano nella Nato e nell’assistenza alla sicurezza interna di molti paesi europei (leggi legami tra i servizi di intelligence) e all’Ucraina. Questo intreccio tra dinamiche commerciali e strategiche di difesa ha inevitabilmente influenzato l’approccio negoziale europeo e la posizione morbida tenuta dal governo tedesco e dal cancelliere Merz in particolare.
MONDO INDUSTRIALE DIVISO
Le associazioni imprenditoriali tedesche hanno espresso valutazioni divergenti sull’accordo. La Confederazione dell’industria tedesca (BDI) ha manifestato severe critiche, definendo l’accettazione di dazi così elevati un “segnale fatale” che comprometterà la competitività delle imprese orientate all’export. Particolarmente penalizzante è considerato il mantenimento di tariffe elevate su acciaio e alluminio, settori chiave dell’industria germanica.
La Camera di commercio e dell’industria ha adottato un approccio più pragmatico, riconoscendo come l’Ue abbia “evitato il peggio” pur pagando un prezzo considerevole. L’amministratore delegato Martin Melnikov ha sottolineato l’incertezza sui dettagli implementativi dell’accordo, avvertendo che la stabilità garantita è solo temporanea. L’Associazione del commercio estero (BGA) ha utilizzato termini invece più duri, definendo l’intesa un “compromesso doloroso” che rappresenta una minaccia esistenziale per numerosi operatori commerciali.
PROSPETTIVE E FRAGILITÀ DELL’ACCORDO
Per l’industria chimica, l’accordo rappresenta essenzialmente un male minore piuttosto che una soluzione ottimale. La metafora dell’uragano e del temporale, utilizzata dal presidente della VCI è chiarissima: è stata evitata un’ulteriore escalation nella disputa commerciale, tuttavia il prezzo da pagare per entrambe le parti è alto e le esportazioni europee perderanno competitività. I dazi concordati sono troppo elevati.
Le contraddizioni emerse già in fase di annuncio dell’intesa – con Trump che ha parlato di dazi farmaceutici e von der Leyen che li ha esclusi – testimoniano la fragilità di un accordo costruito più sulla necessità di evitare il peggio che su una visione condivisa del futuro commerciale transatlantico, commenta la Neue Zürcher Zeitung, che dal suo osservatorio svizzero abbraccia un po’ tutta l’Europa: la Germania e l’Europa si trovano così a navigare in acque incerte, dove la stabilità a breve termine non può mascherare l’esigenza di ripensare un modello economico sempre più pressato tra le ambizioni egemoniche di Washington e Pechino. La settimana di incontri di von der Leyen con Xi e Trump ha rappresentato un brusco risveglio per l’Europa. “Per il momento, all’Ue non resta molto altro da fare che approfondire il mercato interno. Ciò può limitare i danni”, conclude la Neue Zürcher Zeitung, “ma non è un’alternativa al commercio relativamente indisturbato con la Cina e gli Stati Uniti che esisteva un tempo”. Il rischio, sempre più concreto, è di restare schiacciati nel braccio di ferro egemonico tra le due grandi potenze.