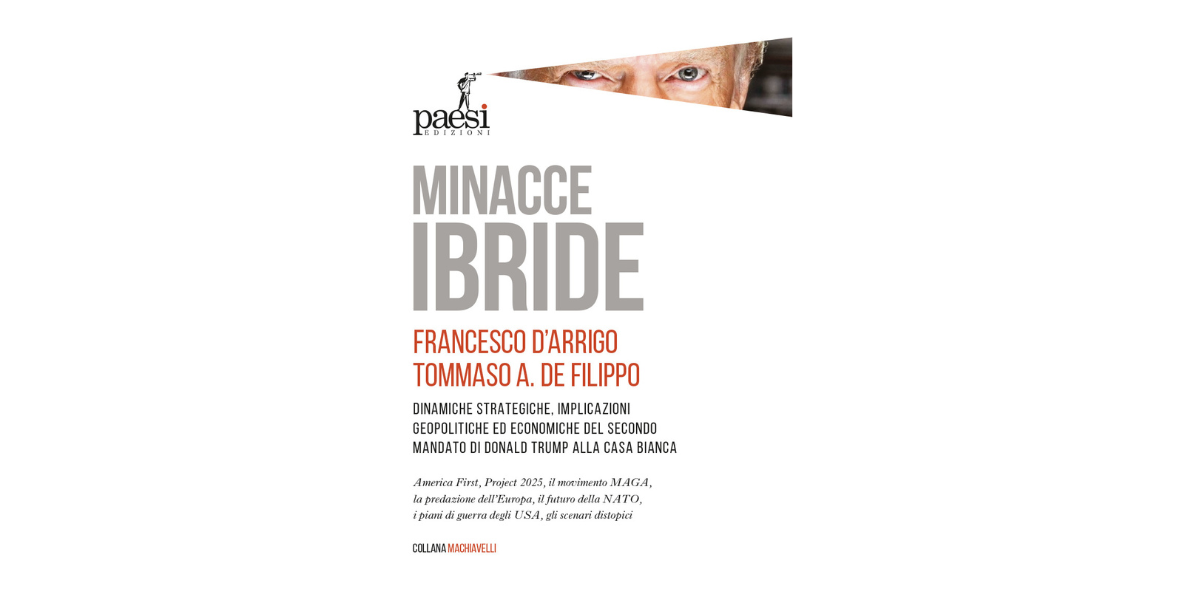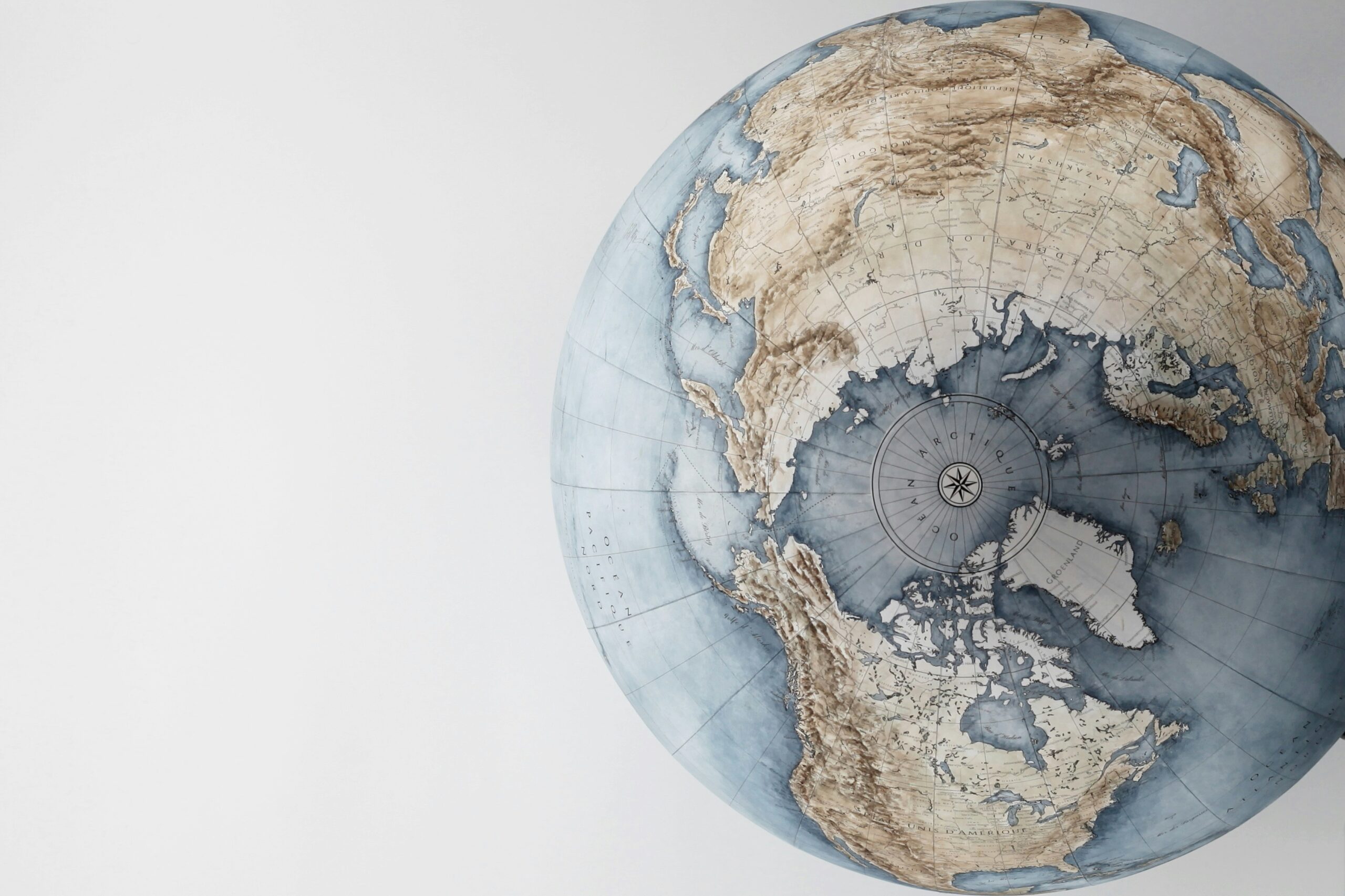Annunciati il 2 aprile nel cosiddetto “Liberation Day”, i dazi di Trump promettevano di rivoluzionare il commercio globale, ma a sei mesi di distanza, come scrive l’Economist, l’impatto è meno apocalittico del previsto.
Sebbene prezzi di beni durevoli e inflazione salgano, con settori come manifatturiero e retail in difficoltà, l’economia Usa cresce (3,8% nel secondo trimestre 2025) e il mondo si adatta. Tariffe più basse del dichiarato, esenzioni diffuse e assenza di ritorsioni globali mitigano i danni, mentre Cina e alleati diversificano il commercio. Tuttavia, come rileva la testata britannica, i costi per le famiglie americane cresceranno, con rischi di inflazione persistente e rallentamento economico.
L’annuncio e le prime reazioni
Il 2 aprile il presidente Donald Trump ha svelato i suoi “dazi del Giorno della Liberazione”, brandendo una lavagna piena di cifre che dipingeva un mondo che si comportava scorrettamente, dal punto di vista commerciale, verso gli Stati Uniti. Numeri privi di fondamento, ma il messaggio era inequivocabile: l’era del libero scambio era finita.
Come scrive l’Economist, i mercati hanno tremato, gli alleati americani si sono infuriati e gli economisti hanno previsto il disastro. Torsten Slok di Apollo, colosso dei mercati privati, ha stimato al 90% il rischio di recessione tariffaria negli Usa.
Nelle pieghe dell’economia americana, il dolore è tangibile. I prezzi dei beni durevoli – elettrodomestici e auto – sono saliti del 3% annuo nel secondo trimestre 2025, il ritmo più veloce dagli anni ’90 (esclusa la pandemia). I giocattoli, in gran parte cinesi, crescono quasi del 5%.
Complessivamente, come rileva la testata britannica, le tariffe aggiungono 0,3 punti percentuali all’inflazione. L’occupazione cala nei settori esposti, come manifattura e retail; i capi d’azienda incolpano costi e incertezza. La fiducia dei consumatori a settembre è un quinto sotto i livelli di un anno fa. Rispetto a un mondo senza dazi, l’America sta peggio.
L’assenza del peggio previsto
Sei mesi dopo, però, il redde rationem non si è ancora registrato. Niente inflazione galoppante; l ‘economia Usa è cresciuta del 3,8% annuo nel secondo trimestre; la filiale di Atlanta della Fed prevede uno scatto simile nel terzo. I consumatori spendono, le imprese investono e la Borsa vola. Come scrive l’Economist, anche altrove l’outlook migliora: a settembre l’Oecd ha rivisto al rialzo la crescita globale al 3,2%, dal 2,9% di tre mesi prima.
Perché queste buone notizie? Le tariffe secondo l’Economist sono state più miti del previsto. Ad aprile, il tasso medio Usa era stimato al 30%; oggi i modelli lo collocano al 18%. Trump ha minacciato la Cina con il 145%, ma a settembre ha abbassato notevolmente le percentuali. La Corea del Sud è passata dal 25% al 15%. Perfino il Lesotho – paese povero e senza sbocco sul mare, esportatore di vestiti – ha evitato il 50% promesso.
Ritardi nell’attuazione hanno ammorbidito i colpi. Una sentenza della Corte Suprema potrebbe bloccare molte tariffe, e le aziende attendono certezze prima di riversare i costi sui consumatori
Eccezioni e buchi normativi
Le deroghe hanno smussato ulteriormente l’impatto. Quasi la metà delle importazioni Usa è esentata. Elettronica come smartphone e pc è stata risparmiata del tutto. Il Brasile, con un 50% nominale, ne ha quasi 700, riducendo i dazi al 30%. Il Canada, al 35% sulla carta, è in pratica al 6% secondo Scotiabank, grazie all’Usmca.
Anche i dazi settoriali sono pieni di scappatoie. Le nuove tariffe farmaceutiche al 100%, annunciate l’1 ottobre, hanno escluso i generici (90% dei farmaci Usa) e le aziende branded con piani di investimento. Trump ha sospeso i dazi per negoziare.
Come rileva la testata britannica, anche dopo deroghe, il divario tra tariffe teoriche e reali è netto. Il Budget Lab di Yale stima che il tasso implicito, da dati doganali, sia la metà del previsto. Parte del gap è “front-running”: aziende hanno accumulato scorte d’estate, spingendo l’import al record, dato che i dazi non colpiscono merci in transito.
Evasioni e mancate ritorsioni
Non bisogna poi sottovalutare l’impatto delle elusioni. Gli economisti assumono un 10-15% di non conformità; le regole complesse di Trump l’hanno aumentata. Il divario tra esportazioni cinesi dichiarate e import Usa registrato è cresciuto, anche senza esenzione de minimis per pacchi piccoli.
Alcune aziende sottovalutano le fatture. Whirlpool ha accusato i rivali di aver tagliato i valori doganali post-dazi. Le riallocazioni contano: la quota di export canadesi conformi all’Usmca è balzata, suggerendo riconfezionamenti.
Il fatto più decisivo è ciò che non è accaduto: ritorsioni. Modelli economici prevedevano tariffe contro-tariffe; invece, i partner commerciali hanno trattenuto il fiato. Pochi sono grandi abbastanza da ferire gli Usa da soli, soprattutto se manca il coordinamento.
Come scrive l’Economist, ciò è avvenuto probabilmente perché l’America conta meno rispetto a un tempo: se all’inizio del secolo rappresentava un quinto delle import globale, ora ne rappresenta un ottavo. Il Brasile manda solo il 13% delle sue export agli Usa, contro il 26% negli anni 2000.
Anche dove la dipendenza resta, come nel Sud-Est asiatico, i dazi al 20% non incentivano vendette.
Diversificazioni e alleanze globali
Invece di rappresaglie, molti Paesi hanno scelto di diversificare il commercio. La Cina, bersaglio principale dei dazi trumpiani, ha visto l’export Usa crollare, ma il totale resiste: da giugno ad agosto +6% annuo, con vendite in Sud-Est asiatico al +20% e in Europa al +10%. I tessili cinesi inondano l’Europa (+20% import l’abbigliamento nel primo semestre 2025). L’elettronica affluisce in Asia.
Le tariffe di Trump spingono altri a unirsi. Canada e Messico hanno rafforzato i legami in vista della rinegoziazione Usmca nel 2026. Il 23 settembre l’Ue ha firmato un accordo con l’Indonesia che elimina i dazi su beni industriali, e adesso è vicina a un patto con l’India. Molti si avvicinano alla Cina: l’Asean ha potenziato l’accordo con Pechino. Gli investimenti cinesi in Brasile sono saliti del 60% nel primo semestre.
Guadagni illusori
Tutto ciò solleva una domanda: cosa ha guadagnato l’America? Il dato è presto detto: ricavi tariffari di $19 miliardi al mese rispetto all’anno scorso. Coprono i tagli fiscali recenti, ma il deficit resta alto. Trump ne userà gran parte per compensare i perdenti come agricoltori, rendendo le tariffe una tassa regressiva.
Il deficit commerciale si allarga, gli investimenti non decollano, la rinascita manifatturiera è un miraggio. Finora, le aziende Usa hanno assorbito i costi. Margini alti e scorte pre-dazi hanno aiutato. Ma con i cuscinetti che si assottigliano, i prezzi saliranno.
Come rileva la testata britannica, il Budget Lab di Yale prevede -2.400 dollari annui sui redditi familiari. Il rollout graduale rischia di trasformare uno shock in inflazione persistente. Con le aspettative inflazionistiche in rialzo, la Fed terrà tassi alti più a lungo, frenando la domanda.
Il futuro del commercio globale
Come gestiranno altri paesi le tariffe Usa e il boom cinese? Alcuni erigono barriere: il Messico ha deciso di alzare i dazi al 50% sulle auto cinesi; l’Ue si unisce agli Usa e al Canada contro l’acciaio cinese low-cost, tagliando le quote e alzando i dazi. Nel Sud-Est asiatico, l’inondazione cinese spinge a misure di salvaguardia.
Ma la logica dell’apertura persiste. Piccole economie si coalizzano: Nuova Zelanda, Singapore e Emirati Arabi hanno creato la Future of Investment and Trade Partnership con 14 paesi. Il Rcep asiatico, inclusa Cina, esplora nuovi membri e maggiore integrazione. Ue e Cp TPP (Australia, Canada, Giappone, Messico) potrebbero armonizzare gli standard. Anche scettici della globalizzazione, da India a Indonesia, difendono il commercio.
All’ordine liberale manca un leader, conclude l’Economist, ma non i discepoli.