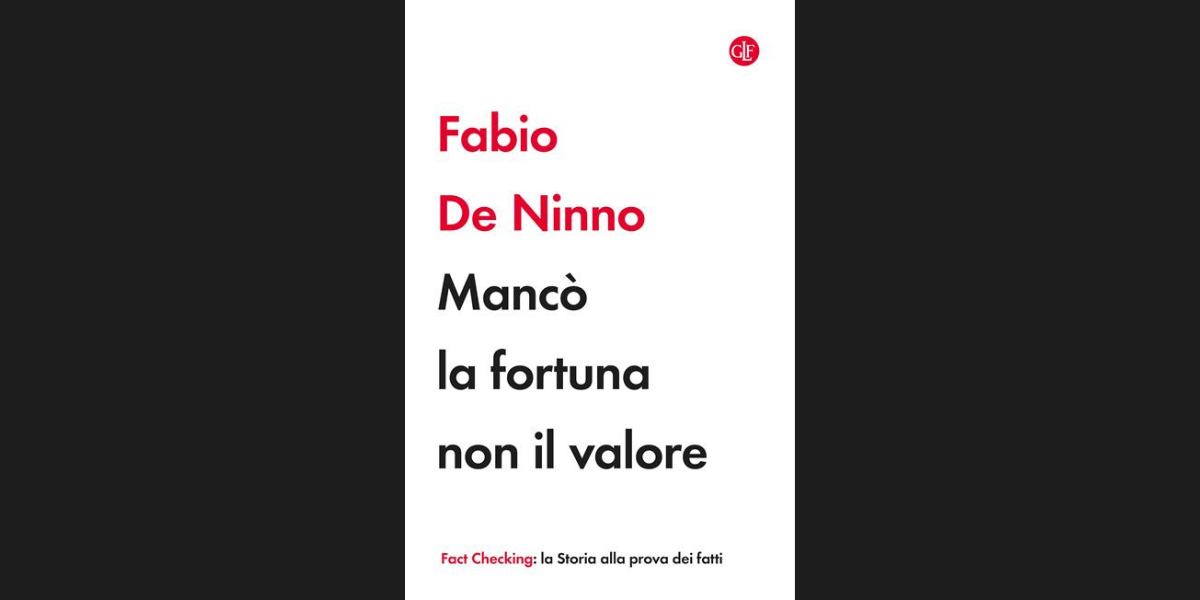Non è questione di “patriarcato” e non è questione di “cultura” maschilista. La violenza sulle donne è una piaga sociale che nasce sul terreno di una assordante assenza generalizzata di radicamento etico. E su una palpabile leggerezza e inconsapevolezza non solo delle nuove generazioni sulle conseguenze di atteggiamenti, azioni, comportamenti soprattutto se praticati nell’universo digitale. Le aule di tribunale (ad iniziare dai tribunali per i minorenni) sono intasate da processi per diffamazione, violenza privata, maltrattamenti in famiglia, molestie… Perché questi sono gli “abiti” giuridici di comportamenti sempre più diffusi e che molti ritengono innocui o, al più, goliardici.
Sempre più spesso lo strumento principe di queste violenze è il web. Una volta le “sconcerie” e i comportamenti fuori dalle righe e dalle regole e si limitavano a battute da osteria, confinate in chiacchierata goliardiche davanti ad una birra. Oggi, lo strumento digitale ha trasformato quelle “cafonate” in reati. Che cambiano la vita: innanzitutto a chi le subisce. Il termine “cyberviolenza” non deve far pensare a qualcosa di impalpabile. Perché è più penetrante della violenza fisica. È una piaga globale, in costante crescita. E dentro c’è di tutto: dal molestatore represso all’amica gelosa, dal narciso patologico al diffamatore seriale, da chi si si sente creativo utilizzando tecnologie deep-fake capaci di imitare voce e movenze di una persona fino al beota che intende farsi bello con l’invio personalizzati di video sessualmente primitivi. Magari sentendosi irresistibile.
Sono tutti reati penalmente perseguibili. Ma la verità è che chi opera e persino che subisce simili violenze, alle volte, nemmeno si rende conto che sono illeciti da reclusione. Un’indagine del 2014 dell’Agenzia dell’Ue per i diritti fondamentali ha mostrato che una donna su dieci nell’Unione europea ha subito molestie informatiche dall’età di 15 anni. Ma questo dato, pur significativo, non è reale. Proprio per il fatto che il cittadino medio non percepisce la rilevanza penale di molti comportamenti, soprattutto se informatici. Come se il “metaverso” fosse una astrazione dalla realtà, un universo parallelo in cui tutto è permesso.
Nell’aprile 2024, il Parlamento ha adottato la prima normativa Ue per il contrasto sulla violenza contro le donne con una direttiva che chiede leggi più severe contro la cyberviolenza. I Paesi membri dovranno adeguarsi entro il 2027. Tra le misure indicate l’obbligo per le grandi piattaforme digitali di rimuovere i contenuti illegali dai propri siti, l’obbligo di etichettare come deep-fakes immagini e contenuti creati con l’intelligenza artificiale ed altro ancora.
Tutto ottimo, tutto condivisibile. C’è un però. La legislazione in evoluzione (per quanto doverosa) non ha mai frenato mentalità e atteggiamenti. È necessaria, parallelamente, un’opera culturale di assunzione di consapevolezze. Non parlo di convincere i maschi di essere pericolosamente “patriarcali” e redimerli (se ci fosse un vero “patriarcato” certi maschi sarebbero presi a ceffoni dai padri), parlo di sensibilizzazione culturale, sociale e giuridica nei confronti soprattutto delle giovani generazioni. Ho personalmente collaborato, con l’associazione nazionale di cui sono presidente (Difesa Legittima Sicura) che si occupa di contrasto alla violenza contro le donne e contro il bullismo, a decine di iniziative e progetti nelle scuole. Ci sono praterie da percorrere e ragazzi inconsapevoli pronti però ad ascoltare. E a capire. Non si rinunci ad un approccio pedagogico e non si dia nulla per scontato. Perché l’aggressione in un parco è ben distinguibile da tutti. L’aggressione sottile digitale è ancora una selva oscura.