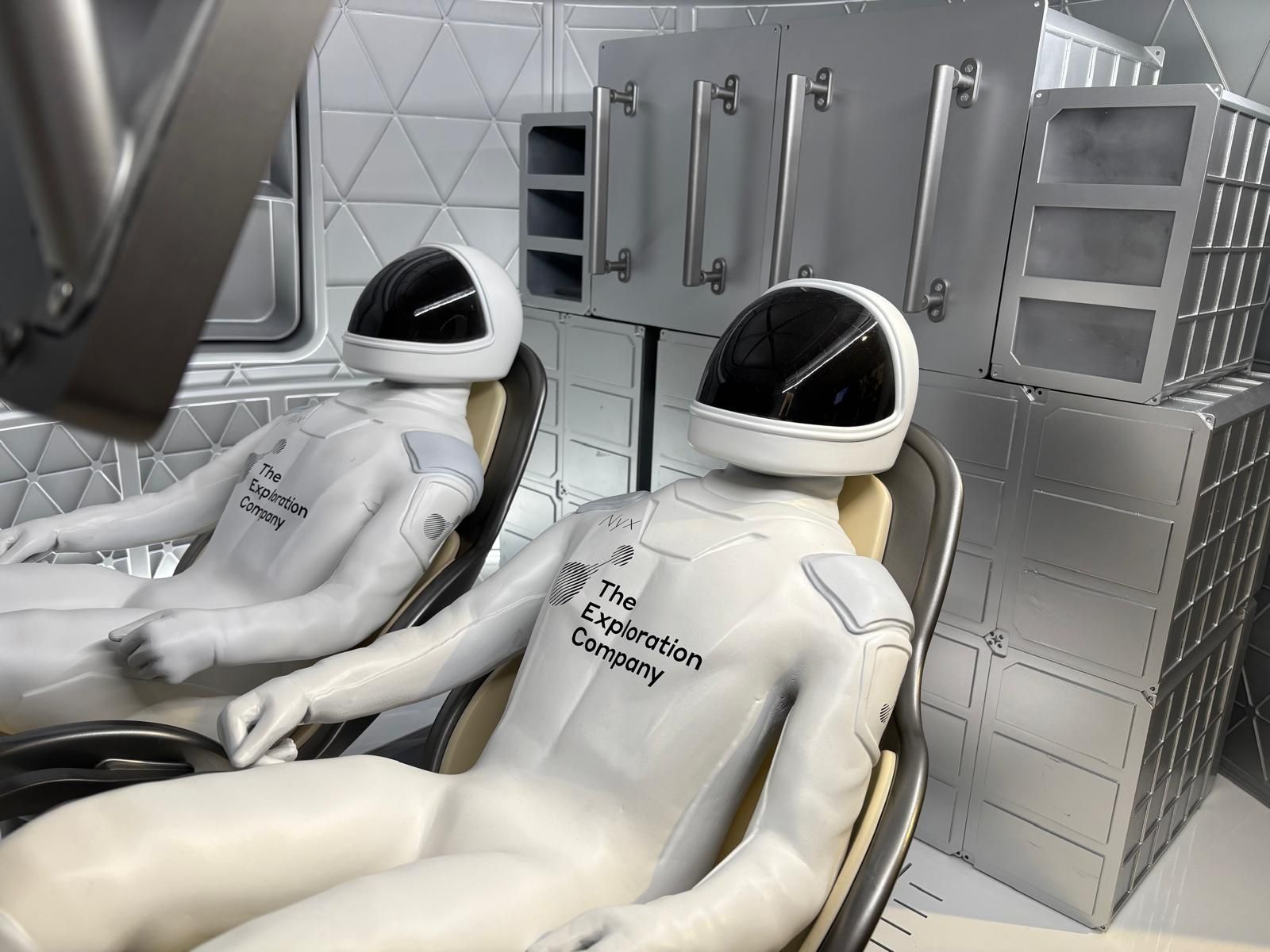Nelle prossime settimane, Binyamin Netanyahu, primo ministro israeliano, spera di ottenere l’approvazione finale del Parlamento per un bilancio di guerra di emergenza. Il bilancio prevede maggiori fondi per i coloni in Cisgiordania e per le scuole religiose, dove gli adolescenti studiano la Torah piuttosto che la scienza: un tentativo di unire la sua coalizione politica in conflitto. Ma contiene anche una sorprendente rottura con il passato. La spesa per il welfare quotidiano (a lungo generosa in Israele, grazie alle sue basi socialiste) sarà tagliata per finanziare le forze armate del Paese. Il budget militare sarà quasi raddoppiato dal 2023 al 2024. Il contratto sociale non scritto di Israele, che da 70 anni promette uno stato sociale generoso e un esercito temibile, è in pericolo.
UNA GUERRA PIÙ COSTOSA DEL PREVISTO
Nonostante le continue discussioni su un cessate il fuoco, Netanyahu ha detto chiaramente che qualsiasi pausa sarà temporanea. E anche se il cessate il fuoco dovesse essere prolungato o se lui dovesse lasciare l’incarico, c’è un ampio sostegno politico per un esercito più potente. Allo stesso tempo, la guerra si sta rivelando più costosa del previsto. Tra ottobre e dicembre l’economia israeliana si è ridotta di un quinto su base annua rispetto ai tre mesi precedenti, più del doppio della contrazione prevista dalla Banca d’Israele. Nello stesso periodo, oltre 750.000 persone, pari a un sesto della forza lavoro, sono state assenti dal lavoro, molte delle quali evacuate o riserviste. Il mese scorso l’agenzia di rating Moody’s ha abbassato il rating del credito del Paese per la prima volta in assoluto. Tutto questo solleva una domanda. Israele può permettersi di fare la guerra?
IL RAPPORTO DEBITO/PIL DI ISRAELE
Il problema principale è di natura fiscale. Alla vigilia dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, il rapporto debito/PIL di Israele era del 60%, ben al di sotto della media del gruppo OCSE, composto per lo più da Paesi ricchi. Da ottobre a dicembre, le forze armate hanno bruciato 30 miliardi di shekel (8 miliardi di dollari) oltre alle spese abituali, un importo equivalente al 2% del PIL. E non si tratta solo di un aumento del budget per le forze armate; il governo sta anche spendendo per gli alloggi degli sfollati, per diversi programmi di licenziamento e per il sostegno ai riservisti. I politici israeliani ritengono che un rapporto debito/PIL del 66% sia gestibile. Il bilancio di Netanyahu prevede un deficit fiscale annuale del 6,6% del PIL, sufficiente a produrre un rapporto debito/PIL di circa il 75%.
Per l’America o il Giappone questo tipo di prestito sarebbe un gioco da ragazzi. In Israele, tuttavia, c’è sempre la possibilità che il conflitto sia dietro l’angolo. Se l’industria tecnologica del Paese dovesse essere ferita, magari in una guerra che coinvolge altre potenze regionali, sarebbe a rischio fino a un quarto del gettito fiscale del Paese. L’ultima volta che Israele ha combattuto una battaglia di questa portata, durante la guerra dello Yom Kippur nel 1973, il suo rapporto di indebitamento ha superato il 100%, innescando una crisi finanziaria. Mentre la banca centrale stampava contanti, l’inflazione è schizzata al 450% nel 1985 e il settore bancario è crollato. Per far felici gli obbligazionisti, quindi, il governo ha bisogno di un margine di manovra.
Molti ora temono che il bilancio di Netanyahu sia troppo sontuoso. Anche se, in tempi di crisi, i governi possono chiedere prestiti per far funzionare le cose, è saggio che lo facciano con moderazione. Dato il desiderio di Israele di aumentare le spese militari, le uscite non torneranno presto ai livelli prebellici. Di conseguenza, il governo ha bisogno di un piano per stabilizzare il debito mentre la spesa rimane elevata.
Nel 2022 il gettito fiscale di Israele era pari al 33% del PIL, appena al di sotto della media OCSE del 34%. Tuttavia, il bilancio di Netanyahu prevede solo aumenti modesti. L’imposta sul valore aggiunto aumenterà di un punto percentuale, raggiungendo il 18%; l’imposta sanitaria sui redditi aumenterà di 0,15 punti percentuali. I politici temono che l’aumento delle tasse sulle imprese provocherebbe la fuga dal Paese del settore tecnologico, altamente mobile e già in difficoltà nel trovare lavoratori. Un inasprimento delle tasse sulle famiglie rischierebbe di deprimere i consumi e renderebbe la vita ancora più difficile a chi già si trova in difficoltà a causa della guerra.
IL RACCONTO DI UNA CITTÀ
Nei sobborghi di Gerusalemme, le famiglie di professionisti laici, che hanno avuto membri richiamati e hanno visto crollare il reddito delle imprese, stanno soffrendo. Molti nei quartieri arabi – i più colpiti dal bilancio di Netanyahu – riferiscono di non essere più i benvenuti al lavoro. A pochi chilometri di distanza, però, le famiglie ultraortodosse, che sono esenti dal servizio militare e fanno affidamento su sussidi che Netanyahu vuole rendere più generosi, hanno dovuto a malapena stringere la cinghia.
L’impatto sulle industrie è altrettanto disomogeneo. Il settore tecnologico sta reggendo ragionevolmente bene. Alcune aziende pensano addirittura di poter realizzare un profitto, beneficiando di una nuova serie di contratti militari. Molte hanno spostato le operazioni all’estero, riducendo così l’impatto della perdita di dipendenti per i combattimenti. “La nostra produttività è migliorata”, dice Chen Bitan di Cyberark, una delle maggiori aziende di sicurezza informatica del Paese. “Abbiamo detto ai nostri dipendenti che la guerra sarebbe stata vinta dall’economia”, spiega. Sebbene gli investimenti tecnologici locali siano diminuiti, lo hanno fatto nella stessa misura di quelli europei, il che suggerisce che la guerra non è da biasimare.
L’ECONOMIA DI ISRAELE È IN DIFFICOLTÀ
Ma il resto dell’economia è in difficoltà. L’edilizia è ferma. Le aziende agricole hanno perso più della metà della loro forza lavoro. E le aziende del turismo stanno soffrendo. A gennaio il 77% di turisti in meno ha visitato Gerusalemme rispetto a un anno fa.
La ripresa potrebbe essere glaciale, anche perché la guerra ha esacerbato problemi di vecchia data. Uno di questi è la dipendenza dell’economia dai lavoratori palestinesi a basso salario. La Cisgiordania può importare da Israele tanti beni quanti ne importava prima della guerra, ma i suoi 210.000 lavoratori a giornata – pari al 5% della forza lavoro israeliana – non possono uscire. I loro permessi sono stati cancellati dopo il 7 ottobre e il governo israeliano si rifiuta di farli rientrare. Nelle fattorie, nelle fabbriche e nei cantieri mancano i lavoratori. Eppure molti industriali sono combattuti. “Abbiamo bisogno dei palestinesi, ma non possiamo dipendere da loro”, dice uno di loro.
Il mercato del lavoro israeliano è già molto rigido. L’ingresso di lavoratori stranieri è lento e costoso, e la forza lavoro del Paese è meno della metà della sua popolazione totale. La metà degli uomini della popolazione ortodossa israeliana, che è il gruppo in più rapida crescita del Paese, si rifiuta di lavorare per motivi religiosi. Quelli che lo fanno sono spesso tristemente poco istruiti, avendo frequentato scuole religiose. Lo stesso vale per gli arabi israeliani, la comunità con il secondo tasso di fertilità più alto. A gennaio, inoltre, nuove regole hanno esteso il servizio militare da 32 a 36 mesi per gli uomini, impoverendo ulteriormente la forza lavoro.
Se il debito dovesse continuare a crescere, mentre l’economia arranca, le cose si faranno difficili. Ma è improbabile che si ripeta quanto accaduto dopo la guerra dello Yom Kippur. I ministeri israeliani sono pieni di tecnocrati. I cittadini sono consapevoli che la loro sicurezza dipende da un’economia stabile e sono pronti a deporre i politici irresponsabili. I mercati ritengono improbabile un default. Sebbene i prestiti siano ora più costosi per il governo, sono ben lontani dai prezzi da capogiro pagati da leader irresponsabili altrove. I tassi di credit-default-swap, un indicatore della fiducia dei mercati in un governo, sono saliti dallo 0,5% all’1,4% dopo il 7 ottobre, prima di stabilizzarsi.
COSA PENSANO I MERCATI
I mercati sembrano avere quasi altrettanta fiducia nel fatto che Israele non scatenerà l’inflazione per ridurre i pagamenti del debito. L’inflazione annuale del Paese, pari al 3%, è inferiore a quella americana e gli investitori si aspettano che scenda allo 0,4% entro la fine dell’anno. Dopo la guerra dello Yom Kippur, Israele si è dotata di una banca centrale che punta all’inflazione e che è di orientamento falco. Dopo il 7 ottobre ha speso 30 miliardi di dollari in riserve estere per sostenere lo shekel (e dispone di altri 170 miliardi di dollari se la valuta ha bisogno di ulteriori ammortizzatori). Da allora lo shekel si è mosso a malapena.
Tuttavia, anche se una crisi finanziaria è improbabile, ciò non significa che il dolore sarà evitato. Si presenterà semplicemente in una forma diversa: attraverso ulteriori tagli alla spesa necessari a garantire la stabilità. I soldi che tengono insieme la coalizione di Netanyahu saranno protetti finché egli rimarrà primo ministro. Invece, come indicato dal bilancio di guerra, sarà lo stato sociale di Israele a subire il colpo. Nonostante abbia uno dei tassi di disoccupazione più bassi dell’OCSE, il Paese è al quinto posto tra quelli che spendono di più per i sussidi di disoccupazione. Solo i governi di Norvegia e Islanda spendono più del loro PIL per l’istruzione. Si tratta di un obiettivo allettante per un primo ministro che ha bisogno di trovare risparmi e ha alleati da proteggere.
Il ministero del welfare, che è anche responsabile dell’assistenza agli sfollati e agli ostaggi restituiti, dovrà subire un taglio dell’8% con il bilancio di Netanyahu, molto più alto di quello che subisce la maggior parte degli altri ministeri civili. Il ministero è già finito sotto tiro per il suo scarso sostegno ai 135.000 israeliani evacuati dal nord e dal sud del Paese. Ha fatto ben poco, se non pagare i conti dell’albergo; ora, secondo quanto riferito, i funzionari stanno facendo pressione sulle famiglie affinché tornino. Se Israele rimarrà sotto la cattiva gestione di Netanhayu, altri ministeri subiranno un trattamento simile. Anche se si dimette, tuttavia, Israele dovrà fare scelte difficili tra i due pilastri del suo contratto sociale: le sue forze armate e il suo stato sociale.
(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)