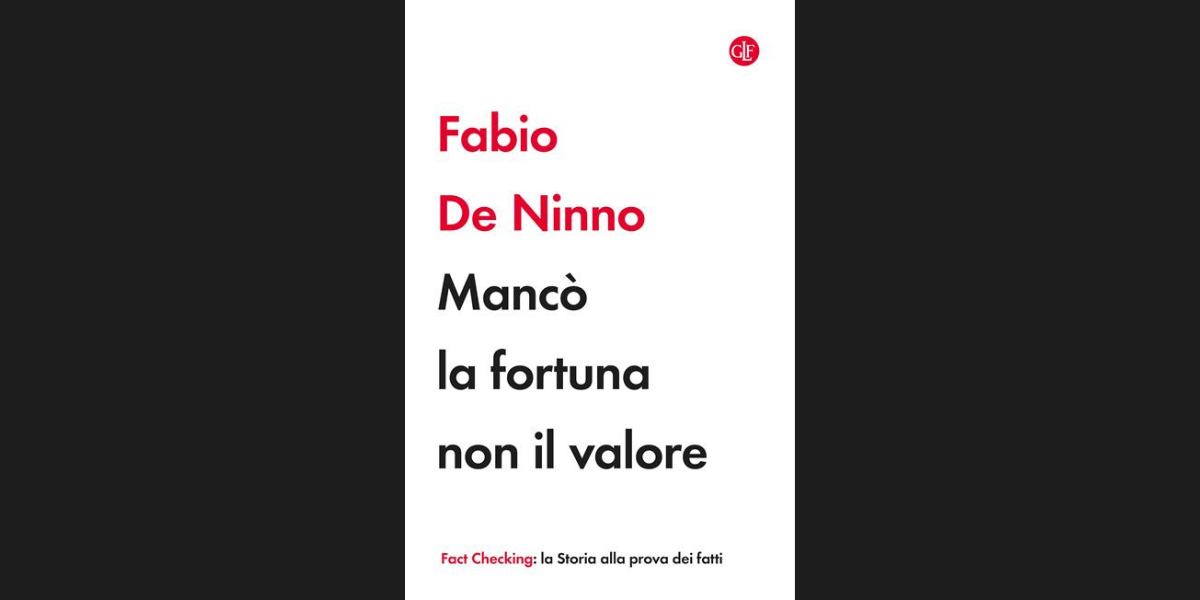La recente condanna in Francia dell’ex presidente Nicolas Sarkozy per il finanziamento illecito legato alla Libia ha il sapore amaro della legge del contrappasso. È inevitabile ricordare quella foto – ormai entrata nella storia – in cui, rivolto ad Angela Merkel, l’ex inquilino dell’Eliseo ridacchiava delle disavventure giudiziarie di Silvio Berlusconi.
Oggi i ruoli si sono capovolti. Sarkozy, l’uomo che nel 2011 chiedeva a gran voce, ed otteneva, la testa di Gheddafi, viene travolto da una vicenda che affonda le radici proprio nei rapporti oscuri con la Libia. Mia moglie, francese, ed io restammo allibiti nel vedere le immagini televisive di quell’ossessione bellicista contro la Libia di Gheddafi, che non prometteva nulla di buono. Oggi abbiamo conferma di quello che all’epoca già si sussurrava: dietro la guerra voluta dall’Eliseo vi erano interessi che nulla avevano a che fare con la difesa della democrazia e delle libertà del popolo libico, e molto invece con il finanziamento occulto della politica.
Per l’Italia, ma anche per l’Unione europea, quell’intervento militare fu un disastro geopolitico. Non solo incrinò definitivamente i nostri rapporti privilegiati con Tripoli, ma comprometteva la sicurezza energetica e strategica nazionale. Una ferita che ancora oggi paghiamo.
La condanna di Sarkozy non è solo una vicenda giudiziaria francese. È un monito che risuona anche in Italia, dove la persecuzione giudiziaria contro il proprio Premier, ha prodotto danni incalcolabili, non solo all’uomo Berlusconi ma al Paese intero. Lo hanno riconosciuto, negli anni, politici, magistrati ed esponenti europei: quella contro Berlusconi fu una campagna denigratoria internazionale che alterò il corso democratico.
Chi scrive, come ha già raccontato in una sua recente pubblicazione, ne è stato in parte testimone. Dall’osservatorio privilegiato dell’Ufficio Europeo per la lotta alla Frode (OLAF), che iniziò a operare con ben tre magistrati italiani, assunti nonostante il diniego del Governo italiano, allora presieduto proprio da Berlusconi. Solo uno dei tre ottemperò alla richiesta di rientrare in Italia. Gli altri restarono, ed uno continuò la sua carriera europea, nonostante il diniego governativo, prima di rientrare in Italia per ricoprire alte funzioni giudiziarie. Portavoce del suo primo, e migliore, Direttore Generale, il Procuratore Bavarese Franz Hermann Bruener, lo sostenni – non senza qualche difficoltà e sofferenza – nella sua decisa volontà di non prestare mai i poteri investigativi a livello europeo dell’Ufficio quale strumento di lotte politiche a livello nazionale. Nonostante alcuni tentativi di lanciare «missili investigativi» da Bruxelles, al solo fine di condizionare la vita politica nazionale.
Ricordo ancora con sconcerto, non solo quale Ufficiale della Guardia di Finanza, ma anche come Dirigente dell’OLAF, il cocktail offerto a tutto il personale dal nuovo direttore generale (ex magistrato, ed ex politico italiano) che succedette a Bruener, dopo la sua prematura scomparsa, per festeggiare la caduta del governo Berlusconi. Fu un gesto che considerai indegno non solo per qualunque italiano che svolgesse una funzione presso un organismo internazionale, ma anche per la neutralità che deve caratterizzare la Commissione europea. Della quale l’OLAF, seppure con statuto di indipendenza per la funzione investigativa, faceva e fa parte.
Dopo che per colpire Berlusconi, qualcuno cercò persino di infangare a livello internazionale la Guardia di Finanza (come ho raccontato qualche anno fa su Il Riformista), sulla scena mondiale si affermavano leader spregiudicati e potenti come Trump, Putin o lo stesso Sarkozy. Mentre l’Italia si auto-indeboliva, lasciando che la giustizia politicizzata stritolasse il suo leader più rappresentativo. Una scelta contro i nostri interessi nazionali, che ha consegnato il Paese a un lungo periodo di instabilità e marginalità internazionale. Ma forse anche degli stessi interessi europei. Perché Berlusconi, nonostante tutto, è sempre stato un grande europeista liberale.
La vicenda Sarkozy dimostra che la storia prima o poi presenta il conto. E che quando politica e giustizia si confondono, a rimetterci non sono solo i singoli, ma le nazioni intere.