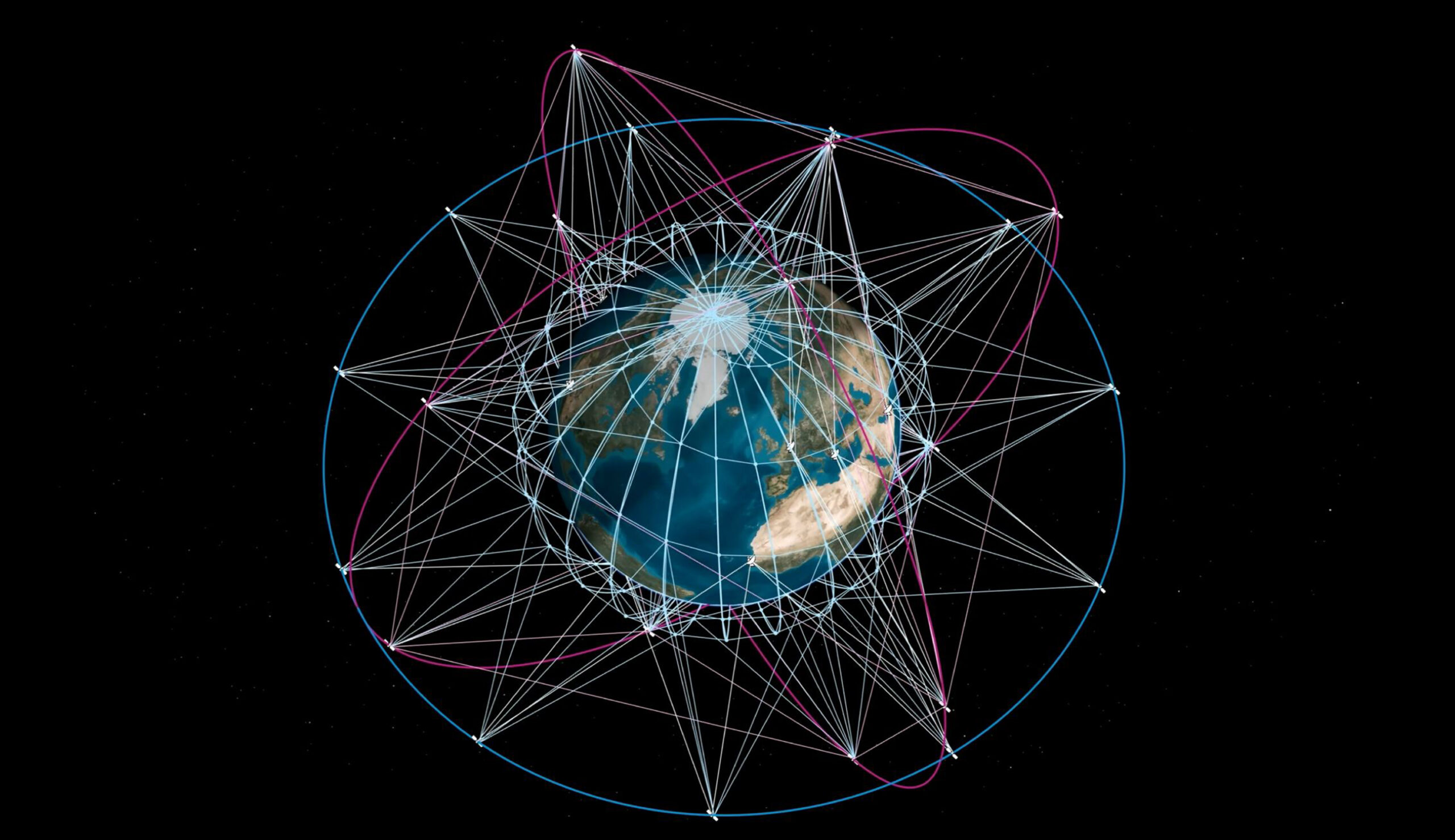Signor Presidente, Onorevoli senatori,
questa nuova legislatura europea si è aperta all’insegna della preoccupazione e dell’incertezza. Per il protrarsi della guerra in Ucraina, per la drammatica escalation in Medio Oriente, per i mutamenti geopolitici, e per le molte difficoltà che attraversa l’economia europea, in parte conseguenza di questi scenari, in parte figlie degli errori del passato.
L’Unione europea si trova ad affrontare queste sfide dopo una tornata elettorale che ha restituito alcuni messaggi molto chiari da parte dei cittadini europei, e con una nuova squadra che dovrà affiancare la Presidente rieletta Ursula von der Leyen.
Se il percorso parlamentare in atto confermerà – come naturalmente crediamo e auspichiamo – la composizione annunciata, di questa squadra farà parte il Ministro Raffaele Fitto, che la Presidente von der Leyen ha voluto designare nel ruolo di Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea. Un notevole miglioramento per la nostra Nazione rispetto alla composizione della commissione uscente, atteso che vedeva 4 Vicepresidenti esecutivi e 7 Vicepresidenti complessivi ma nessuno di questi era italiano.
Differentemente da quanto preconizzato da molti, e da quanto forse sperato da alcuni, questa indicazione è la conferma di una ritrovata centralità dell’Italia in ambito europeo, rafforzata – permettetemelo – da un governo credibile che garantisce la stabilità politica in una fase storica in cui tutto intorno a noi è instabile. Una realtà, insomma, molto distante dal continuo mantra di un presunto isolamento internazionale italiano.
Ma è soprattutto il riconoscimento del ruolo e del peso dell’Italia, Stato fondatore della Ue, seconda manifattura d’Europa, terza economia del Continente. Significa che a differenza di quello che vorrebbero alcuni, in Europa la forza degli Stati membri viene ancora prima di quella delle presunte maggioranze politiche, come è giusto e normale che sia.
Un risultato che credo debba inorgoglire tutta la Nazione, non solo i partiti della maggioranza. Ed è la ragione per cui mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato, così importante per la nostra Nazione, possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi, per consentire alla Commissione, in un momento così delicato, di essere pienamente funzionante dal primo dicembre. Non mancheranno le occasioni per dividerci nel corso di questa legislatura europea su tanti temi su cui le diverse forze politiche hanno opinioni spesso radicalmente diverse, ma di fronte all’affermazione dell’interesse nazionale credo che abbiamo il dovere di essere uniti.
È quello che noi abbiamo fatto nella scorsa legislatura all’atto della nomina di Paolo Gentiloni, quando proprio Raffaele Fitto – in rappresentanza di Fratelli d’Italia – si espresse a favore del candidato italiano e conseguentemente il gruppo di ECR votò in suo favore, e addirittura il Presidente Silvio Berlusconi chiese di partecipare ai lavori di una commissione che non era la sua, per poter prendere la parola e intervenire a sostegno di Paolo Gentiloni.
Ci sono momenti in cui l’interesse nazionale deve prevalere su quello di parte e mi auguro sinceramente che questo momento sia uno di quelli, senza distinguo e senza tentennamenti.
Anche perché, e lo voglio dire anche in questo caso senza polemica – sgomberando però il campo da alcune valutazioni a mio avviso poco corrette e sicuramente ingenerose – quelle attribuite a Raffaele Fitto sono deleghe di primissimo ordine.
La delega sulla Coesione vale nel complesso circa 378 miliardi (di cui circa 43 per l’Italia), su un bilancio complessivo di 1200, solo per il ciclo 2021-2027. Senza contare il futuro ciclo di programmazione (al momento non quantificabile ma presumibilmente di portata simile) che sempre la prossima Commissione sarà chiamata a definire insieme con altri Stati membri. Per una Nazione come l’Italia, e specialmente per il Mezzogiorno, si tratta di un interesse nazionale primario.
A questa delega si aggiunge anche quella al PNRR, che vale ulteriori 600 miliardi di euro circa. E questo rappresenta una garanzia per tutti, perché grazie all’ottimo lavoro svolto in questi due anni dallo stesso Fitto, l’Italia è oggi la Nazione più avanti di tutte nella realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonostante abbia anche il piano più corposo.
La delega del PNRR, secondo le indicazioni della Presidente, dovrà essere esercitata congiuntamente con il Commissario Dombrovskis, e qualcuno ha letto in questo affiancamento una sorta di “ipoteca rigorista”, mentre io credo che questa stretta collaborazione di carattere paritario rappresenti piuttosto l’opportunità per il commissario italiano di far valere le ragioni di una necessaria, maggiore flessibilità, sugli investimenti. Una posizione storicamente italiana che ha trovato soltanto un primo, parziale, accoglimento nella riforma del Patto di stabilità appena entrata in vigore.
Si tratta di un ruolo che diverrà ancora più importante dopo il giugno 2026, quando proprio le nuove regole della Governance richiederanno a ogni governo di pianificare investimenti ulteriori rispetto a quelli che si concluderanno con il Pnrr, sempre che l’Unione Europea non decida di derogare la scadenza del Next Generation EU, come già alcune nazioni stanno chiedendo.
Inoltre, come specificato nella lettera di incarico della Presidente Von der Leyen, rientreranno nell’area di competenza, o meglio dire di coordinamento, di Fitto, materie di importanza decisiva e di interesse strategico per l’Europa e per l’Italia: agricoltura, i trasporti, il turismo, la pesca e l’economia del mare.
Deleghe strategiche, per l’Italia e per l’Europa, affidate a Commissari che dovranno fare riferimento al Vicepresidente esecutivo e che saranno cruciali per ritrovare equilibrio in alcune scelte europee degli ultimi anni, che – come sappiamo – hanno finito col penalizzare fortemente alcuni di questi settori produttivi.
Onorevoli Senatori, le recenti elezioni europee hanno a mio avviso segnato un punto di non ritorno, e ci hanno dato un’indicazione chiara da seguire. L’Europa di domani non può essere più uguale a quella di ieri e di oggi. Deve cambiare, ripensare completamente le sue priorità, il suo approccio, la sua postura. Riscoprire, cioè, il suo ruolo nella storia, particolarmente in questo tempo storico così complesso.
La domanda che dobbiamo porci è: quale futuro intendiamo costruire per l’Europa? Chiaramente non mi riferisco solo all’Europa come Istituzione, ma all’Europa come comunità politica e come attore, autorevole e imprescindibile sulla scena globale.
Siamo di fronte a una fase della geopolitica completamente nuova, sempre più animata da sfide interconnesse tra loro e che principalmente ci dice una cosa: non esistono più blocchi omogenei, e l’interdipendenza dei nostri destini è un fatto. Così come è un fatto che l’ordine al quale eravamo abituati non è più scontato, la centralità del nostro Continente non è più scontata.
Il rapporto Letta sul mercato interno e, ancor più, il rapporto Draghi sulla competitività europea, hanno fotografato con chiarezza i numeri e le ragioni della nostra perdita di ruolo negli ultimi decenni.
Entrambi i rapporti – e non sono stilati da due persone che il nostro spesso semplicistico dibattito definirebbe “europeiste” – ammettono in sostanza che il mondo nel quale troppo a lungo ci siamo crogiolati è finito, e che dunque non possiamo sfuggire all’occasione storica che questa nuova legislatura europea ci offre: scegliere finalmente, e con coraggio, che cosa vogliamo essere e dove vogliamo andare. Possiamo, cioè, scegliere di continuare ad essere ciò che siamo stati finora, ovvero un gigante burocratico che appesantisce cittadini e imprese con una selva di regole, molte delle quali senza senso e autolesioniste. Oppure possiamo invertire radicalmente questa tendenza, concentrandoci sulla visione e sugli strumenti necessari a realizzare quella visione.
È quello che i cittadini ci hanno chiesto con il loro voto, e fedeli come siamo alla sovranità popolare intendiamo dare seguito a questa indicazione.
Ecco lo spirito con il quale il Governo Italiano intende affrontare la legislatura europea che si è appena aperta.
Nel Consiglio europeo di giugno, il primo di questo nuovo corso, abbiamo adottato una nuova Agenda strategica 2024-2029, cioè la bussola che orienterà il percorso comune nei prossimi anni.
Nel documento approvato l’Italia ha chiesto e ottenuto che venissero riaffermati due principi – quello di sussidiarietà e quello di proporzionalità – che sono sanciti dai Trattati e che consideriamo centrali nell’Europa che abbiamo in mente.
Parlo di un’Europa che si occupi delle grandi materie di interesse comune, materie che richiedono di unire gli sforzi e di mettere a sistema il contributo di tutti, e che sappia attribuire la giusta importanza alle specificità nazionali nelle materie dove gli Stati nazionali sono in grado di fare meglio.
L’Agenda strategica indica chiaramente anche la necessità di dotarsi, quanto prima, delle risorse e degli strumenti comuni adeguati all’altezza delle ambizioni che ci poniamo. Lavoreremo perché questa indicazione non rimanga lettera morta, perché nessuno Stato Membro – anche il più solido dal punto di vista economico e fiscale – può sostenere da solo gli investimenti necessari per far fronte alle sfide che stiamo affrontando, dal rilancio della competitività del sistema produttivo e industriale europeo alla doppia transizione ambientale e digitale, dalla politica di difesa e sicurezza al governo dei flussi migratori.
Il Consiglio europeo tornerà ad occuparsi di come rafforzare la competitività europea, e l’Italia ha una posizione molto chiara su questa materia. Non intendo dilungarmi su questo, ma credo sia opportuno ribadire alcuni punti.
L’approccio ideologico che ha accompagnato la nascita e ha sostenuto finora lo sviluppo del Green Deal europeo ha creato effetti disastrosi. È una posizione che noi abbiamo sostenuto fin dall’inizio, spesso in splendida solitudine, e che oggi, finalmente, è diventata invece patrimonio comune. Perché non è vero che per difendere l’ambiente e la natura l’unica strada percorribile sia quella tracciata da una minoranza palesemente ideologizzata.
Anche i più convinti e integralisti sostenitori di questo approccio si sono resi conto che non ha alcun senso distruggere migliaia di posti di lavoro, smantellare interi segmenti industriali che producono ricchezza e occupazione e condannarsi a nuove dipendenze strategiche, per perseguire obiettivi impossibili da raggiungere. Come ho detto mille volte, inseguire la decarbonizzazione al prezzo della deindustrializzazione è, semplicemente, un suicidio. Non c’è nulla di verde in un deserto, e nessuna transizione verde, alla quale guardiamo con favore, è possibile in una economia in ginocchio.
L’addio al motore endotermico entro il 2035, cioè in poco più di un decennio, è uno degli esempi più evidenti di questo approccio sbagliato. Si è scelta la conversione forzata ad una sola tecnologia, l’elettrico, di cui però noi non deteniamo le materie prime, non controlliamo le catene del valore, che ha una domanda relativamente bassa e prezzi proibitivi per gran parte dei nostri concittadini. Insomma, una follia per la quale le nostre economie stanno pagando pesanti conseguenze, in termini di ricchezza, occupazione, forza produttiva e, appunto, competitività.
Lo stiamo vedendo in Italia, ma anche in quelle economie considerate per antonomasia talmente solide da resistere ad ogni evoluzione.
Per queste ragioni non ci siamo affatto stupiti della richiesta portata avanti dalla principale associazione che riunisce i produttori del settore automobilistico di anticipare al 2025 la revisione degli obiettivi legati allo stop al motore endotermico. Non poteva essere una sorpresa per chi come noi fin dal primo giorno ha lavorato per rendere gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti compatibili con la sostenibilità economica delle nostre filiere.
Si deve avere il coraggio di riaprire la partita, e di perseguire, al contempo, la strada della neutralità tecnologica, sostenendo anche quelle tecnologie e quelle filiere – come i biocarburanti – nelle quali l’Italia e l’Europa possono giocare un ruolo da protagonisti.
Allo stesso modo, però, è necessario porsi il tema di come finanziare gli investimenti verso un automotive più pulito, di come sostenere l’innovazione, di come garantire una sempre maggiore autonomia strategica, costruendo catene del valore europee per non consegnarci a nuove, pericolose, dipendenze.
Proprio in questa direzione va il non-paper presentato dal Ministro Urso ai colleghi degli altri ventisei Stati membri che servirà come base di discussione per ampliare il consenso intorno alla nostra posizione, ispirata al buon senso e al pragmatismo, senza alcuno spazio per gli approcci ideologici.
E ampliando lo sguardo ad altri settori produttivi, non posso che essere d’accordo con Mario Draghi quando scrive, nel suo rapporto, che gli ambiziosi obiettivi ambientali che ci siamo posti devono essere accompagnati da maggiori risorse pubbliche e private, da investimenti adeguati e da un piano coerente per raggiungerli, altrimenti la transizione energetica ed ambientale andrà a scapito della competitività e della crescita. Sono temi che, me ne darete atto, più volte ho toccato in precedenti occasioni e che ci devono spingere ad una riflessione approfondita quanto rapida.
Questo vuol dire aprire il dibattito soprattutto sugli strumenti finanziari necessari a sostenere questo percorso. Un dibattito nel quale dovremo essere pronti a verificare la possibilità di nuovi strumenti di debito comune, così come a lavorare per riuscire finalmente a mobilitare adeguatamente il capitale privato. Completare l’Unione dei mercati dei capitali consentirebbe, infatti, ai risparmi europei di diventare investimenti europei.
Sappiamo cosa dobbiamo fare, insomma, ma adesso serve farlo. Servono azioni politiche concrete che trasformino le nostre priorità in una ambiziosa strategia industriale europea, per garantire la crescita delle aziende, la protezione dell’industria, la semplificazione del quadro normativo.
(Estratto dalle Comunicazioni di Meloni in Senato; qui il testo integrale)