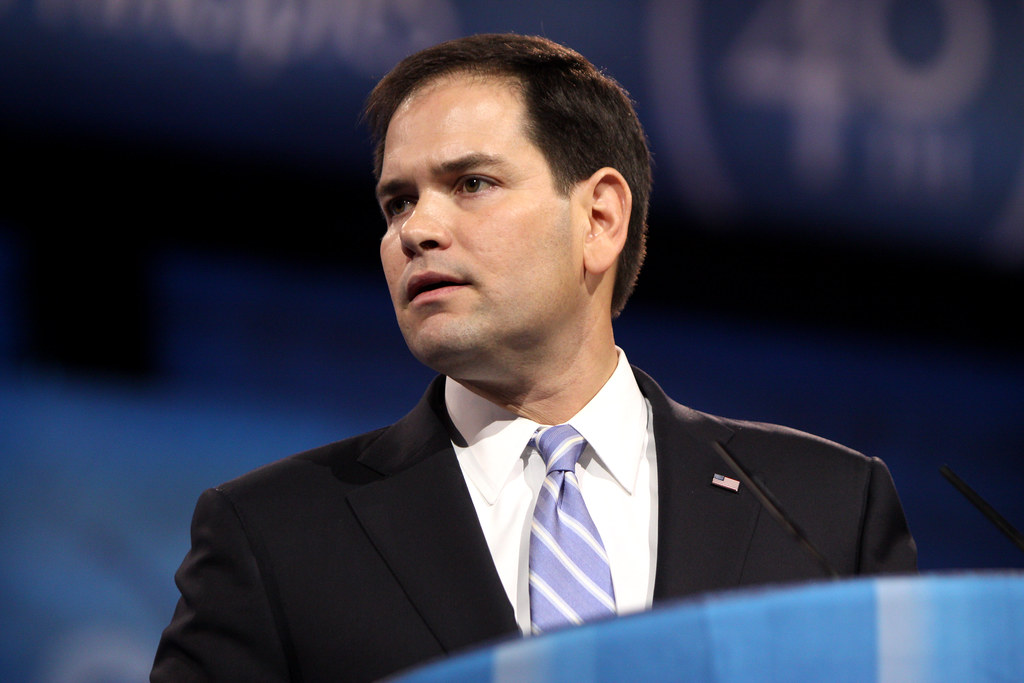L’Italia ha un pavimento di odio politico che viene da lontano e che è stato nel tempo alimentato. La stessa politica democratica se ne è ricorrentemente dimenticata esasperando toni e argomenti per sostenere pur legittime convinzioni. In questo modo, senza volerlo, ha offerto il clima, il contesto, per azioni violente su cose e persone.
Il risultato è che le manifestazioni sono agevolmente infiltrate da gruppi intenzionati allo scontro con le forze dell’ordine o alla distruzione di luoghi simbolici. Così come le università hanno perso la caratteristica di luoghi aperti alla pluralità delle opinioni e sono spesso sotto il controllo di minoranze violente e intolleranti. Con qualche complicità tra i docenti. È difficile immaginare un luogo universitario in cui si possa svolgere quel dialogo, quasi socratico, tra Charlie Kirk e giovani studenti di opposta opinione di cui abbiamo letto le registrazioni pubblicate dopo la morte.
Lo stesso terrorismo, sconfitto nei termini conosciuti, potrebbe oggi ripresentarsi attraverso la saldatura tra antagonisti di casa nostra e islamisti radicali. La risposta a questa deriva dovrebbe essere non solo istituzionale. Non possiamo abituarci alla inagibilità delle università o alla periodica occupazione di stazioni ferroviarie e autostrade.
Occorre tuttavia anche e soprattutto una risposta politica e culturale. Le organizzazioni politiche dovrebbero concorrere alla educazione collettiva dichiarando che la loro dialettica, anche aspra, si colloca pur sempre in una cornice di valori condivisi. E dissociarsi da ogni forma di intolleranza. Non meno utile potrebbe essere il ruolo di quei corpi sociali che si muovono nella dimensione prepolitica. Come il laicato cattolico. Questi potrebbero impegnarsi, in questa stagione difficile, a veicolare messaggi di rispetto, di tolleranza, di perdono e, perchè no, di amore. In fondo, abbiamo questi anticorpi e li dobbiamo usare. Ora.